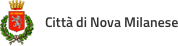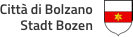Leone Fiorentino
Nato il 7 settembre 1923 a Roma
Intervista del 6/9/2000 a Roma, realizzata da Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari
TDL: n. 49 – durata: 1° parte 64’ – 2° parte 29’
Arresto: 3 dicembre 1943 a Roma
Carcerazione: carcere di Regina Coeli a Roma; carcere giudiziario a Castelfranco (MO)
Deportazione: Fossoli (Carpi, provincia di Modena); Birkenau (Auschwitz II), matricola n. A-5399; Stutthof, e in vari suoi sottocampi; Natzweiler; Hayingen (sottocampo di Natzweiler); Dachau, matricola n. 150.319
Liberazione: fuggì verso la fine dell’aprile 1945 dalla Marcia della morte cominciata a Dachau
Nota sulla trascrizione della testimonianza:
La trascrizione è integrale e fedele all’originale. Gli interventi del compilatore sono segnalati da parentesi quadre. Per espressioni di difficile interpretazione si segnala l’omissione con la dicitura […]. Alcune ripetizioni ed elementi intercalari in parte non sono stati riportati.
PRIMA PARTE
Io mi chiamo Fiorentino Leone, sono nato il 7 settembre 1923 a Roma.
Voglio dire che le mie vicissitudini sono iniziate con la emanazione delle leggi razziali nel 1938. Migliaia di cittadini italiani di religione ebraica furono messi in condizioni di non poter più lavorare, di non poter più esercitare la propria attività, e anche io, al pari dei miei corregionali della mia stessa età, o giù di lì, fui espulso da tutte le scuole del regno. A mio padre, per esempio, che era un modesto venditore ambulante che operava nel mercato di Piazza Vittorio Emanuele all’Esquilino, fu tolta, fu ritirata d’autorità la licenza di vendita, e dovette arrabattarsi, dovette incominciare a fare degli umilissimi lavori per potere mantenere la famiglia. Io cominciai a fare il ragazzetto di bottega. Più tardi, alcuni anni dopo, fui precettato ai lavori obbligatori lungo le rive del Tevere, lavori di sterro primariamente. Ma istintivamente questo lavoro non lo accettavo, proprio perché era imposto, e anche perché la paga oraria [era] di una lira e ottanta centesimi, in virtù del fatto che ero un minore della maggiore età, mentre gli altri operai in genere lavorando dieci ore al giorno – perché la giornata lavorativa era stabilita in dieci ore – guadagnavano tre lire e sessanta centesimi. Questa disparità mi inaspriva maggiormente, non tanto nei confronti della ditta per la quale ero obbligato a lavorare, ma mal sopportavo la imposizione da parte del regime fascista. Non che sapessi esattamente quello che facevo, ma era un modo mio di agire, come dire, spontaneo. Questo mio atteggiamento nei confronti della ditta appaltatrice e anche del regime mi costava notti da trascorrere in guardina. L’indomani mattina venivo accompagnato da un agente di pubblica sicurezza sul posto di lavoro e poi finivo per essere piantonato per tutto il giorno lavorativo.
In seguito fui arrestato e condannato a sei mesi di carcere, che scontai interamente nel carcere di Frosinone ove ero stato trasferito subito dopo la condanna. Gli articoli del Codice penale che mi erano stati affibbiati erano tre, e ognuno di questi articoli mi comportava una pena da un minimo di sei mesi a tre anni di reclusione l’uno. L’imputazione era questa: vendita abusiva di generi di vestiario, che erano allora tesserati, così come erano tesserati gli articoli che riguardavano i generi alimentari, e per propaganda antifascista. A Frosinone fui costretto a lavorare nel locale fornace, che era situata ai piedi della cittadina, al pari di altri detenuti che con me erano arrivati da Roma a Frosinone, in sostituzione di tutti quegli operai della ditta della fornace che erano stati richiamati alle armi. Qui…
D: Scusa Leone, quando questo? In che anni?
R: Nel 1943. Nel 1943. Quindi la paga, così come era stato stabilito attraverso un accordo tra la direzione del carcere e la direzione della fornace, riconosceva per dieci ore lavorative a ogni detenuto che prestava la sua opera nella fornace una paga di 15 lire il giorno. Però di queste 15 lire la direzione del carcere se ne appropriava letteralmente, sottraendole a quanti effettivamente spettavano. E venivano riconosciute ad ogni detenuto soltanto le 5 lire rimanenti. Era un grosso vantaggio economico, sia per la direzione della fornace che risparmiava un sacco di soldi perché la giornata lavorativa di un operaio era di 36 lire per dieci ore lavorative, e le altre 10 lire venivano sottratte illegalmente dalla Direzione che se le pigliava totalmente. E questo sistema sempre istintivamente non lo accettavo, e quindi lavoravo anche qui molto molto svogliatamente, creando non pochi guai. Raccoglievo i blocchi di fango semisolido che uscivano da una taglierina… da una impastatrice, che dall’alto, attraverso un canale di legno, arrivava davanti a un operaio, che con una taglierina a compasso, con molta maestria bisogna dire la verità, tagliava in tre pezzi. Bisognava raccogliere questi tre pezzi così tagliati e metterli su un carrello che poi si spingeva fino a un capannone dove si doveva mettere ad essiccare prima che fossero messi nella fornace. Bene, da parte mia questi tre pezzi immediatamente ritornavano ad essere unici, un pezzo unico, e questo, anche qui, mi costava decurtazioni di paga e nello stesso tempo camere di punizione. Finalmente la direzione del carcere della fornace si decise a liberarsi di me, e quindi incominciai a trascorrere le mie giornate in camerata insieme ad altri detenuti. Ogni camerata aveva grosso modo dai venti ai ventidue ai ventitré prigionieri.
Cade il fascismo il 25 luglio, le carceri si stanno vuotando. Credo di poter essere liberato, ma non c’è una disposizione nei miei confronti, perché quanto serve alla direzione per poter mandarmi via è qualcosa che deve arrivare dalla centrale di polizia di Roma, che allora era a Piazza del Collegio Romano. Ma questo documento non poteva certo giungere perché attraverso i bombardamenti le linee di comunicazione erano totalmente rovinate.
Il 25 luglio cade appunto il fascismo. Si fanno congetture tra detenuti, si pensa che la guerra ormai sia finita e che si comincerà a vivere in maniera diversa. Ma non è così. I bombardamenti continuano e comunque, per non sottostare al pericolo incombente, poiché i bombardamenti avvenivano quasi tutte le notti in maniera massiccia, alcuni detenuti – intanto erano passate delle settimane, erano passati dei mesi – alcuni detenuti presero contatti con la direzione del carcere perché facesse scendere i detenuti durante le incursioni aeree giù in basso. Ma l’ottusità del direttore non lo permise e si decise di tentare una evasione in massa, quando uno dei continui bombardamenti più forte degli altri in questo caso lo avesse permesso. Capita questo bombardamento, e i detenuti scagliano le brande sulle serrature delle porte, e la nostra porta, quella della nostra camerata, è la prima a saltare. A un malcapitato secondino gli prendono le chiavi, qualcuno si incarica di aprire tutte le porte del piano e si scende durante il bombardamento intenso le scale che portano giù in basso, come bestie feroci terrorizzate. Ma un comando di carabinieri che facevano parte della caserma dirimpettaia – diciamo – del carcere, dopo aver sparato alcuni colpi in aria per intimorirci, ci sospinse ancora sul piano da dove eravamo discesi. E quindi trascorremmo tutta la notte con la faccia rivolta verso il muro e le braccia alzate, i moschetti con la baionetta innestata, puntata alla schiena. L’indomani mattina veniamo trasferiti giù in basso nelle celle di punizione, e siamo in molti ad attendere l’interrogatorio di ognuno perché si potesse valutare la colpevolezza di ognuno di noi. Ma intanto un reparto di soldati tedeschi, al comando di un loro ufficiale e da un tenente dell’esercito italiano che funge da interprete, invade tutto il piano terra. Un breve discorso dell’ufficiale tedesco e si riesce a capire che – perché tradotto appunto dall’ufficiale italiano – che il comando tedesco di stanza a Frosinone non vuole assumersi la responsabilità di tenere esposti ai bombardamenti gli unici civili quali i prigionieri sono, e quindi mette in libertà tutti coloro che hanno una pena da scontare non superiore ai cinque anni. Gli altri saranno trasferiti in altre carceri. Vanno via i tedeschi, e quelli che hanno maggiori anni da scontare rinchiudono gli esterrefatti secondini nelle celle di punizione e si danno alla fuga.
Esco dal carcere insieme ad alcuni altri compagni di sventura e ci dicono… riusciamo a sapere che alla stazione dovrebbe transitare una tradotta militare che dovrebbe andare verso Roma. Dopo molte ore arriva carica di soldati stracciati, affaticati, moralmente soprattutto. Dicono che per loro ormai la guerra è finita, e nella maggior parte dei casi sono stati abbandonati dai loro comandanti e quindi ora sono diretti verso le loro case. Dopo molte ore di viaggio si arriva a Roma. Esco, prendo un mezzo pubblico che va verso il quartiere dove abito, il quartiere Testaccio, ma non so rendermi conto perché piccoli e grossi mezzi militari tedeschi carichi di soldati armati di tutto punto transitano per Roma. Roma che era stata dichiarata mesi addietro Città aperta, quindi mi dicevo che doveva sicuramente essere accaduto qualcosa perché tutto si fosse in una qualche misura rivoltato. Alla stazione, o meglio, alla Piramide, in prossimità appunto di Porta San Paolo, c’erano i segni di violenti combattimenti e quindi una desolazione. Scendo dal mezzo appunto e poiché abitavo poco distante da lì, a piedi raggiungo la mia abitazione. I miei genitori… Quindi, una volta arrivato a casa, i miei genitori mi dicono delle tremende giornate trascorse, la combattività dei granatieri italiani e popolani romani malissimo armati contro il potente contingente corazzato tedesco che riesce a penetrare in città e a presidiarla. In un secondo tempo io seppi che in quei giorni di battaglia i morti furono 146, di cui 27 donne. Devo presentarmi alla centrale di polizia a piazza del Collegio Romano per convalidare la mia uscita dal carcere. Però la polizia non si sapeva bene da che parte stesse; le bande fasciste, sotto il controllo relativo dei tedeschi, si erano formate di nuovo e comunque i tedeschi, benché glielo avessero permesso di ricostituirsi, non si fidavano di loro, e perciò decisi di non presentarmi. Però sapevo di essere ricercato e quindi, malgrado tutti gli accorgimenti, fui catturato dalla polizia fascista il 3 dicembre 1943.
D: Dove? A casa tua?
R: A casa mia. Ma la casa era disabitata, perché le mie sorelle erano presso amici di famiglia e altrettanti amici di famiglia, che abitavano accanto al nostro appartamento rimasto vuoto, erano… ospitavano me e ospitavano mio padre e mia madre. Quindi fu un caso… C’era il coprifuoco, era tardi, e quindi dissi a mia madre: “Bene, se devo andare in quel posto, presso altri amici, per ripararmi dalle insidie, voglio andare a prendere qualche libro per leggere.” Infatti entro dentro casa, ma non appena entro sento lo squillo del telefono e penso che sia mio padre che vuole mettermi fretta. Invece erano tre agenti di pubblica sicurezza in borghese, che dopo avermi domandato dove fossero i miei, dissi che non potevo saperlo poiché da pochissimo ero uscito dal carcere e quindi non potevo dare altre spiegazioni. Ma perché vennero a ritirarmi… ad arrestarmi in quel frangente a casa? Perché avevo girato tutto il giorno, poiché mi sentivo seguito, per allontanare da me i due agenti di pubblica sicurezza in borghese che mi seguivano. Quindi prendo il tram, faccio poche fermate, scendo a Porta Castello perché stavo lì a Viale Giulio Cesare; a Porta Castello mi inoltro in quelle viuzze scure e strette, e lì giro attorno per molte ore, sperando di avere fatto perdere le tracce a questi poliziotti. Quindi molto tardi arrivo a casa, tanto è vero che mi trovo all’altezza di Ponte Vittorio – perché Borgo Pio si trova proprio sul Lungotevere all’altezza di Ponte Vittorio – attraverso il ponte, e qui mi pare che sono un po’… come dire, non più seguo un certo discorso: attraverso il ponte, prendo a Corso Vittorio il primo mezzo, il primo autobus che capita, e che va verso Piazza Venezia. Però mi pento. Mi pento perché dico, a Piazza Venezia? Piazza Venezia è piena di fascisti e di polizia! Ma ancor prima non posso scendere perché all’altezza della Cancelleria c’è il Palazzo Braschi dove c’è la banda Pollastrini, Bardi e Pollastrini. E quindi, una volta a Piazza Venezia, decido di proseguire e scendo a Via Nazionale – a metà di Via Nazionale – percorro poi tutta via dei Serpenti, arrivo a Via Cavour. Là prendo un’altra circolare che mi porta al Colosseo, e di lì la circolare rossa che mi porta a Testaccio. Quindi io ho capovolto la situazione. Vengo arrestato a casa perché quei due che mi avevano seguito mi avevano ben individuato e quindi avevano potuto comunicare ai loro colleghi che mi trovavo in quella situazione.
Dopo moltissime settimane nel carcere di Regina Coeli, e altrettante settimane nel penitenziario di Castelfranco di Modena, [arriva] quindi il trasporto su pullman nel campo di Fossoli, vicino Carpi.
D: Scusa Leone, quando ti hanno arrestato a casa tua, ti hanno portato subito in quale carcere?
R: Non in carcere, in camera di sicurezza.
D: Dove?
R: Nella camera di sicurezza del commissariato di Testaccio.
D: E ti hanno rivolto qualche imputazione?
R: No.
D: Ti hanno interrogato?
R: No.
D: Solo ti hanno arrestato?
R: Solo.
D: Lì sei rimasto quanto tempo?
R: Tutta la notte. L’indomani mattina fui… con un furgone carcerario fui trasferito nel carcere di Regina Coeli.
D: Sei stato interrogato lì?
R: No.
D: Ti hanno messo in cella isolato o con altri?
R: Con altri delinquenti comuni.
D: Questo è accaduto quando? Te lo ricordi?
R: Eh sì. Dunque… subito dopo il 3 dicembre del ‘43.
D: E poi tu dicevi che ti hanno trasferito ancora?
R: Sì.
D: Da Regina Coeli…
R: Da Regina Coeli nel penitenziario – non direttamente però – dal penitenziario di Castelfranco di Modena. Da lì poi…
D: Non direttamente in che senso?
R: Perché tentarono, i militi della Decima Mas, tentarono di… – me e altri due prigionieri che si trovavano, civili naturalmente, che si trovavano sul pulmino – di farci pernottare, perché anche loro volevano pernottare, nel carcere di Firenze. Però il direttore si impose, disse che non c’erano documenti necessari perché noi potessimo… essere, si fa per dire, ricoverati… fossimo rinchiusi lì. E quindi a malincuore questi militi ripartirono. Cioè, si ripartì tutti quanti verso Bologna, perché si percorse tutta la montagna pistoiese fino a Torretta Terme, e poi ancora giù fino a Bologna. A Bologna invece non ci fermammo, ma il pulmino si fermò a Castelfranco di Modena.
D: Lì sei rimasto anche lì nelle carceri a Castelfranco?
R: Sì.
D: Una notte o più giorni?
R: Più giorni.
D: Sei stato interrogato?
R: No. No. Quindi ci fu il caso che di lì a pochi giorni un altro gruppo abbastanza folto di ebrei romani – donne, uomini, bambini – giungesse appunto da Roma. Dopo pochi giorni tutti quanti – fui aggregato a quel gruppo – e tutti quanti fummo portati nel campo di Fossoli, vicino Carpi, in provincia di Modena.
D: Quando sei entrato nel campo di Fossoli ti hanno immatricolato?
R: No. No, assolutamente no.
D: E in che blocco ti hanno messo?
R: In che blocco io sinceramente non te lo posso dire. Comunque noi uomini, di quel gruppo, fummo tutti messi in una baracca, in un blocco, che era semivuota, poiché alcuni giorni prima c’erano state delle partenze, e quindi noi eravamo andati a rimpiazzare, si fa per dire, quelli che erano partiti.
D: Cos’era… dicembre, quando sei arrivato a Fossoli?
R: No, dopo, perché io ho fatto molti mesi di carcere. Tra carcere Regina Coeli, tra Castelfranco di Modena, erano passati dei mesi.
D: Sei arrivato quindi a Fossoli quando più o meno?
R: Verso, grossomodo… verso la prima quindicina di maggio, se non vado errato. Sì.
D: Nel ‘44?
R: Nel ‘44 certo, nel ‘44. Ormai il ‘43 era passato.
D: E lì a Fossoli sei rimasto quanto?
R: A Fossoli pochissimo. Pochissimi giorni, e quindi la partenza su carri bestiame per la Germania, per Auschwitz, Auschwitz Birkenau. Settanta o ottanta persone di ambo i sessi e senza nessuna distinzione di età per ogni carro. Tra i lamenti dei più deboli, tra i pianti atterriti dei bambini, soprattutto i lamenti strazianti delle donne e anche delle persone anziane. Il viaggio durò sette interminabili giorni. Ricordo questo: quando si arrivò ad Auschwitz – dopo lo sapemmo che si trattava di Auschwitz – mentre si scendeva sotto i colpi di bastone sferrati con forza su ogni dove, una donna mi è sempre rimasta impressa, una donna ancora giovane, in preda sicuramente a una crisi isterica, disse più volte: “Ma non sentite che puzzo di bruciato c’è nell’aria?” Però nessuno gli dette retta. Effettivamente il cielo era cupo, sembrava una cappa di piombo, e il puzzo di bruciato c’era.
D: Scusa Leone, quando tu dici Auschwitz, intendi Auschwitz I o Birkenau?
R: Lo stavo dicendo. Quindi ci trovavamo appunto ad Auschwitz, Birkenau. Auschwitz era una vasta zona di oltre 40 chilometri quadrati, fitta di campi e sottocampi, con altre denominazioni, ma tutti facenti capo a Birkenau, che era il vero centro dello sterminio.
D: Scusami ancora Leone, quando il tuo transport è arrivato a Birkenau, il treno è entrato dentro nel campo o fuori si è fermato? Se ti ricordi.
R: Il treno si è fermato sulla rampa, che era – diciamo, si può dire – dentro questo grande complesso di campi. Lì ci fu la prima selezione, le donne con le donne, gli uomini con gli uomini. Ma soprattutto c’erano le suddivisioni ulteriori che riguardavano grossomodo l’età delle persone e, a detta o a parere, diciamo, dei tedeschi, delle SS, e anche dei capi, che poi erano anch’essi prigionieri, quelli che avevano il bastone in mano come segno di riconoscimento, come segno di potere, e a loro volta comandavano un infinito numero di altri prigionieri vestiti con la casacca e i pantaloni a righe, che si muovevano con sveltezza, quasi correndo, per non subire le sollecitazioni a suon di bastonate di questi che erano considerati i capi. Erano i veri e propri capi, perché poi la organizzazione interna del campo era in mano ai triangoli verdi, che erano delinquenti comuni, e ai triangoli neri, quelli che venivano definiti asociali, ma che poi, nella mentalità tutta teutonica, erano quelli che non avevano diritto di vivere, ma comunque erano stati delegati a comandare, erano stati delegati a sancire condanne anche di morte senza dovere poi risponderne ad alcuno.
D: Tu arrivi a Birkenau che è quando?
R: Attorno alla prima metà di maggio. Infatti, il numero che ho corrisponde grossomodo a quella data. Dopo un brevissimo periodo di quarantena…
D: Dopo la selezione sulla rampa cosa è successo?
R: È successo che fummo spogliati completamente di tutti i nostri vestiti, fummo rapati, tosati sulla testa, sotto le ascelle, attorno il pene, e quindi, dopo una doccia freddissima – si diceva di disinfestazione [disinfezione, ndr] – il vestito a righe di tela, casacca e pantaloni e un berretto della stessa stoffa a forma di basco. Ai piedi soltanto zoccoli di legno.
Fui assegnato al commando, al Wasserkommando, al commando acqua, uno dei Kommandos più cattivi, così si diceva in campo, poiché la mortalità dei suoi componenti era altissima. Si dovevano percorrere circa 9 chilometri di strada fangosa, per arrivare poi alla zona paludosa, dove dovevamo entrare nell’acqua stagnante per tagliare dell’erba acquatica. Un lavoro inutile, un lavoro che non serviva a niente, ma che serviva, nelle intenzioni delle SS, a far sì che si morisse di fatica, se non direttamente con un colpo di pistola, o magari attraverso una delle selezioni. Le selezioni avvenivano all’improvviso. Si doveva passare tutti nudi davanti un ufficiale tedesco che non sempre era medico, ma indossava un camice bianco, e senza tenere conto delle effettive condizioni del prigioniero che gli passava davanti, ne decretava la morte: o vai a destra o vai a sinistra. Molto spesso capitava di dover andare a morire anche [a] quei prigionieri che ancora potevano essere, diciamo così, valide forze, potevano ancora essere… usati come manovali, come uomini di fatica, come uomini…
D: L’immatricolazione, come ve l’hanno fatta? Come te l’hanno fatta?
R: L’immatricolazione avvenne prima, subito dopo l’arrivo ad Auschwitz, o meglio, a Birkenau. Subito dopo, diciamo, la vestizione. Il tatuaggio fu fatto con un ago bagnato di un certo liquido, da gente, prigionieri naturalmente, che si ingegnavano di scrivere nel migliore dei modi, facendo una serie di punture. Comunque, salvo casi eccezionali, non è che questo desse motivo di febbre o altro. E quindi ci fu l’assegnazione al posto di lavoro, al commando di lavoro, e ripeto, io fui assegnato al Wasserkommando che operava nella zona paludosa.
D: Leone, siccome a Birkenau l’immatricolazione avveniva in modo molto particolare rispetto agli altri campi – perché il numero vi veniva anche tatuato, dicevi – com’è che avveniva? Eravate in piedi, tutti in fila?
R: In piedi tutti in fila, chiamati per ordine alfabetico, chiamati per ordine alfabetico. E quindi con questo ago una serie di punture, tanto da disegnare il numero… da trascrivere il numero che si voleva, ma che era seguente al primo e via dicendo.
D: Il tuo numero?
R: Il mio numero è: A 5399.
D: E poi oltre al numero che vi hanno tatuato sul braccio vi hanno dato anche il numero di stoffa?
R: Sì, unitamente ad un numero di stoffa e davanti il numero corrispondente a quello tatuato sul braccio, un triangolo giallo, e così anche un altro secondo talloncino di stoffa, con le stesse caratteristiche, da appiccicare, da cucire sul pantalone sulla gamba sinistra.
D: Il blocco di Birkenau te lo ricordi?
R: Sì, il blocco numero 8. Il blocco numero 8, uno dei peggiori. Io ero un Häftling, un prigioniero che stava all’ultimo gradino della scala sociale del campo, erano quelli che dovevano morire prima, erano quelli che facevano i lavori più bassi, più pesanti. E quindi in questo lavoro, in questo commando, ci ho trascorso oltre sei mesi.
Voglio dire che il campo… nel campo c’era la pulizia massima, ma fuori delle baracche però. Davanti ad ogni baracca, davanti l’entrata di ogni baracca, c’era una grossa aiola ben fiorita, ben tenuta, la Lagerstrasse, la strada in terra battuta che tagliava il campo in senso verticale, e nel suo insieme dava l’aspetto… il tutto aveva l’aspetto di un piccolo paese di campagna pulito ed accogliente. Dentro le baracche, invece, oltre mille uomini, asserragliati dentro le buche dei castelli di legno, in dieci o dodici persone per ogni buca – i posti erano per due praticamente persone – in un groviglio di ossa, di maledizioni, di bestemmie in tutte le lingue, come in una nuova torre di Babele. Si tiravano calci, con quelle poche forze che si avevano, per cercare di sistemare meglio le proprie ossa. E poi c’erano i Mussulman. I Mussulman erano quelli che orinavano dappertutto, soprattutto la notte, bagnando non solo di urina ma anche di liquido diarrotico [per diarroico] i cuscini e dava un odore insopportabile. I ‘mussulmani’, quelli che venivano chiamati Mussulman, non erano altro che povere persone, poveri esseri umani che di umano effettivamente non avevano più niente. Scalzi, imbrattati di sangue, pieni di croste, girovagavano per il campo in cerca impossibile di qualcosa da mettere in bocca. Però bisogna dire che le loro condizioni facevano pensare che avessero perso il senso del ragionamento. Aspettavano così, incoscientemente, la morte.
Si lavorava non certo per produrre. Si lavorava per morire, perché il lavoro che si faceva – sotto le continue bastonature, sotto le continue angherie, le vessazioni e poi il lavoro per se stesso duro così com’era – ci faceva vivere nel terrore continuo di essere ammazzati, o di morire di stenti.
D: Leone, nel Block con te c’erano altri italiani?
R: Nel mio commando c’erano soltanto tre italiani, e guarda caso tutti e tre romani. Nelle baracche vicino c’erano qualche altro italiano, e non a caso, così come facevano del resto tutti: i francesi con i francesi, i milanesi cercavano il compagno milanese perché potesse scambiare, non dico qualche impressione, ma perché potessero magari ricordare quanto era rimasto in loro come ricordo della vita passata.
Comunque, eravamo dei condannati a morte, perché nel momento in cui si metteva il piede dentro il campo si era destinati a morire. Non a caso le SS, quando arrivavano nuovi prigionieri, venivano accolti grossomodo con una frase di questo tipo: “Voi siete in un campo di sterminio” – o meglio, in un campo di concentramento, non parlavano di sterminio – “un campo di concentramento tedesco da dove non si esce se non per il camino.” E questo era tutto.
C’era l’orchestra, che allietava le ore lunghissime dell’appello, sia all’alba, sia alla sera quando si rientrava dai vari posti di lavoro. Chiunque, chiunque avrebbe potuto pensare appunto che si trattasse di un paesino pulito e accogliente. Mentre l’orchestra suonava dolci melodie, fuori del lager passavano colonne interminabili di uomini, di donne e di bambini, che andavano inconsapevolmente a morire in una delle camere a gas. Molto spesso, prima che suonasse la sveglia, quindi prima dell’alba, si era costretti, cinquanta uomini per volta, di uscire completamente nudi dalla baracca e lì sulla neve o nel fango, o nella terra polverosa, ci si doveva distendere per terra, e poi sotto il fioccare delle bastonate, o comunque di altri corpi contundenti, ci si doveva arrotolare prima da una parte, poi dall’altra, quindi tirarsi immediatamente su e poi subito giù di nuovo, e questo per circa mezz’ora o forse di più. Questo era considerato un saggio ginnico, come mezzo di allenamento vero e proprio che ci portasse a riscaldare i muscoli per il lavoro poi che più tardi, poco più tardi, si sarebbe andati a fare. Molto spesso quattro o cinque persone rimanevano sul posto, morte. E non sempre erano i più malati o i più vecchi.
D: Leone, scusa, sempre quell’immagine del paesino lindo e pulito, il Waschraum com’era?
R: Il Waschraum era il blocco dei lavatoi. Ma ancor prima del Waschraum c’era il Block delle latrine. Dunque, lungo tutta la loro lunghezza, c’erano tre muretti di cemento, in senso verticale naturalmente, costellati di fori su cui bisognava… si doveva necessariamente sederci. Ma per pochi istanti soltanto però, perché davanti a ognuno di quelli che ci erano seduti sopra, lunghissime file di prigionieri con i pantaloni per un po’ calati, pronti per essere tirati definitivamente giù, sostavano in attesa. Ma ripeto, quelli che ci stavano seduti sopra a questi fori [rimanevano] solo per pochi istanti, perché venivano strattonati via, venivano malmenati da quelli che ritenevano di essere più in forza, da quelli che erano capi, quelli che erano i sottocapi, quelli che erano i servi dei capi. E poi si passava al Waschraum. Il Waschraum anche aveva tre – sempre in senso verticale – tre canali di cemento dove sgorgavano dai piccoli tubi dell’acqua puzzolente. Là ci si doveva in qualche maniera tentare di bagnarsi, non dico di lavarsi. Ma anche qui si subivano le angherie più feroci, perché c’erano quelli che erano definiti i capi, oppure i Prominenten, quelli che avevano certi incarichi e quindi erano abbastanza floridi, poi avevano la possibilità di organizzarsi, di cambiare facendo magari piccoli favori in cambio di saponette o di asciugamani, o di spazzolini dei denti: questi con tracotanza non volevano nessuno accanto a loro, e picchiavano maledettamente con quanta forza avevano per punire chi magari soltanto casualmente era passato loro accanto.
D: Scusa Leone, il tuo commando di lavoro dicevi era il commando dell’acqua.
R: Il Wasserkommando.
D: Tagliare queste canne di palude…
R: Sì, più che canne erano erbacce, erbe, molto folte, molto…
D: Quante ore voi dovevate lavorare?
R: Noi, salvo la quasi ora di riposo per mangiare quel po’ di zuppa che ci veniva distribuita – fredda oltretutto, perché veniva dal campo – dieci ore, all’incirca. Quindi, si dovevano percorrere i 9 chilometri per arrivare alla zona paludosa. Si lavorava pressoché nudi, perché altrimenti si sarebbe costretti poi a rimettersi la divisa bagnata. Quindi c’era quell’ora di riposo, si fa per dire, per mangiare quel po’ di brodaglia. Era circa un litro di acqua e cavoli, più acqua che cavoli in verità… Perché anche lì c’era un’angheria, perché quando ci si metteva in fila per passare davanti al Vorarbeiter – che era quello che col mestolo in mano travasava la zuppa in quella specie di scodella di metallo che ci portavamo sempre appresso – bene: non girava, non mescolava quanto c’era dentro, e quindi le foglie di cavolo, i crauti andavano a fondo, andavano a fondo e gli altri pigliavano soltanto un litraccio di acqua puzzolente. Ma quello che rimaneva a fondo serviva al Vorarbeiter e al sottocapo, di organizzarsi ancor meglio facendo… ricevendo poi dei favori più grandi, certo.
D: E non c’era giorno di sosta, diciamo la domenica?
R: La domenica. In genere la domenica non si lavorava, però si era obbligati. D’altra parte era anche necessario rivolgersi al Rasier della baracca. I Rasier erano piccoli capetti che avevano avuto la mansione di possedere un rasoio e un pennello da barba, e quindi radevano tutti coloro che dovevano necessariamente radersi, perché sarebbe stato oltremodo pericoloso non radersi, o comunque non farsi radere. Però per ingraziarseli, questi Rasier, bisognava portare loro una mezza razione di pane, o magari quel pezzettino di margarina che una volta ogni tanto ci passavano, allora uno la teneva da parte per poi darla a questo Rasier. E questi, senza scrupoli, si atteggiavano a capi, e quindi facevano il bello e brutto tempo. Se quanto il prigioniero, una volta davanti a lui, mostrava soltanto la mezza razione di pane, e non era gradita da lui, erano botte, oppure, con cattiveria, il sapone che era rimasto sulla lama del rasoio, te lo pulivano addosso alla casacca. Se reagivi prendevi botte da lui: non solo, ma diventavi il peggior nemico di tutti quei prigionieri che ti venivano appresso, che stavano appresso a te, perché dicevano che tu con quell’atteggiamento avevi creato che il Rasier si innervosisse e se la prendesse quindi con tutti. Quindi i tuoi stessi compagni erano diventati nemici.
D: E tu sei restato in questo commando di lavoro sei mesi?
R: Sei mesi. Poi fui trasferito con tutto il commando di lavoro nel campo di Stutthof, vicino Danzica. Perché il fatto fu piuttosto, come dire… piuttosto importante. Nello stesso tempo però un fatto eccezionale: perché il commando di lavoro che operava nel crematorio, che era nelle immediate vicinanze della zona paludosa, riuscì a far saltare e a distruggere il crematorio stesso. Ma questa fu una operazione andata a male, perché era stata organizzata in un’altra maniera, e quei prigionieri, quei componenti di quel commando non furono… non potettero essere avvisati, perché avrebbero dovuto soprassedere di fare quell’azione. Comunque, oltre cento di quel commando furono trucidati dai tedeschi, e noi del Wasserkommando fummo – nella tarda serata, nel tardo pomeriggio, poi venne la sera – dovemmo raccoglierli tutti e tirarli all’asciutto, tirandoli fuori dal fango dove erano mezzo affossati. Quindi arrivammo in campo, e un ufficiale tedesco ci parlò a lungo. Eravamo l’ultimo commando di lavoro che stava rientrando, perché da ore tutti gli altri comandi, oltre ventimila persone, erano in attesa che il quadro completo dei prigionieri dei comandi di lavoro fosse presente nel piazzale principale. Riuscimmo a capire soltanto che non avremmo dovuto fare parola di quanto avevamo visto e di quanto eravamo stati protagonisti, pena la eliminazione fisica di tutto il commando di lavoro. Quindi ci collocammo nel nostro… nell’assetto generale, quello che era il posto del Wasserkommando, e quando finì l’appello si entrò nella baracca. Ma poi non andammo più al lavoro perché fummo reclusi letteralmente per alcuni giorni, diciamo lontano da tutti, e poi aggregati a un Transport che ci condusse poi a Stutthof.
SECONDA PARTE
R: A Stutthof vi era impiantata una fabbrica per la produzione di sapone. E lì fui impiegato nei vari comandi di lavoro a trasportare pietre, a scaricare sacchi di cemento o a caricarli, a scaricare addirittura ghiaia dai carri ferroviari, in cinque persone, e soltanto con le mani nude perché gli attrezzi necessari non erano numericamente sufficienti. E poi ancora in altri campi, e sottocampi…
D: A Stutthof sei stato nuovamente immatricolato?
R: No.
Quindi, in una lunga serie di campi e sottocampi meno conosciuti, anche dislocati in zone remote e di difficile identificazione, e poi ancora nei campi di Hayingen – più che campi erano cave di pietra – per oltre 10 ore al giorno; e anche a Natzweiler, per le stesse ragioni e per lo stesso tipo di lavoro, a spingere i carri ferroviari, sì, ma anche carri da miniera carichi inverosimilmente di materiali ferrosi, in cinque persone, perché cinque era per le SS il numero esatto, non si doveva essere più di cinque. E quindi ancora un altro campo, e questo fu Dachau.
A Dachau il numero, oltre il numero tatuato sul braccio sinistro, ne fu dato un altro: il 150.319. Noi siamo arrivati a Dachau in un periodo sotto un certo aspetto fortunato, perché fino a poche settimane prima c’era stata una violenta epidemia di tifo petecchiale, che aveva letteralmente vuotato il campo. Comunque, una volta reso sovraffollato, il campo di Dachau appunto, che era semi circondato in quel periodo preciso – si stava verso la metà dell’aprile del ’45 – il campo superaffollato e semi circondato dalle truppe alleate, venne deciso dalle SS che tutti i prigionieri militari che erano rinchiusi nei campi di concentramento, appunto militari, esistenti nella vasta zona, fossero evacuati da quei campi e portati a Dachau. Però per far posto a loro, gli ebrei via via venivano trasferiti altrove, e non si sa dove. Anch’io fui tra questi.
Dopo alcuni giorni di viaggio in treno – non so se il treno andava soltanto in una direzione o se poi magari lo si faceva tornare indietro – fummo fatti discendere e incominciò una lunghissima marcia così incolonnati. Un tragitto stentato, colpi di arma da fuoco ma soprattutto di mitra colpivano tutti coloro che rimanevano addietrati. E comunque venivano uccisi anche coloro che in un impeto di solidarietà… cosa mai vista prima, la solidarietà, ma in quei frangenti sì, per aiutare il compagno che stentava a seguire il passo. E quindi ci si allontanava il più presto possibile da quel compagno che stava in difficoltà, perché ormai era diventato soltanto un bersaglio da colpire.
Ma intanto attraversiamo una collinetta innevata, e una frase corre tra la lunga colonna: “Ist fertig Krieg”. È finita la guerra. Ma è possibile? Sì, è possibile perché larga parte delle SS di scorta erano fuggite, ma quelli rimasti sparavano colpi di mitra indiscriminatamente su tutti. Alcuni prigionieri li vedo che si gettano a lato di questa collinetta innevata e io, facendo degli sforzi terribili, li seguo: e giù, un ruzzolare continuo sulla neve ghiacciata fino ai piedi di questa modesta altura. Ci ritrovammo, dopo poche centinaia di metri, davanti un cartello che indicava Innsbruck a 30 chilometri distante. I miei compagni erano tutti ungheresi, complessivamente eravamo in sei: cinque ungheresi più il sottoscritto. Con molta difficoltà raggiungemmo Innsbruck e qui qualcuno disse che i russi avevano liberato Vienna. Logicamente questi compagni di sventura andarono in quella direzione. Ed io continuai il viaggio verso il Brennero. Sono tornato a Roma – dopo una ventina di giorni circa nell’ospedale civile di Vipiteno – e sono tornato a Roma, appunto, il 27 maggio 1945. Inutile dire che appresi con gioia che i miei più diretti familiari si erano salvati, sani e salvi. Piuttosto, o meglio, più tardi, appresi dolorosamente che altri sedici nostri parenti, più lontani, erano stati catturati dai fascisti e consegnati ai tedeschi. Purtroppo di loro nessuno è tornato.
Mi ricordo un particolare a Vipiteno, o meglio… sì, a Vipiteno, perché dal Brennero mi fu fatto prendere il treno che non andava oltre Vipiteno. Ero stato indirizzato presso una famiglia che [era] originaria di Trento e che aiutava tutti coloro che rientravano e che avevano bisogno di… in qualche modo, essere aiutati. Mi disse: “Lei” – mi dava del lei – “lei non deve temere più nulla, qui non ci sono più né tedeschi e né fascisti. Vedrà. Lei è ancora giovane, si rimetterà presto. Quanti anni ha? Sessanta?”
D: Leone, allora: Fossoli, Birkenau. Birkenau, ci rimani sei mesi, circa?
R: Sì, oltre sei mesi.
D: Quindi fino al dicembre, gennaio?
R: No, a ottobre, perché a ottobre Birkenau incominciò ad essere in qualche misura evacuata. Poi come si sa fu liberata il 27 gennaio del ‘45 dalle truppe sovietiche. I continui spostamenti nei vari campi, piccoli e grandi, sconosciuti o meno, in una certa maniera, non so se si può valutare più pesante quel periodo di quello trascorso a Birkenau o meno, o viceversa. È stato un continuo temere di morire ammazzati o di morire sfiancati dalla fatica.
D: Ecco, proprio questo. Quindi a ottobre riparti da Birkenau e ti portano?
R: A Stutthof.
D: E lì ci rimani più o meno quanto tempo?
R: Non molto tempo. Non molto tempo perché quando eravamo a Stutthof i sovietici erano, se non vado errato, a una ottantina di chilometri dal campo.
D: Da lì ripartite?
R: Sì, per altri campi, sconosciuti, in zone deserte, di difficile identificazione.
D: Non te ne ricordi?
R: Come? E come è possibile? Uno me ne è rimasto impresso: era un hangar, un vecchio hangar, circondato naturalmente dai reticolati. E in questo hangar, in metà… la metà di questo hangar era occupato dai castelli di legno sovraffollati di prigionieri, l’altra metà invece era adibita a movimenti di camion, di soldati, era la parte dove la mattina, o meglio all’alba, si faceva l’appello e dove poi lo si ripeteva alla sera.
D: Il luogo non te lo ricordi?
R: No.
D: Poi altri campi ancora?
R: Altri campi, sempre in zone desolate e deserte. Desolate… che cosa potevamo, con quali mezzi potevamo dire “ci troviamo in questa zona”? Era assolutamente impossibile.
D: Fino ad arrivare a Dachau.
R: Fino ad arrivare a… Ma prima di Dachau ci fu Natzweiler, e ancor prima Hayingen. Hayingen era poi il campo principale di una zona dove c’erano altri campi di concentramento di cui poi c’era Natzweiler.
D: Tutti questi trasferimenti come li hai fatti?
R: Su carri bestiame.
D: Ed eravate solo uomini?
R: Sì, si era rigorosamente, come dire… si era rigorosamente divisi. Ci si poteva anche incontrare durante il lavoro con altri comandi di lavoro che magari erano composti esclusivamente da donne, ma questo avveniva non molto spesso comunque. Per esempio, questo particolare [lo] voglio dire, che mi sono dimenticato. Nel campo di Auschwitz, o meglio di Birkenau, le categorie da eliminare erano: i politici, gli ebrei, i testimoni di Geova, gli omosessuali, gli zingari, i russi, i triangoli verdi e i triangoli neri. Però non è come si può credere. Ognuna di queste categorie di prigionieri erano contrassegnate da triangoli di colore diverso. Non è come si può credere che si stesse tutti insieme, perché le varie categorie erano suddivise, diciamo, erano rinchiuse in campi diversi: gli omosessuali con gli omosessuali, gli zingari con gli zingari, e via dicendo. Comunque, questi campi, che erano anch’essi circondati da filo spinato con il passaggio della corrente ad alta tensione, erano distanti soltanto poche decine di metri l’uno dall’altro. Era una serie di campi. Solo nel campo principale, che aveva rinchiusi dentro oltre ventimila prigionieri, era costituito da politici, ebrei, triangoli verdi e triangoli neri, e tutti dalla diversa nazionalità. I politici non subivano le selezioni così come avveniva esclusivamente per gli ebrei, però i politici avevano un vantaggio penso su tutti gli altri, perché la loro ideologia politica li teneva, ecco come dici tu, più sostenuti, più sollevati. E comunque avevano una bassissima percentuale di salvezza, perché il duro lavoro lo subivano, le sevizie le subivano, le malattie, il freddo, la diarrea e quanto altro, li colpiva maledettamente. I russi, come contrassegno avevano una ulteriore striscia di rasatura sulla testa che partiva dalla fronte fino alla nuca, e come segno di riconoscimento ulteriore un disco rosso di stoffa appiccicato, o comunque cucito dietro la casacca, che era il simbolo inequivocabile dal significato ‘bersaglio da colpire’. Gli ebrei invece venivano uccisi o per le sevizie o per il lavoro forzato, ma più spesso ancora la selezione e quindi la morte per gasazione.
D: Scusa Leone, Fossoli, Birkenau, Stutthof, e poi tutti gli altri campi che tu hai fatto, durante tutto il tuo periodo di deportazione, non hai mai potuto comunicare con l’esterno del campo? O ricevere…
R: Ma come si poteva? Auschwitz, o comunque Birkenau, poiché era soltanto a 2-3 chilometri, distava dal confine italiano, se non vado errato, qualcosa come 3000 chilometri. Questo poteva succedere con i polacchi, poteva succedere, e sicuramente sarà accaduto con i russi; ma ai francesi, ai turchi – perché c’erano anche turchi – ai greci, agli italiani, ai francesi l’ho detto, e a quante altre nazionalità ci fossero, non era assolutamente possibile avere contatti con altre persone.
D: Durante il tuo periodo di deportazione non sei mai stato ricoverato al Revier?
R: No, mai. La prima cosa che si imparava, poi era difficile metterla in atto, era quella di non presentarsi mai nel cosiddetto ospedale, nel Revier, perché di là non si usciva vivi. E allora se avevi la febbre alta, se avevi il mal di gola, se avevi magari la polmonite, e se ancora avevi un po’ sano il cervello, non ci andavi.
D: Hai mai subito punizioni?
R: Io le punizioni me le sono andate a cercare, ne ho prese quante ne ho volute, ma questo ricevere colpi dappertutto e da tutti, anche dai miei stessi compagni, non italiani, non perché gli altri mi portassero rispetto, ma dava a me la forza di resistere, perché mi dicevo: se io cerco in qualche maniera di non fare questo lavoro o di non farlo comunque come lo si vuole, cercando di non farmi vedere, magari adottando piccolissime astuzie – mi dicevo – è preferibile rischiare di prendere delle bastonate che perdere un etto di ciccia, perché non si rimette più.
D: Quindi hai ricevuto punizioni?
R: Sì, sì. E ne ho fatte anche prendere, incolpevolmente, perché chi lavorava con me era destinato a prenderle anche lui. Erano diventati tutti nemici praticamente.
D: Questo a Birkenau?
R: A Birkenau, sì. A Birkenau.
Io ho avuto un carissimo amico, diventato carissimo amico nella prigionia, e con lui ho trascorso molti mesi di prigionia. Eravamo arrivati a dividerci quanto riuscivamo a racimolare, cambiando la zuppa con altre cose, e poi tornando a cambiare queste cose per il pane e via dicendo. Un lavoro difficoltoso, perché era vietato entrare nelle altre baracche diverse da dove si era alloggiati. E quindi questo rischio lo si correva per cercare di mandare giù nello stomaco qualcosa che ci desse – come potevano essere le bucce di patate – che ci potessero dare una maggiore sensazione di sazietà. Questo caro amico, anche perché lui, anche lui romano, piccolo di statura come me, grossomodo avevamo la stessa età, a volte passavamo… ci scambiavano per fratelli, e noi non avevamo assolutamente niente da dire su questa fratellanza inesistente. Purtroppo lui non ce l’ha fatta. Quanto io ho scritto, quanto ho scritto l’ho dedicato a lui.
D: Che si chiamava?
R: Renato Sonnino.
D: È mancato a Birkenau?
R: No, non l’ho visto. Dopo Birkenau noi abbiamo passato lunghi mesi insieme. Tanto è vero che io, quando mi trasportarono a Natzweiler, credendo che fosse l’ultimo viaggio, sperando che fosse… non sperando, credendo, che si andasse verso il crematorio, poiché avevo avuto l’impressione… Ma poi, fatta ragione che era stata una vera e propria selezione, ci portarono dentro questa grande baracca e prima di essere trasportato comunque, ad un comune amico dissi: “Se… quando torna Renatino, abbi la cortesia di dirgli che se ha la fortuna di tornare a casa dicesse ai miei che sono morto.” Fortunatamente arrivati in quel campo fummo fatti spogliare e una volta denudati fummo fatti entrare dentro questa baracca che era stata una baracca adibita a camera a gas, ma fortunatamente incominciò a uscire dell’acqua, puzzolente, giallastra, ma comunque, comunque acqua.
- scarica la testimonianza (271 KB – PDF)
- Fiorentino Leone: testimonianza sonora, 1° parte (64′) (29,7 MB – MP3))
- Fiorentino Leone: testimonianza sonora, 2° parte (29′) (19,4 MB – MP3)