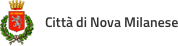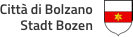Riccardo Goruppi
Nato il 14/01/1927 a Prosecco (Trieste)
Intervista: 23/06/2000, a Villa Opicina (Trieste), realizzata da Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari
TDL: n. 26 – durata: 62’
Arresto: 25/11/1944 a Prosecco (Trieste)
Carcerazione: Carcere del Coroneo di Trieste
Deportazione: Dachau (Matr. 135.423); Leonberg (Matr. 40.184); Mühldorf; Kaufering
Liberazione: maggio 1945 a Kaufering.
Nota sulla trascrizione della testimonianza:
La trascrizione è integrale e fedele all’originale. Gli interventi del compilatore sono segnalati da parentesi quadre. Per espressioni di difficile interpretazione si segnala l’omissione con la dicitura […]. Alcune ripetizioni ed elementi intercalari in parte non sono stati riportati.
Io sono Goruppi Riccardo, nato il 14.1 del 1927 a Prosecco, provincia di Trieste. Arrestato il giorno 25 novembre del 1944, trasferito alle carceri del Coroneo di Trieste, subìto tre interrogatori, certo non bene. L’ultimo interrogatorio l’ho subito cinque minuti prima della partenza per la Germania. Perché l’ultimo? Perché alla sera, quando hanno chiamato i numeri e i nomi delle persone che dovevano partire, il mio non è stato chiamato come [neppure] quello di mio padre. Al momento, non essendo stati chiamati era la cosa più brutta, perché si rimaneva nell’interno delle carceri come ostaggio, e come ostaggi la giornata era pericolosa sempre, in qualsiasi momento.
D: Riccardo, chi ti ha arrestato e dove ti hanno arrestato?
R: Mi hanno arrestato a Prosecco, per una spiata. Le SS e mi hanno trasportato al Coroneo.
D: Sei stato arrestato con altri?
R: Si, hanno rastrellato il paese completo, cioè, c’erano diverse persone, non saprei dire se 40 o 30.
D: Dici che ti hanno arrestato per una spiata: tu facevi parte di un’organizzazione partigiana?
R: Io ero partigiano. Ero partigiano. Ma in quel momento mi trovavo in paese perché ho dovuto subire un’operazione e sono ritornato a casa; dopo l’operazione sono ritornato a fare il partigiano. Comunque, m’hanno preso senza armi: ecco perché poi sono finito in Germania invece di finire alla Risiera di San Sabba, [nel]la quale mi promettevano o un interrogatorio o logicamente… Non ho mai detto che non ero partigiano, non l’ho mai detto, perché quando mi chiedevano [rispondevo: “sì, sono partigiano”]. Dopo la chiamata che hanno fatto la mattina, si sono presentati i due giannizzeri, cioè le SS, con l’interprete, gridando: “Dove sono quei due che non vogliono andare in Germania?!”, e ci hanno chiamato per cognome e nome. Mio padre è stato portato immediatamente nella fila [dove] c’erano cinque già pronti per la partenza. E a me mi hanno portato a un ultimo interrogatorio, m’ hanno pestato molto bene, nel quale momento m’hanno anche rotto i denti davanti. E poi, guarda il caso, mi hanno dato per il trasporto due pezzi di pane e un pezzo di formaggio, perché quello era dato a tutti per il trasporto che si faceva. Il trasporto è durato da Trieste partendo il giorno 8, siamo arrivati a Dachau il giorno 11 [dicembre 1944].
D: Siete partiti dalla stazione di Trieste?
R: Siamo partiti da Trieste dalla stazione dalla parte del silos, dove c’erano le famose partenze dei treni. E lì ero separato dal gruppo dei paesani, compreso da mio padre, perché m’hanno portato come ultimo. Devo dire che fra la scorta c’era proprio il mio operaio del cantiere San Marco, che era un sergente delle MM [Marina Militare]. Questo m’ha scortato nel vagone; non avevo la possibilità di chiedergli di entrare nel vagone di mio padre, fino a che nella vallata, credo in Austria, hanno fermato questo treno, hanno circondato il luogo e hanno fatto scendere le persone per vuotare le Kübel, cioè i bidoni famosi che si usavano nei vagoni. Nel vagone eravamo dalle 60 alle 70 persone. Lì ho chiesto a questa persona se [potessi] entrare nel vagone dove era mio padre, m’ha detto: “Beh, tanto andate tutti in un posto, puoi entrare.” Sono entrato nel vagone, fortuna perché non ho mangiato il pane – non lo potevo mangiare perché avevo rotti i denti – la fortuna di arrivare nel posto dove tutti avevano già fame: ecco che ho diviso quel poco di pane che c’era.
Arrivati a Dachau… Andando in Germania si pensava di andare a un lavoro, cioè certo in una prigione molto più grande, sempre però a un lavoro. Entrando, sulla porta, ho chiesto al mio operaio del cantiere San Marco se “può avvisare a casa che siamo in Germania, io e mio padre”. “Beh – ha detto – tanto non ha nessunissima importanza, da qui non tornate più”. Dunque lo sapevano molto bene dove ci hanno portato. Ma non ho pensato questo, perché entrando in questo luogo ho visto l’ampiezza del campo; ho detto: “Questa è una prigione molto più attrezzata del Coroneo ma siamo nelle vicinanze di un posto di lavoro o qualcosa del genere.” Sennonché, arrivati, ci hanno fatto gettare tutto quello che avevamo: oltre al vestiario che si aveva addosso, i vestiti che ci hanno portato da casa nelle prigioni, avevamo qualcosa… e tutto bisognava gettare sul mucchio. E entravamo dentro nella sala delle docce. Nella sala delle docce c’erano i prigionieri, i famosi barbieri, che ti rasavano completamente. Fatta la rasatura completa sulla persona totale, c’hanno fatto a noi italiani una striscia lungo la testa che significava traditori. Noi italiani e i russi avevamo questo segno perché eravamo calcolati traditori. Fatto questo, ci hanno messo sotto le docce, hanno aperto l’acqua fredda – dico nel mese di dicembre, era l’11 dicembre – hanno aperto l’acqua fredda, l’acqua calda, l’acqua fredda: e allora si faceva dei salti che non finivano più, e loro ridevano, si divertivano. E poi ci hanno dato una manciata di un… hanno detto sapone, ma c’era una soda caustica o qualche cosa del genere, e poi bisognava molto bene sparpagliare dove ci avevano rasato: allora si vedeva i salti che si facevano perché la rasatura certamente non era tanto delicata, di tagli ce n’erano. Finito questo [loro] divertimento ci hanno consegnato le famose divise a zebra, era a strisce bianche e blu il vestito, e davano un paio di calzoni, una giacca. [Per] chi aveva la fortuna di riceverla, anche una specie di “sopra giacca” – noi la chiamavamo cappottino – era la stessa stoffa, ma era più lungo. Non tutti avevano questa fortuna, perché fino a quando c’era davano, poi non c’era più e non davano più, davano quello che era. Gli zoccoli aperti, con una tela; calze non se ne vedevano. Chi aveva ricevuto un po’ più lunghi i calzoni, [questi] servivano anche da calze, fortunatamente. La cosa più brutta… ecco quando si è capito di essere entrati in un campo di sterminio. Quando siamo usciti all’appello ci hanno consegnato prima dei numeri e i triangoli, e bisognava cucire sulla giacca e sui calzoni. Sul [triangolo] c’era la scritta dello Stato a cui si apparteneva: noi avemmo la “I” come Italia. Arrivati a questo punto fu chiamato un interprete dalle nostre file – anche se avevano un interprete proprio, non lo so perché, per una verifica, probabile – hanno chiamato e questo doveva dire le parole che le SS, cioè il comandante del campo, dichiarava in quel momento. La dichiarazione era questa: “Da questo momento voi non siete più uomini, siete un numero e con questo numero verrete chiamati. Non potete comunicare con l’esterno.” Ecco questa era la cosa più… la dignità della persona, nel momento che ti portavano via il tuo nome e cognome… e l’hanno pronunciato per l’ultimo nella chiamata, poi hanno chiamato col numero. Certo era molto difficile, difficilissimo per chi non capiva il tedesco; per chi capiva il tedesco il numero era facile, ma chi non lo capiva, il 135.423, nel tedesco era hundertfünfunddreissigtausend vierhundertdreiundzwanzig, che era una cosa enorme! Enorme al momento. E allora te lo sei imparato immediatamente perché arrivava e bastonava. Tornava a richiamare i numeri e bisognava rispondere con “hier” [qui, ndr], man mano che rispondeva quello che era davanti si rispondeva automaticamente, ma in poco tempo si è imparato il numero: la prima cosa che uno si è imparato è il numero, e non se lo è dimenticato di certo. Da lì trasferiti alla baracca della quarantena. C’erano le baracche dispari, c’erano i Revier, la baracca degli esperimenti e poi c’erano le baracche della quarantena. Ecco, si è saputo immediatamente da gente che era all’interno di non farsi vedere troppo forti, troppo veloci, troppo espansivi, perché potevi essere scelto per degli esperimenti. Non dovevi far vedere di essere ammalato perché potevi essere eliminato, perché hanno eliminato immediatamente gli ammalati. Ho fatto la quarantena, diciamo quarantena… ho fatto 20 giorni all’interno. La baracca era lunga 100 metri, divisa in quattro Stuben, e man mano che invocavano i numeri entravamo nelle Stuben. Nella Stube c’era lo spazio di una camerata – dunque doveva essere 25 metri circa – ma era ricavato anche uno spazio per il capobaracca; poi c’erano i letti a quattro piani. La cosa più tremenda era dormire in quel posto. Perché? Perché i letti non erano separati, erano incolonnati, attaccate le cuccette, attaccate tutte, era come un quadrato, e dove dovevano dormire 20 persone, ad esempio ne dormivano 40, anche 50. Guai perdere il posto la notte, perché alla metà della baracca c’erano le latrine e se uno perdeva il posto non riusciva più a ritornare; poi con le bastonate del kapò certo si rientrava, in una maniera o nell’altra. Si dormiva piedi e testa, l’uno con l’altro, c’era molta difficoltà.
Arrivati a un momento, a una data che non so esattamente, ci hanno radunato nel salone delle docce al quale sono arrivati i famosi capi dei campi che dovevano prelevarci e portarci via da Dachau. A Dachau c’erano dei trasferimenti, non è che uno rimaneva a Dachau perché era a Dachau, c’erano trasferimenti fino a Auschwitz, ad esempio. E io sono stato trasferito. Alla scelta del gruppo sono stato scelto per il lavoro e sono partito, mi hanno trasferito al campo di Natzweiler, nella località di Leonberg. Il campo era nel territorio tedesco e lavoravamo nel tunnel autostradale. Hanno chiuso i due tunnel della strada che porta non so dove… verso una località, e hanno fatto le fabbriche lì.
D: A Dachau, prima del trasferimento, hai visto se c’erano anche dei religiosi deportati?
R: Sì, nel trasferimento alla baracca 19… Quando sono stato scelto non sono rientrato più alla baracca 19 ma sono partito alla baracca 29. Nella baracca 29 ho trovato dei religiosi, dei preti, e devo dire anche una cosa molto bella, perché queste persone… io dico sempre: uno per sopportare, per riuscire a uscire da questo, doveva avere un senso di solidarietà, un Credo, un qualcosa, o in Dio o nel politico, un senso doveva averlo per poter sopportare queste cose che son successe. Ho visto dei religiosi veramente… veramente… Io non sono uno di quelli che si inginocchiano per ogni cosa, mi inginocchio quando c’è la necessità di aiuto e lo faccio volentieri. C’erano questi religiosi che con la mollica del pane consolavano le persone che erano veramente dei devoti, che credevano in questo, e con piccole cose hanno dato coraggio alle persone; questo l’ho visto da questi religiosi in quel momento. Poi credo che questi sono stati scelti per andare in un altro campo, perché i religiosi erano nel campo libero, nelle ultime due baracche che c’erano [con] numero pari.
Trasferito in questo campo, la prima volta che ho visto il mucchio di morti davanti a crematori. A Dachau c’erano anche caserme delle SS, non delle SS che facevano la guardia a noi ma un reparto di SS che facevano addestramento. Coi camion ci hanno portati fino ad Asburgo perché le vie ferroviarie erano bombardate. Attraversando questo posto son passato davanti al cancello dei crematori e ho visto il mucchio dei morti. Lì mi sono reso veramente conto di cosa è il campo di sterminio. Ma nella speranza di uscire c’era una speranza sempre di andare verso qualche cosa di nuovo, difatti ci hanno portato in questo luogo di Leonberg, dove hanno chiuso questi due tunnel. C’era già un campo di baraccamento con il legname, hanno costruito due blocchi in cemento e m’hanno sistemato in uno di questi due. Devo dire che nell’interno della camerata c’era anche una stufa. Si lavorava giorno e notte. Non è che uno dice “la domenica non ho lavorato e ho fatto festa”, questo è anche successo nei campi, ma qui si lavorava giorno e notte.
Il viaggio da Augsburg a Leonberg è durato un giorno, perché l’ultimo dell’anno eravamo a Leonberg. Eravamo il gruppo di Ronchi al completo, poi c’era mio padre e un gruppo di ragazzi di Prosecco, proprio amici miei, partigiani, che abbiamo lavorato insieme. Arrivati a Leonberg c’hanno preso in consegna i kapò. I kapò erano sempre i triangoli verdi, non so se in qualche campo può essere stato anche con un altro triangolo, ma la maggioranza erano triangoli verdi prelevati dalle carceri e trasportati in questo. Nel campo di Leonberg abbiamo avuto un kapò italiano, un certo Carlo, di Bolzano. E io ho detto: “Meno male, abbiamo un kapò il quale capisce la nostra lingua e possiamo anche chiedere qualche cosa.” Ma era uguale a tutti gli altri, non ha cambiato niente, perché queste persone dovevano dimostrare alle SS di essere capaci di mantenere questo gruppo che avevano in dotazione, ecco perché anche questa gente doveva farlo nella maniera… certe volte erano più brutali delle SS. Io di lui, ho una cosa sola che poi dirò… L’Appelplatz iniziava alle 5 del mattino, per chi lavorava di giorno, e alle 6 si entrava in questo tunnel. Per 12 ore non si usciva, ma la cosa [importante] era questa: era un lavoro di catena, facevamo ali di aerei, e ogni gruppo che c’era di cinque-sei persone aveva un Vormann tedesco, un operaio tedesco del luogo, credo sia stato del luogo, o non so arrivato da dove. Ma comunque questi non erano tanto cattivi perché non bastonavano, avevano solo il dovere di controllare che non [esistessero] sabotaggi sui pezzi che si mandava avanti. Ogni quindici persone c’era un SS che camminava su e giù, lungo il tunnel. Ecco la cosa… quando passava bisognava levare il berretto e quando se ne andava mettere il berretto, quando ripassava levare il berretto: questo per 12 ore. Ecco anche questo, è una cosa per denigrare la persona. Davanti le latrine c’era la sentinella, dunque non dico altro. Il lavoro dunque era 12 ore, il sabato [con] il cambio turno tornavano a lavorare giorno e notte, c’erano 16 ore lavorative. Si cambiava il turno, tanto è vero che io avevo un numero di matricola minore di mio padre e non ci siamo mai incontrati, solo vedendoci nel passaggio, perché lui lavorava la notte ed io il giorno, quando lui lavorava di giorno io lavoravo di notte. Questo ha avuto una durata di poco tempo perché mio padre è morto in febbraio, il 20 di febbraio [1945] … Difficile era chiedere qualcosa. Io ho ricevuto molte bastonate da questo Karl, molte. Però devo ringraziarlo anche – credo sia morto – perché quando mio padre si è ammalato ti tenevano nel blocco per un giorno, il giorno dopo o uscivi o dovevi essere trasportato al Revier Sennonché, maledettamente, in quella serata hanno fatto lo spidocchiamento, cioè la disinfezione del vestiario, che non hanno fatto mai. Quella sera tutti quelli che non avevano il turno, che non lavoravano, dovevano andare in fondo: c’era una baracca, spogliarsi a nudo – parlo sempre in febbraio – spogliarsi a nudo, depositare le cose sul posto, loro venivano, prendevano questi stracci, li portavano a disinfettare e poi li riportavano. Io non ho mai capito come dopo abbiamo ricevuto la stessa divisa, questo non lo so, ma comunque l’abbiamo ricevuta. Ecco, mio padre stava male prima, e quella sera era il colpo di grazia perché poi ha preso una polmonite fulminante e la mattina è morto. A questo Karl io ho chiesto – bisognava chiedere per poter andare da una baracca all’altra baracca – ho chiesto se [potessi] accompagnare [mio padre] e m’ha detto di sì, e di questo gli dico grazie. E poi quando sono ritornato dal lavoro la mattina ho chiesto se posso andare al Revier a vedere e m’ha dato [di nuovo] il permesso, non scritto, il permesso era così [a voce, ndr], e purtroppo ho trovato mio padre che era già morto. Sono arrivato, ho chiesto a due persone che c’erano lì, e parlavano italiano, ma non so di dove erano, e m’hanno detto: “Adesso lo hanno portato via”. E dico: “Verso dove?”, “Verso su”. E son corso. Potevo anche morire immediatamente, ma non aveva nessuna importanza. Son corso verso l’alto e c’era la fossa comune. Chi non ha visto una fossa comune sarebbe giusto che la vedesse, perché nell’interno di quelle fosse ci sono… ci sono tutte le religioni, tutte le nazionalità. Io dico sempre e lo dirò sempre: lì dentro sono i pilastri dell’Europa unita, se la dovessero fare, perché lì dentro ci sono tutte le religioni; non si distingue dall’ebreo al cristiano o allo zingaro, perché c’erano lì dentro. E io l’ho visto. Io l’ho visto.
Non so se una decina di giorni poi, mi sono ammalato di tifo… e ho dovuto andare al Revier. Ma ero tanto sicuro di andare a finire la mia vita che mi son spogliato del cappottino famoso che avevo – perché non tutti l’avevano – mi son spogliato e gliel’ho dato a un ragazzo, un partigiano, e gli ho detto: “Guarda, a me non mi serve più. Te lo do a te, tanto…”. Ecco, io sono qui e lui è morto. Anche questa è una cosa… che il destino porta a questo. Vede come sono le cose che succedono. Comunque ho fatto il tifo, non so la durata di un’incubazione di tifo, credo sarà 20 giorni come minimo. E dico sempre, qualcuno m’ha dato da mangiare, perché sennò morivo di fame. Ecco, ringrazio sempre queste persone che non ho mai conosciuto e che mai conoscerò. Però qualcuno mi ha dato da mangiare. Da lì hanno evacuato il campo.
D: Prima dell’evacuazione del campo: voi facevate parti di aeroplani?
R: Ali, le ali di aerei.
D: Sai per che fabbrica, per che ditta?
R: Lavoravamo per la Messerschmitt.
Alla sera si sentiva il cannoneggiamento, poi dicevamo “Il fronte è vicino, il fronte è vicino”, ma purtroppo la durata era abbastanza lunga. Nel momento dell’evacuazione del campo, i gruppi che potevano camminare li hanno fatti camminare con la marcia forzata, e difatti hanno fatto 220 chilometri quelle persone nelle giornate seguenti, fino a Dachau nel ritorno; perché tutti questi sottocampi dovevano rientrare nel campo principale, perché c’era un programma di eliminazione. Tanto è vero che noi non siamo rientrati a Natzweiler, che era il nostro [campo], perché Natzweiler era evacuato, essendo in territorio francese verso Dachau. A me m’hanno portato col treno con i vagoni aperti, quelli che trasportano carbone, perché ormai non eravamo in forze, e ci hanno portato a Dachau. Siamo arrivati a Dachau, non dico i morti che c’erano in quei vagoni, dico che forse per ogni vagone c’erano cinque vivi. E dovevamo scaricare questi morti, con la tristezza di non aver potuto adoperare le mani, perché eravamo delle larve, coi piedi li rotolavamo e [li] scaricavamo. Fatto questo il treno imbarca e va a Mühldorf, perché Dachau era troppo pieno. Ci portano a Mühldorf, era un sottocampo di Dachau. La matricola è rimasta quella di Natzweiler; comunque non si cambiavano più le matricole perché erano giorni di smistamento, in questi sottocampi si stava dai dieci ai quindici giorni.
D: L’altra matricola che tu avevi quale era?
R: 40.184.
D: Ed era quella che ti hanno dato al campo…?
R: Di Leonberg, al [sotto]campo di Natzweiler. Di Mühldorf ricordo poco, sono ricordi di una ventina di giorni della mia vita […] A Mühldorf c’erano dei baraccamenti a punta, baracche piccole, son stato non so se cinque o dieci giorni, non saprei, e ci hanno trasferito in un altro sottocampo di Dachau, a Kaufering. Kaufering, lo dicono nei libri, era uno dei sottocampi più terribili. In tutto questo periodo di trasferimenti non c’era da mangiare, non si mangiava. Arrivati a Kaufering, c’erano dei baraccamenti sottoterra: io credo che una volta [ci fossero] dei depositi di munizioni o qualche cosa del genere. E c’erano dei baraccamenti dove ci stavano sedici persone. Non c’erano letti, per terra c’era della paglia sparpagliata, poi non c’era niente più. E arrivati c’era un’erba attraverso tutti i coperchi delle baracche [che emergevano per] un metro circa da terra, il resto era sotto. C’era l’erba verde, il giorno dopo non c’era più niente… nemmeno… Io non so, abbiamo rosicchiato le radici [tanto che] per 20 anni l’erba non [sarà cresciuta] più, abbiamo mangiato tutto. La cosa più triste era che non entravano più le SS nell’interno, erano solo all’esterno, e ripartivano il mangiare. Prima c’erano delle scodelle con cui ci davano le rape calde, lì invece ci davano del caffè, io credo [fosse] erba bollita. Ecco la differenza: a Dachau avevamo il pane diviso in quattro, a Leonberg avevamo il pane diviso uno a sedici. Devo dire, la sacra onestà del deportato che ripartiva questo pane: in ogni baracca c’era uno che doveva ripartire [il pane], che era già tagliato, in maniera che il fondo della pagnotta arrivava oggi a uno e domani ad un altro, non perché era più voluminosa ma perché era il pezzo più duro e durava di più.
A Kaufering sono rimasto una quindicina di giorni. Hanno evacuato il campo, hanno chiamato tutti gli ebrei fuori, perché c’erano degli ebrei fra noi. Noi eravamo tutti amici, io in quel senso nel campo non ho avuto delle brutture fra i deportati, ho avuto sempre cose belle fra i deportati. E ho avuto anche questa, di avere un ragazzo con noi nella stessa baracca; perché, quando moriva una persona bisognava spogliarla, bisognava trascinarla vicino alla porta, piegare il vestiario – queste giubbe, come se [fosse] oro – col numero verso l’alto, e appoggiarlo sul petto della persona. Venivano a prendere prima il vestiario, non il morto, e segnavano con una matita blu il numero [di matricola] sul petto. Ecco, voglio dire, quando uno va alla ricerca del proprio morto nelle fosse comuni, come può saperlo? Fatto questo, abbiamo detto a questo ebreo… perché le cose peggiori succedevano agli italiani perché traditori, ai russi perché russi, agli ebrei perché erano ebrei; tutto il resto non è che finiva bene, tutto il resto si risparmiava qualche bastonata, ne riceveva meno. E abbiamo detto: “Guarda, mettiamo la tua giacca al posto di questo e ti vestiamo con questa nostra giacca.” Difatti lo abbiamo fatto. E quando eravamo in piedi per la selezione che hanno chiamato tutti gli ebrei, lui è uscito automaticamente. È uscito perché si è sentito ebreo, perché ormai per tutto il periodo era ebreo, e l’ha fatto. Li hanno ammazzati tutti. Hanno scoperchiato una delle baracche più grandi che c’era al centro del secondo campo – c’erano due campi separati, il secondo era un baraccamento più grande, era una fossa comune – e poi hanno dato fuoco, [lasciando] una scritta: “Attenzione tifo”. A noi ci hanno imbarcato su un treno, sempre a vagoni aperti, e ci hanno trasportato lungo la ferrovia. C’era un treno blindato che sparava sul fronte e ci hanno messo come scudo. Gli americani erano arrivati a mitragliare questo treno, ma certo hanno mitragliato il nostro che non si finiva più.
Quando uno dice che non ha paura non credergli mai. Mai. Perché la paura fa il coraggio. In quel momento ci siamo tutti raggruppati verso gli angoli di questi vagoni, perché non avevamo la forza di scavalcarli. Certo, il gruppo che era sotto, erano morti, e ci siamo automaticamente rialzati per poter scavalcare la balaustra del vagone. I primi che sono caduti sulla ghiaia si sono spaccati. Io sono caduto su un mucchio di morti… ho avuto la fortuna. Ho avuto la fortuna anche di non approfittare del momento di andare verso il bosco, che c’era un boschetto vicino. Mi sono rintanato sotto le ruote dei vagoni, perché sempre mitragliavano, e i tedeschi, invece di mitragliare sugli aerei, hanno iniziato a mitragliare su quella gente che si sparpagliava, così ci sono [stati] dei morti. Io mi sono salvato perché eravamo quattro persone e abbiamo fatto un ragionamento di ricercare qualcosa da mangiare sul treno blindato, perché il treno blindato aveva due o tre vagoni di roba rubata. C’erano ad esempio, nel vagone dove siamo riusciti a salire – ma con molta difficoltà perché non era così facile risalire – c’era metà vagone di materassi. Materassi nuovi… e dei cassoni, che non so cosa c’era dentro. Man mano che si vede che il treno viaggiava questi materassi son venuti in avanti, e da un lato c’era uno spazio: allora ci siamo infilati nell’interno. Siamo stati in piedi perché c’era uno spazio così [stretto], dietro, e siamo stati lì. La cosa più triste, la cosa più brutta, è successa dopo. Quando hanno spostato il treno, hanno dato fuoco con benzina al treno nostro: e c’erano degli urli, tremendi, tanto erano grandi che se si è passato il fronte noi non ci siamo accorti. Alla mattina – io credo la mattina, poi può essere stato due giorni, non lo so – c’era un silenzio, ma un silenzio da tomba, un silenzio che ha fatto più paura delle urla che c’erano la notte. E allora decidiamo di uscire. Sempre strisciando a quattro [a carponi, ndr] non a due piedi, arriviamo fuori e ci mettono il fucile sulla testa. Abbiamo detto: “Adesso è la fine”. Poi comincia a levarci fuori da questi buchi [tra i] materassi, e inizia a piangere. Era un negro, era un nero… non finirò mai di ringraziarlo. Lui piangeva, noi piangevamo. Non abbiamo capito perché. Non sapevamo ancora che era uno che aveva iniziato a salvarci. Tirati fuori, finito a piangere, ci ha preso tutti e quattro nella cabina del camion e ci ha portato immediatamente – c’era un centro di raccolta in fondo, si raggruppavano da altri campi – e ci ha portato direttamente a un ospedale. C’era un monastero, nelle vicinanze – tutta questa cosa si sta svolgendo in una trentina di chilometri da Monaco – e questo monastero è stato preparato a un lato [come] ospedale per i deportati, e difatti ci hanno immediatamente ricoverato. Nell’interno ci hanno disinfettato, ci hanno levato gli stracci che avevamo, che non abbiamo più recuperato, e ci hanno messo in piedi sul letto perché… Io ho incontrato il prete di quel momento, dopo venti anni che sono andato su, e lui m’ha chiesto: “Da dove sei arrivato qui?”. Ho detto: “Sono arrivato dal treno…”. Ha detto: “Io so che vi hanno portato [in] pochissimi. Vi abbiamo dovuto tenere a sedere perché vi avevamo adagiati e vi cadevano gli occhi nell’interno”. Dunque, eravamo all’ultimo stadio, veramente. Ho avuto fortuna di mangiare poco, comunque regolare, quello che m’hanno dato, ma c’era gente che non si nutriva che solo con [la] flebo – io era la prima volta che vedevo [una] flebo, che prima non si sapeva nemmeno… – li nutrivano con questo perché l’intestino non lavorava più.
Ho fatto tre mesi d’ospedale. Quando mi chiedevano il nome e cognome ripetevo il numero. Non sapevo chi sono, non sapevo da dove arrivo né dove sono, ma mi sono rimasti nella testa – e che questo me lo sto chiedendo… – i nomi dei posti! Ma non dico di Kaufering, non dico di Dachau, non dico di Schaffhausen, il punto dove c’era il treno. Che poi io l’ho visitato dopo 25 anni, e ci sono le fosse comuni [dove] c’era il treno, ci sono le lapidi sulle fosse comuni solo in ebraico, perché le hanno fatte gli ebrei. Sulle lapidi c’è una bellissima scritta, che me la son fatta tradurre dal rabbino, perché c’è una scritta molto importante. C’è una scritta che dice: “Il viaggiatore passando si chiede cosa è questo: qui sono sepolte le ossa sacre dell’ultimo minuto di guerra”. Questo è scritto sulle lapidi.
Mi dispiace tanto di non aver avuto la forza… Quando mi sono ricordato il nome e cognome – che poi l’hanno scritto immediatamente perché si perdeva la [memoria] nuovamente, non rimaneva – è quando ho incominciato a ragionare e a camminare che questo nero veniva giornalmente all’ospedale a visitarci, e non gli ho chiesto il nome e il cognome. Io, la notte quando dormo, perché dormo poco, me lo vedo. Me lo vedo come quel giorno che l’ho visto. E non l’ho chiesto, non l’ho chiesto.
La cosa più triste ancora è stata anche all’ospedale. È stata la questione di una donna. Una donna di Rodi, parlava l’italiano. Eravamo 4 cristiani e 500 ebrei in questo ospedale, e fra questi c’erano due ragazzi di Rodi che, quando si è iniziato a camminare – io aiutavo a fare la barba alla gente, facevo qualcosa, tanto per fare qualcosa se no diventavo pazzo – m’hanno chiesto, questi due ragazzi, essendo questa persona da Rodi, se [potessi] andare a fare compagnia a questa ragazza che era sola, perché purtroppo questa era isolata. Era peggio che in campo perché nel campo era con altre persone ma lì era l’unica donna, isolata in una stanza. E difatti andavo. Andavo molto volentieri per stare insieme, per parlare, e anche per poter capire tante cose sulle questioni delle donne, che poi fra noi ci si parla molto apertamente, specialmente in quei luoghi. La cosa triste era questa, che quando ha iniziato a stare meglio questa ragazza, ha detto: “Riccardo, guarda… – ma si parlava di tutto, ecco, ma dico queste parole – pensi che io sarò donna qualche volta?”, che si è scoperta, c’erano quattro ossa… giuro, quattro ossa. E ho detto: “Sì, senz’altro, vedrai…”. Difatti, quando sono andato via, quando sono partito da quel posto, già camminava in piedi. Spero che viva ancora oggi, ecco.
D: Riccardo, quando sei rientrato in Italia?
R: Io Sono rientrato in agosto [1945]. Però, se mi permettete voglio dire una cosa che mi ha fatto diventare una persona nuovamente. Perché credo di aver assorbito tanto di quell’odio in quei posti, verso questi torturatori. Perché non parlo di tedeschi, perché non si può dire tedeschi, dobbiamo sempre dire SS. L’odio accumulato, avevo paura di non poterlo smaltire mai più. E la cosa che m’ha fatto pensare di diventare una persona nuovamente è stata al momento quando nell’ospedale… c’era un reparto dove c’erano i tronconi di persone, tronconi militari, che erano senza mani senza piedi, senza cose… E quando ho iniziato a camminare io ho voluto vedere questo, è una cosa che m’ha tentato a entrare, non so perché… è così il destino. Quando sono entrato, vedendo, queste persone m’hanno fatto pietà. E in quel momento ho detto: “Ecco, sono ancora una persona”. Queste cose… tutti dovrebbero vedere, per capire cosa può portare l’odio e cosa può portare una guerra. Perché l’odio verso di noi era tremendo, ecco. E spero, speravo sempre che mai più [succedessero] queste cose, questo di odiarsi, perché è la cosa più brutta, perché è la cosa che sta portando a quello che ha portato a noi. Ci odiavano e ci hanno fatto odiare dalla gente che non aveva né pena né colpa, perché i tedeschi, loro ci presentavano come dei criminali, a noi. Non ci presentavano come dei prigionieri o persone che erano imprigionate per un qualcosa, ma ci presentavano come criminali, e difatti i tedeschi civili avevano paura di noi, perché gli hanno inculcato nella testa queste cose. E difatti ci portavano dei ragazzini a tirarci, a sputarci, a [fare] tante cose… ma cose che, purtroppo, quando si è in una fase di un nazismo, come è preparato… succedono queste cose.
D: Riccardo, tu in questi anni sei mai stato intervistato?
R: Sì, sono stato intervistato, sì. Sì, ho fatto delle interviste. Ma io per molto tempo non si poteva… perché era difficile ricordare tante cose, perché un’intervista ti sta portando nel campo, rivivi il campo e poi non stai bene … non stai bene. Ma poi ho detto: se non testimoniamo noi che siamo i sopravvissuti? Dobbiamo farlo perché i giovani devono saperlo, perché non possiamo dire: i giovani sono così, non capiscono e non sanno. Non sanno perché non possono saperlo se non lo si spiega. Io vado anche nelle scuole, mi chiedono e vado. Ho fatto un’intervista a Roma con 2000 studenti, addirittura con sardi, e ho avuto delle grandissime soddisfazioni. Delle soddisfazioni che i ragazzi hanno capito. Ecco, quando capiscono i giovani è una grande soddisfazione. Certo, ero distrutto alla fine degli otto giorni che ero fuori, però non mi son lamentato per questo, senz’altro no.
D: Del ritorno cosa ti ricordi ancora?
R: Del ritorno mi ricordo tante cose perché poi il nostro ritorno non era facile. Credo, e qualche volta penso, che se [avessero] potuto ci avrebbero portato di notte che nessuno ci avrebbe veduto… un tiro di pistola, un tiro di fucile o di mitra… Ecco, questa è la cosa più triste. Quella, e vedere morire di fame. Questa è anche triste, perché morire di fame è una cosa …la persona [denutrita diventa] molto più di una bestia e diventa… poi ve lo racconterò senza essere registrato… non ha più un pensiero, non ha più una voglia di vivere perché non sa che è ancora in vita. [sono stato] una ventina di giorni in questo ospedale, non un giorno, e non sapevo chi sono, non sapevo…
D: E come è tornata poi la coscienza?
R: Si è ripresa con calma, ma con molta calma. E arrivavo a dire: io sono Goruppi Riccardo. Poi mi perdevo, non sapevo più chi sono, non avevo ancora da stringere le mie meningi, ecco. E quando sono riuscito a capire chi sono e iniziare a camminare a due… perché vi dico, una cosa molto triste in ospedale…
- scarica la testimonianza (214 KB – PDF)
- Goruppi Riccardo: testimonianza sonora (62′) (28 MB – MP3)