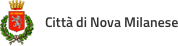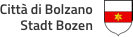Nota sulla trascrizione della testimonianza:
La trascrizione è integrale e fedele all’originale. Gli interventi del compilatore sono segnalati da parentesi quadre. Per espressioni di difficile interpretazione si segnala l’omissione con la dicitura […]. Alcune ripetizioni ed elementi intercalari in parte non sono stati riportati.
Mi chiamo Pio Bigo. Sono nato il 28 marzo del 1924 in Piemonte, precisamente alla Cascina Falchetta, nella tenuta della Mandria, allora proprietà dei marchesi dei Medici del Vascello. Mio padre era un contadino. Visto e considerato che poi ci siamo trasferiti a Torino, alle Vallette, in Piemonte, io ho continuato le scuole e sotto la dittatura fascista, c’era il sabato fascista, dovevamo andare vestiti da balilla, poi da avanguardista, eccetera. Giunti all’8 di settembre del 1943, io ero di leva, avrei dovuto presentarmi alle armi al novembre del 1943. Rinunciai a presentarmi alle armi della Repubblica di Salò e cercai di arruolarmi, con dignità e scelta morale, nella lotta della Resistenza partigiana. Precisamente coi miei amici, compagni, ci siamo informati, abbiamo avuto delle informazioni come dovevamo fare. Ci siamo recati in treno con la Ciriè-Lanza da Torino e siamo arrivati a Pessinetto in Valle di Lanzo. Il comando ci ha presi in forza, sembrava a noi di respirare un’altra aria più pulita, più sana. Tutta la zona era controllata dai partigiani: da Lanzo, da Germaniano, tutta la vallata in su, in montagna. E lì abbiamo tribolato [sono cominciate le difficoltà, ndr] … ci han dato un posto su a Lanzeroldo, dove ci siamo riuniti una cinquantina di partigiani nelle baite, al freddo.
E poi, una volta registrati tutti i nostri nomi, al comando, ci hanno mandati su una frazione, a Lanzeroldo, un gruppo di cinquanta ragazzi. C’era anche qualche militare assieme, noi li chiamavamo i nostri padri perché erano più anziani di noi, ed erano già istruiti a usare le armi, mentre noi dovevamo ancora imparare. Però eravamo senza armi, aspettavamo sempre che ci mandassero… buttassero giù le armi gli inglesi, che si parlava, mandavano i messaggi con la radio allora inglese, mandavano dei messaggi “a Paolo piacciono le mele”: noi non capivamo, ma erano dei segnali; infatti, ogni tanto ci facevano accendere dei fuochi di notte, e aspettavamo i lanci e i lanci non arrivavano mai. Insomma, per farla corta, abbiamo tribolato tanto. Al 7 marzo io ero di guardia, di notte, perché li aspettavamo: eravamo avvertiti che dovevano venire su a fare il rastrellamento – la SS tedesca assieme ai repubblichini – dal comando CLN che si era ormai formato. E noi, lì, quando eravamo di guardia, facevamo turni di due ore; il mio turno verso il mattino era dalle cinque alle sette, difatti dovevo smontare alle sette meno un quarto [quando] c’era la colonna a fondo valle che veniva su, coi repubblichini davanti e i tedeschi dietro. Io ho avvisato i compagni che erano a riposo, dico: “Guarda che stanno arrivando”. Ci siamo messi ognuno al nostro posto di combattimento, e quindi abbiamo combattuto fino verso le due del pomeriggio. Poi sono riusciti a chiuderci a ferro di cavallo e ci hanno bombardato con due apparecchi, ogni tanto che venivano sopra a bombardare. Noi con quelle poche armi abbiamo fatto miracoli. E quindi dopo abbiamo indietreggiato su, dove c’era una chiesa che si chiama Bogliano [località in provincia di Torino, la chiesa è di San Bartolomeo, ndr]: lì non c’è stato più niente da fare, si salvi chi può. Chi è scappato prima è riuscito ancora a varcare il monte e passare dall’altra parte in Valle di Viù, e invece io, purtroppo, con altri, siamo rimasti presi nel cerchio e non abbiamo più potuto scappare. Ci siamo trovati alla sera, di notte, in un posto su in montagna, dove c’era anche il comandante. Eravamo senza mangiare, affamati, al freddo, c’era una baita solo: chi dormiva nella stalla chi nel fienile. Abbiamo passato la notte. All’indomani, oltretutto abbiamo dovuto andare a cercare da mangiare; hanno preso una mucca in una stalla dei pastori, l’han portata su, dove erano passati i tedeschi avevano bruciato i paesi, non abbiamo trovato le nostre provviste. Alla sera, dopo aver mangiato quella mucca, squartata in quattro e quattro otto e fatta bollire, il comandante dice: “Ho bisogno che qualcuno vada in Valle di Viù a vedere se ci sono i tedeschi”. Noi là eravamo in un angolo in alto in montagna che non si poteva vivere, e allora io – ero abbastanza pratico – sono andato con altri due miei compagni, siamo partiti per andare nella Valle di Viù: uno, posso fare il nome, un mio caro amico, Luca Castello Sergio, eravamo coscritti, l’altro, un certo Emilio, che era di Torino, adesso non ci sono più. E abbiamo attraversato tutta la costa, abbiamo trovato un cane impaurito sperso, l’abbiamo carezzato e ci è venuto dietro, e lo chiamavamo Dick. Quando siamo arrivati giù dall’altra parte abbiamo trovato una baita e ci siamo messi lì. Abbiamo aperto con tanta attenzione, abbiamo visto che c’era un fuoco, abbiamo acceso il fuoco per farci asciugare i panni e le scarpe. Al mattino, morti di fame come eravamo, abbiamo visto che più in basso c’erano dei pastori. Siamo scesi e siamo andati da questi pastori, abbiamo chiesto prima di tutto se c’erano i tedeschi e loro ci hanno risposto: “Sì, sono lì sotto al paese dei Tornetti, in Valle di Viù”. E allora abbiamo chiesto da mangiare. Ci han portato un po’ di polenta e latte, quelle cose che si fanno in montagna; noi con le mani l’abbiamo mangiata in quattro e quattro otto, e loro ci han detto: “Non andate giù, scappate su per la montagna perché vi prendono”. Noi con quel cane abbiamo attraversato dietro la casa per prendere la mulattiera che andava su in montagna. Loro erano già di dietro, ci hanno sparato e ci siamo messi per terra, abbiamo nascosto quelle poche armi che avevamo sotto delle foglie secche. Sono arrivati lì: “Vi arrendete?”. E noi abbiamo alzato le mani perché non c’era niente da fare: loro erano in sedici, noi eravamo in tre, disarmati, con un novantuno [fucile, ndr] non potevamo fare niente. Un repubblichino… Il cane si è spaventato perché avevano sparato, si è messo a scappare su per la montagna. Un repubblichino gli ha sparato al cane e l’ha ferito. Era lì che piangeva, il cane. Io ho sempre amato molto le bestie e… mi ha toccato quello, ma dico: lui ha fatto mica niente di male, è un animale! Perché? Pazienza noi, ma il cane cosa ne poteva? E così abbaiava, e lui è partito: “Adesso vado su e te lo finisco”. E lo ha ucciso. Primo segno di criminalità.
Poi ci hanno arrestato. Passa nel sentiero lì un repubblichino, mette il piede sopra il calcio del moschetto e il moschetto viene fuori… e lì è uscito poi dopo tutto il resto. Chiedeva di chi era questo moschetto. Ci ha messo davanti il plotone per fucilarci, per farci parlare. Noi parlare non parlavamo, non avevamo niente da dire, non sapevamo neanche chi erano i nostri capi, ecco. E da una parte è stato meglio così, e non potevamo dire niente. Quello che aveva il moschetto dice: “L’ho preso per la difesa della notte”. Io avevo le bombe a mano, ed erano le bombe a mano tedesche. Ha detto: “Cosa ne facevi di queste bombe?” “Cosa ne facevo, per la difesa della notte”. Insomma, li prendevamo ancora in giro così. L’altro aveva una pistola, idem. E quindi ci hanno poi portati giù al paese dei Tornetti, ci hanno picchiati a sangue. Poi hanno rubato le provviste dei pastori che avevano in casa, le donne urlavano, insomma c’è stato delle cose… Poi hanno preso i pastori per farci fare da guida, ci hanno portato a fondo valle. Arrivati in fondo valle c’erano le camionette e ci han caricati sopra, e ci han portati alle scuole di Lanzo torinese. Lì abbiamo passato una notte. Ci hanno picchiati, ci hanno fatto mettere con le mani contro il muro, ogni tanto passava qualcuno, ci dava delle pedate e degli schiaffi sulla testa, quindi torturati. Il giorno dopo ci han caricati sui camion e ci han portati alle carceri di Torino. Nel tragitto ci han fatto passare alla Veneria reale, poi ci hanno fatto fare Corso Regina, Porta palazzo, Via Roma, Porta Nuova: giro di propaganda per la città dicendo che avevano preso i banditi, noi ci chiamavano “banditi”. Poi Corso Vittorio. Siamo arrivati davanti al carcere di Corso Vittorio, Torino, ci hanno rinchiusi dentro nelle celle 10 e 15 nel braccio tedesco politico della Gestapo. Lì siamo stati interrogati, picchiati, malmenati, torturati. Insomma, sono ricordi purtroppo anche dolorosi. Nella notte, verso l’una, è suonato l’allarme, mezzanotte l’una, ricordo la prima notte che eravamo lì, c’è anche stato un bombardamento da parte degli americani oltretutto. Lì siamo stati fino al giorno 13 di marzo. Il giorno 13 al mattino assieme a noi hanno messo quelli che avevano arrestato ai primi di marzo per gli scioperi nelle fabbriche: la Fiat, la Spa, la Lancia, gli operai, uno sciopero più che altro di protesta contro questa dittatura. Oltretutto ce n’era già di politici che erano in carcere nella regione di Cuneo, di Saluzzo, nei dintorni e via dicendo. Ci hanno al mattino portati sotto, ci hanno caricati sui camion. Abbiamo percorso Corso Vittorio fino a Porta Nuova, dove guardavo io fuori da una parte dall’altra: ogni tanto c’erano la gente che ci guardava, madri di famiglia che vedevano noi ragazzi giovani, poi c’erano i loro mariti, che erano stati presi nella notte, arrestati nella notte perché avevano scioperato, e li chiamavano, chiamavano i loro mariti. Insomma, era un viaggio della tragedia proprio. Io queste cose me le ricordo bene. Siamo entrati nella stazione, c’era una tradotta che ci attendeva. Ci hanno caricati sopra quei vagoni dove fuori era scritto “cavalli 8, persone 40”, nell’angolo c’era una tinozza per i bisogni. E poi ci hanno fatto partire, alle quattro e mezza del pomeriggio siamo arrivati a Bergamo. A Bergamo ci han fatti scendere e siamo passati lì due tre giorni perché hanno concentrato lì quelli di Milano, che avevano arrestato nei pressi di Milano, specialmente alla Caproni, che erano allora, quelli che avevano scioperato, e quelli che erano contro… insomma. E poi da Brescia sono arrivati in diversi. Il giorno 17 ci han fatti partire, e siamo… Noi pensavamo che ci portassero in Germania a lavorare, come si sentiva.
D: Pio, scusa, ti ricordi a Bergamo, vi hanno messo dove?
R: A Bergamo ci hanno messo in una caserma che si chiamava Umberto I, della cavalleria. E lì c’erano dei genovesi, di Savona, c’erano milanesi. Io ricordo tanti nomi di Milano che sono stati con me, Carlo Annovazzi, ricordo Guido Bortolotto, ricordo tanti nomi, Ottolini, Malaguti che era di Torino e lavorava alla Michelin. Erano tutta gente molto più anziani di noi, che noi li chiamavamo i padri nostri, ecco.
Il 17 ci han fatti partire, inquadrati per cinque. Siamo arrivati di nuovo alla stazione di Bergamo. Ognuno portava con sé la sua tristezza. I padri di famiglia pensavano ai loro figli, e ci hanno fatto un discorso prima di partire, un ufficiale tedesco ha detto: “Voi adesso, vi porteremo tutti a lavorare per la grande Germania, per il nostro Fuhrer. E state attenti di non scappare perché noi abbiamo il vostro indirizzo e faremo rappresaglie sulle vostre famiglie”. Questo me lo ricordo benissimo, e l’ho anche scritto. Dopo… adesso non ricordo se siamo arrivati alla sera del 19, mi sembra, a Mauthausen. Dopo tutto il tragitto… Siamo passati per Tarvisio nel Friuli; ricordo che a Verona e a Casarza abbiamo buttato giù dalla tradotta dei bigliettini scritti, e difatti io ne avevo messo anche giù due o tre a casa mia. M’avevano detto che l’avevano ricevuto ma non me l’hanno mai fatto vedere i miei fratelli, la mia famiglia, perché quando ero arrivato sono successe delle altre cose che racconterò dopo.
Quel viaggio è stato molto sofferto da tutti perché noi giovani cercavamo di scappare, invece i padri di famiglia ci intimavamo di non farlo perché era pericoloso non solo per noi ma anche per la nostra famiglia. E quindi nel mio vagone almeno posso dire che nessuno è scappato perché non abbiamo avuto la possibilità. E siamo arrivati a Mauthausen. Quando siamo arrivati alla stazione, quello che posso ricordare dopo un viaggio sofferto e patito: di arrivare in una terra dove non capivi neanche a parlare, ti davano degli ordini in quella lingua che noi non conoscevamo e non capendo stavi fermo e loro ti picchiavano a morte. Un bel momento, scesi dal treno ci hanno inquadrati per cinque, in quell’attimo io… C’erano due, uno era un infermiere che lavorava all’ospedale qui di Torino, al Mauriziano, l’avevano arrestato perché portava una camicia di colore rosso. E quando siamo arrivati lì a Mauthausen, più avanti ha visto che c’era suo figlio, Afro, e l’ha chiamato. Si sono abbracciati e poi ha detto: “Ma guarda qui dove ci troviamo… Io nella guerra mondiale del ‘15-‘18 sono stato ferito e nell’ospedale in Italia [dove] mi avevano portato ho sentito dire che i prigionieri militari li portavano a Mauthausen, e adesso qui sono arrivato con mio figlio”.
Io con loro ho vissuto una storia, che l’ho anche spiegata. Insomma, ci hanno portati su a Mauthausen, dove abbiamo subito le pene dell’inferno. Arrivati lì dove adesso ci sono i monumenti, sia a destra che a sinistra c’erano le baracche delle abitazioni dei guardiani delle SS. Ci buttavano addosso dei catini d’acqua che usavano per farsi la barba, degli sputi, ci tiravano addosso qualsiasi cosa, ci chiamavano banditi traditori italiani, fascisti traditori, comunisti, tutti i nomi, e via dicendo.
Poi una volta che siamo entrati dentro ci hanno messo lì di fianco e un ufficiale tra il muro dove adesso ci sono delle lapidi e via dicendo, in attesa del bagno, della doccia.
D: Scusa Pio, partendo da Bergamo nel tuo Transport c’erano anche delle donne?
R: Io ero giovane allora, non ho potuto vedere le donne, non mi ricordo. Però so della gente, ad esempio c’è un avvocato che adesso non c’è più di Cuneo, Bonelli ad esempio, che l’ha anche scritto questo, che c’erano delle donne, mi sembra 17 o 30 non mi ricordo più, però io personalmente non le ho viste le donne. Non lo nego per carità, se l’ha detto è perché c’erano. Quando ci hanno messi lì in colonna per aspettare la doccia, un ufficiale ci ha detto che quel portone lì quando siamo entrati era la porta per entrare e uscire per andare a lavorare. Poi si è girato – sempre con quell’italiano mal parlato, qualche parola in tedesco – ha puntato il dito verso la canna del forno crematorio che allora non sapevamo neanche che cosa era, che fumava, e ha detto: “Quella è la strada per andare a casa vostra”. Queste sono le battute che mi ricordo bene.
E quindi poi di lì ci hanno svestiti. Quello che ricordo io, ad esempio, a me mi hanno spogliato sopra, dove adesso esiste una cappella cattolica. Allora era divisa in due parti: da una parte c’era le SS, blocco scrivani e via dicendo, e la prima parte era vuota, faceva freddo, nevicava. Ci han fatti salire lì e ci han detto: “Lasciate la vostra roba lì a terra, prima della doccia, oro, brillanti, tutto quello che avete lasciatelo nelle tasche, noi tanto abbiamo il vostro indirizzo, manderemo tutto a casa vostra”. Queste sono le cose che ricordo con tanta lucidità. E con memoria visiva.
Poi nudi ci hanno fatto andare sotto, sotto c’era una fila di Friseur, cioè barbieri, che con una macchinetta ci rapavano i capelli, e chi aveva la barba lunga anche la barba. Poi passavano il rasoio, facevano l’Autobahn, la Straße, in mezzo alla testa col rasoio. E poi prima di entrare nella doccia con un pennello ci disinfettavano da tutte le estremità superiori e inferiori, con dei liquidi che bruciavano da morire. Ho visto delle cose che non mi va neanche di raccontarle. Quando ci hanno spogliati c’erano degli uomini che piangevano. Diceva: “Era il regalo che mi aveva fatto la mia Rita”. L’altro diceva altre cose, e noi giovani non avevamo nessuno, io che cosa avevo? Il pensiero della ragazza, qualche cosa così, mi aveva regalato il maglione per andare nei partigiani. Tutte queste cose, le nostre cose care che ci tenevamo ci hanno spogliato. Avevamo… una catenina d’oro di poche lire, che mi aveva regalato il padrino della cresima e via dicendo, insomma tutti questi ricordi, ci hanno spogliati di tutto. Siamo stati nudi come mamma ci ha creato, dal ragazzo di 17-18 anni al vecchietto di 70 anni, eravamo tutti uguali. Noi non eravamo abituati a presentarci nudi e via dicendo, ne soffrivamo un po’ di vergogna.
Poi una volta passata quella famigerata doccia, coi bruciori infernali, nell’uscire ci han dato una camicia e un paio di mutande, di tela, e noi dovevamo indossarle immediatamente e poi prendere un paio di zoccoli che ci davano anche spaiati e metterle nei piedi e salire sopra al freddo. Sopra dovevamo aspettare almeno di essere in 100-150 prima che ci portassero via, e lì prendevamo freddo da morire, i primi malanni sono successi a quelle persone più deboli, subito, due tre giorni dopo.
Abbiamo fatto quattro giorni di quarantena con delle botte, trattamenti ingiusti, trattamenti infernali. In quella quarantena abbiamo sofferto perché arrivando da un paese che più o meno eravamo a casa nostra, di fatto una vita normale, trovandoci là, trattati peggio delle bestie: noi non avevamo più il nostro nome, ci chiamavano con un numero che noi non conoscevamo. Dopo quattro giorni di quarantena, maltrattati a morte – dormivamo per terra come le acciughe – il mattino ci hanno portato il vestito a righe con un berretto e ci hanno portati a Gusen I dove ci hanno messi in un campo a lavorare per costruire Gusen II. È stato un momento più massacrante, in quanto non abituati. Eravamo tutti sofferenti, dal contadino all’avvocato all’insegnante al professore, eravamo trattati tutti ugualmente. Poi la Pasqua. È arrivata la Pasqua.
D: Scusa Pio, l’immatricolazione di Mauthausen, ti ricordi il tuo numero?
R: Cinquantotto mila ottocento diciannove [58719]. E in tedesco venivamo chiamati con un nome diverso, perché… l’avessero almeno chiamato in italiano! A Gusen, quando il mattino era ora, ci portavano a lavorare dopo l’appello, in quei lavori di campagna, a spalare terra, spingere carrelli, lavori pesanti, sotto la pioggia, sotto la neve, nel fango. Ci chiamavano con un nome in tedesco che noi non conoscevamo, e allora loro ci giravano attorno, poi avevano delle gomme con dentro dei cavi di rame eccetera, e di piombo: picchiavano a morte. Se era uno un po’ robusto magari li sopportava, se era una persona già anziana piena di acciacchi il giorno dopo finiva al forno crematorio. Lo vedevamo steso nel Waschraum, cioè nelle latrine, in un angolo, alla sera, morto, con il numero scritto sul petto per traverso. Scrivevano con una matita copiativa, gli scrivevano il numero e lo scaricavano poi al forno crematorio che era morto. Succedeva spesso che tante volte, degli errori… che il capoblocco non l’aveva scaricato, l’appello durava delle ore per trovare lo sbaglio dove era andato a finire. E noi dovevamo restare sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto la neve perché c’era stato… Mancava due Stück! Perché noi venivamo chiamati “Stück”. Per esempio a Mauthausen le SS ricevevano degli ordini… Allora erano più di 40 sottocampi nell’Austria, di lavoro, dove ci mandavano noi, e gestiti dalle imprese, ad esempio a Linz ce n’erano tre: Linz I, Linz II, Linz III. Io sono stato a Linz I poi a Linz III. Quando le telefonavano di lì, che avevano bisogno di duecento… non dicevano duecento uomini, dicevano “zweihundert Stück”, in tedesco, duecento pezzi. Noi eravamo diventati dei pezzi, di lavoro, destinati certamente poi a morire e passare per il forno crematorio. Questo era il sistema nazista. Quando l’abbiamo capito era tardi. Tante volte ho pianto sulla piazza d’appello, quando vedevo impiccare poveri ragazzi perché erano stati messi a fare un lavoro che non erano capaci. Sbagliando, venivano considerati come sabotatori, impiccati sulla piazza d’appello davanti a noi tutti. Quante volte un padre ha visto suo figlio impiccato o il figlio impiccare suo padre, anche. Queste cose diverse volte le ho viste, e senza avere esagerato, solo dire quello che ho visto. Poi oltretutto arrivava la domenica nei sottocampi e loro dovevano avere un divertimento, le guardie delle SS. E loro per avere un divertimento, [a loro piaceva] vedere lo sport, il pugilato, e obbligavano questi detenuti a picchiarsi, addestrarli, poi alla domenica… Io mi ricordo uno che era di… Mugnaini, si chiamava di cognome, era di Firenze, era l’unico che aveva fatto il pugile nella sua carriera. Era del ‘15, ed era molto più anziano di me: io ero del ’24 quindi lui aveva nove anni più di me, io allora avevo vent’anni e lui ne aveva ventinove. L’abbiamo pregato, dico: “Fai te al posto degli italiani il pugile, se hai fatto il pugile!” Era magro, così, piccolino. Hanno cominciato a fare l’incontro a eliminazioni, nazione contro nazione, francesi contro italiani, polacchi contro francesi, a eliminazione così, russi, c’era tutta l’Europa lì ecco, c’è poco da dire. Davanti hanno fatto dello spazio, nella baracca davanti, c’erano tutti questi ufficiali e gendarmi delle SS che guardavano, eccetera. Noi un po’ fuori dai vetri guardavamo dentro con rancore a vedere i nostri compagni lì che si picchiavano per la bellezza… e anche questo era un sistema per eliminare…
D: Questo a Gusen I o anche a Mauthausen?
R: Questo che io racconto l’ho visto a Linz I. È un campo che dopo, verso la fine di giugno, è stato eliminato dai bombardamenti dove sono morti diversi prigionieri anche. Io per fortuna lavoravo di giorno ed ero in fabbrica, ci hanno fatto attraversare uno stradino, ci han portato sotto un rifugio. Da quel bombardamento lì mi sono salvato. Poi eravamo soggetti ai bombardamenti, continuamente, in quanto lavoravamo per costruire, dopo due o tre giorni arrivavano e bombardavano di nuovo. Questo era il sistema.
Quel sistema lì diciamo a Linz, dov’ero addetto al comando dello “Stallbau” [Baustelle, cantiere, ndr], dove si lavorava l’Hermann Göring, dove si costruivano i carri armati tigre, e io facevo il saldatore, lo Schweißer. Ero già meccanico, quindi di conseguenza è stata una sciocchezza per me da fare tornitore, conoscevo il disegno e via dicendo, lavoravo già al tornio, alla rettifica e tutto quanto. Per passare al ramo saldatura, era stata una sciocchezza in quanto ero già capace anche a saldare. E saldavo anche bene, mi sono guadagnato il posto da saldatore, lì all’Hermann Göring, facendo dodici ore di lavoro massacrante, di giorno una settimana e una settimana di notte.
D: Parlando di Linz I, il campo dov’era rispetto alla fabbrica?
R: Era proprio davanti al reparto, era vicinissimo, ci sarà stato cento metri. Il magazzino delle lamiere, finiva quasi al confine col campo, diciamo. Erano tre baracche, che l’ho disegnato anche sul libro [Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice – Memoria di sette lager, Dell’Orso, Alessandria, 1998] ho fatto tutti i disegni dei campi che sono stato, una di qua e l’altra di là e l’altra per traverso così… la terza era la cucina e il magazzino dei viveri.
D: Eravate in pochi come deportati.
R: Ah, sì saremo stati 700-800 forse, anche mille certe volte, ma non di più perché non aveva la capienza.
D: E a Linz I sei andato dopo Gusen I?
R: Sì, a Linz I sono andato dopo Gusen I. Poi da Linz I, dopo il bombardamento ci han trasferiti a Linz III. Linz III era un campo che era un po’ in basso dalla strada, un paio di metri, la strada andava leggermente in discesa. Appena entrati a sinistra c’erano le cucine, e poi in fondo c’era la piazza appello, a metà si girava una stradina a sinistra dove c’erano venti baracche. Quest’anno abbiamo trovato il sito, tramite una professoressa che vive in Austria, storica. Siamo andati con gli studenti, c’è anche la foto che mi hanno fatto, dove lì adesso ci sono più le fotografie dove esisteva questo campo con le venti baracche, come ho fatto io il disegno che mi ricordavo. E queste venti baracche erano tutte in fila, davanti allo stradino. Bisognava attraversare lo stradino per andare a fare i nostri bisogni alle latrine, o lavarsi. Erano delle baracche quadrate, ogni tre baracche avevamo questo servizio, diciamo. Però c’erano minimo 600 prigionieri [in] ogni baracca.
D: Linz I era vicino a Linz III o era molto distante?
R: Linz I da Linz III era poco distante, ci sarà stato tre chilometri di marcia a piedi, su per giù, che ricordo io. Però andavamo sempre a lavorare nella stessa fabbrica.
Quindi questo lavoro, fin quando sono stato a Linz III, è durato fin nel novembre… dopo il 20 di novembre del 1944, in quanto, penso, per mancanza… cioè i bombardamenti avevano quasi distrutto completamente l’industria bellica. Allora un bel mattino ritornando dal lavoro, dopo l’appello, sono entrati dentro degli ufficiali delle SS, con i gendarmi col mitra e hanno diviso… hanno selezionato i prigionieri, “links rechst, links rechts”, senza sapere cosa succedeva. Quelli che hanno mandato a destra li hanno mandati in baracca a dormire, quelli che han mandato a sinistra sono arrivati dei camion, ci hanno caricati sopra e ci hanno portati di nuovo a Mauthausen. Io in quel periodo lavorando in fabbrica avevo conosciuto dei militari italiani e avevo avuto modo di avere un piccolo quadernetto, qualche foglio di quaderno piegato, me lo tenevo in tasca, con una matita copiativa, dove mi prendevo degli appunti.
Avevo capito che andavamo a Mauthausen sul camion, e allora quegli appunti che vi avevo preso – ad esempio su tutte le memorie, nomi di compagni italiani e stranieri, le impiccagioni, chi avevano impiccato, le date, tutto tutto quello che succedeva – l’ho buttato dal camion perché avevo paura di… l’ho buttato dal camion, però mi è rimasto impresso nella memoria quello che avevo scritto, più o meno. Arrivati a Mauthausen ci hanno spogliato di tutto. Noi eravamo oramai… era otto mesi che avevamo i vestiti strappati addosso, pieno di pidocchi. Siamo di nuovo passati alla disinfezione, ma questa volta invece di usare il pennello ci hanno buttati dentro una vasca di creolina, cos’era, con la testa sotto, gli occhi bruciavano. Poi siamo passati alla doccia, ci hanno dato un altro vestito. Il giorno dopo, assieme a tantissimi altri che erano arrivati a Mauthausen da altri campi, malandati di salute, deperimento, ci hanno portati a Mauthausen, ci hanno caricati su una tradotta e siamo arrivati a Birkenau. Destinazione ignota, nessuno sapeva dove ci portavano.
Siamo arrivati a Birkenau. Sul foglio della Croce di Arolsen [archivi di Arolsen, ndr] dice l’uno o due di dicembre, però a mia memoria siamo arrivati molto prima, qualche giorno prima… che poi le registrazioni venivano fatte anche dopo, questo è possibile che sia stato così.
Poi ci hanno mandati… Siamo arrivati lì, in quel grande lager, e ci ha impressionato per la grandezza, per quello che vedevamo. A sinistra c’erano tutte donne, che tiravano dei carri di patate di verdure, eccetera, la kapò e gli ufficiali che ridevano, e facevano frustare queste donne, come schiave, rapate a zero. E noi purtroppo avevamo già subito queste umiliazioni prima, ma capivamo che lì era ancora peggio. Poi lì passavamo davanti all’ufficiale, dottore, dicevano, delle SS, poteva anche esserci Mengele assieme, chi lo sa? [Josef Mengele, ndr], e ti davano una destinazione, links o rechts, sinistro o destro. Nessuno di noi poteva sapere cosa succedeva ad andare a sinistra o destra, ognuno di noi oramai abituati al trattamento avevamo già fatto il callo. E chi mandavano a sinistra, a me fortunatamente mi hanno mandato a destra. Finita la selezione ci hanno mandati un po’ distanti di qualche chilometro, in un posto dove ricevevano i prigionieri, e lì siamo passati prima di tutto alla spoliazione, poi ci han fatto il tatuaggio sul braccio. E quello che io ricordo… c’era l’ufficiale che teneva la lista in mano del trasporto e con noi c’erano anche degli ebrei, specialmente ungheresi perché si distingueva dal modo di parlare. E gli ebrei li avevano scelti, andavano a farsi immatricolare in un’altra fila, e venivano immatricolati qui sopra [indica la parte esterna dell’avanbraccio, ndr], mentre gli ariani venivano immatricolati di qui [mostra il tatuaggio, all’interno dell’avambraccio sinistro, ndr]. Questo quello che ricordo io… difatti io non ho mai visto – sono stato assieme a tanti ebrei – non ho mai visto un ebreo immatricolato da questa parte [indica l’interno dell’avambraccio, ndr].
Questa è stata una memoria che ho sempre portato avanti, che poi dopo è venuta fuori… Nel momento, quando siamo tornati, non potevamo raccontare queste cose, perché nessuno ci credeva.
D: Pio, due cose: quando sei arrivato ad Auschwitz II, a Birkenau, il treno è entrato dentro nel campo?
R: Sì, sì è entrato dentro, si è fermato dentro, fino in fondo. Ha fatto una grande curva molto grossa, perché arrivava diritto così, poi ha fatto una grande curva così, è entrato dentro al lager fino in fondo, là c’erano due o tre binari… Arrivavano continuamente i convogli. Io mi ricordo che alla sera, era già notte, finita la doccia e l’immatricolazione… perché prima ci hanno immatricolati, poi ci hanno fatto fare la doccia, c’hanno detto che questo [il tatuaggio] doveva asciugare, di non fregare col dito, sennò erano botte.
D: La seconda cosa è proprio l’immatricolazione. Tu ti ricordi? Te l’hanno fatta in piedi… seduti..
R: In piedi in piedi. Così, mi hanno fatto mettere il braccio così, appoggiato a qualcosa lì, e il prigioniero era da quella parte lì che scriveva, difatti [indica il numero tatuato, ndr]. Poi c’era quello che era più abile che lo faceva meglio, si vede che chi l’ha fatto a me era uno specialista, poi ce n’era degli altri che lo facevano più rosso e via dicendo. Perché erano tutti prigionieri che facevano quello, non erano…
D: Tutti deportati.
R: Tutti deportati! Ognuno aveva un compito ben preciso, anche ad esempio – che poi si è saputo dopo – in zona del comando, che erano addetti a fare quel lavoro lì, dei forni crematori, no, tirare fuori i cadaveri dalle camere a gas: erano tutti prigionieri. Figuriamoci cosa provavano in quel momento. Oltretutto potevano avere una vita di due o tre mesi, non di più, perché poi li cambiavano, non ci dovevano essere testimoni che raccontassero queste cose. Era una cosa studiata a tavolino, perfettamente, perché lo sterminio lo facevano fare dagli stessi prigionieri.
D: E tu a Birkenau quanto tempo sei rimasto?
R: Poco, diciamo tre o quattro giorni per la quarantena in una baracca, poi il primo trasporto che c’è stato hanno chiamato il mio numero e a piedi ci han trasferiti a Auschwitz III, cioè a Monowitz.
D: Il tuo numero di Birkenau qual è?
R: Duecentouno mila cinquecentosessantuno [201561]. In tedesco veniva chiamato diversamente: zweihundert[ein]tausend fünfhunderteinundsechzig. Ho dovuto anche memorizzare, oramai la numerazione la conoscevo già abbastanza bene, perché se uno non capiva cosa succedeva quando ti chiamavano il tuo nome… perché noi eravamo solo che dei pezzi, non eravamo più creature umane, quindi botte da orbi. Lì ci avevano preso in giro strada facendo. Ci raccontavano ogni tanto sorridendo le SS: “Arbeit [kochen]?” Cioè, di voi chi è capace a fare il cuoco? Tutti eravamo capaci a fare il cuoco in quel momento. Loro ridevano, ce l’avevano detto apposta, perché ci avevano promesso che ci mettevano tutti a lavorare a far da mangiare in cucina o pelare patate. Strada facendo eravamo abbastanza contenti. Poi quando siamo arrivati là, la tortura del lavoro… Ci han messi in un campo dove dovevamo spalare terra nel gelato, battere tutto il giorno nel ghiaccio… perché lavoravamo a venti gradi sottozero, ventidue, diciotto d’inverno, tanto di quel freddo, ogni tanto moriva qualcuno. Scaricare vagoni di cemento sfuso. Quando era mezzogiorno noi avevamo la gamella attaccata alla natica del sedere, perché dovevamo avere la gamella per prendere quella brodaglia che ci davano a mezzogiorno. Ci facevano uscire dal vagone impolverati e non sembravamo neanche più persone, avevamo il cemento incollato dappertutto… e la gamella figuriamoci: secondo loro noi avremmo dovuto mangiare quella brodaglia nel cemento, e allora cercavamo – fortunatamente c’era la neve – prendevamo la neve da sotto i piedi e ci pulivamo la gamella, così, e poi con il gomito l’asciugavamo un po’, la pulivamo come potevamo. Eravamo sempre sporchi, luridi, perché non avevamo mezzo di cambiarci. Oltretutto dovevamo lavorare sotto la pioggia, sotto la neve. Insomma, è stata una cosa che a raccontarlo non sembra vero, eppure io sono ancora qui a raccontare queste cose. Mah!
D: Questo a Monowitz?
R: Sì, a Monowitz.
D: Alla Buna?
R: Sì, alla Buna. Portavamo delle travi quando non ci facevano spalare il cemento sfuso, portavamo delle travi di cemento armato a una impresa che montava dei piccoli capannoni, bassi capannoni, per la IG Farben. Queste travi erano pesanti, di cemento armato, dovevamo portarle a spalle, e io ero assieme a quattro o cinque italiani che erano friulani. Mi ricordo benissimo, tre erano friulani, uno era il padre, e altri due erano i suoi figli, due fratelli. Quando prendevamo queste travi sulle spalle – il padre era più alto, era uno molto alto, magro, per forza era magro, poverino, soffrivamo tutti la fame – ogni tanto si sentiva più peso addosso e noi non ci arrivavamo tutti a… Si sentiva stroncare, e allora nel dialetto friulano diceva: “Ostrega Bettin, te m’accoppi, te m’accoppi”, e noi facevamo tutto il possibile per arrivarci su, e lui si abbassava e il figlio gli diceva: “Abbassati papà, abbassati papà, dacci dai più peso a noi!”. Lui poverino faceva in modo di… Abbiamo sofferto le pene dell’inferno, cose che nel mondo purtroppo ogni tanto se ne sente ancora, sono cose vergognose.
D: Pio, il campo di Monowitz, le baracche eccetera, rispetto al luogo di lavoro, era distante? Dov’era?
R: Diciamo, abbastanza distante, sì, non erano vicine. Tanto è vero che noi dovevamo fare una strada nel ghiaccio dove a gennaio, nei primi giorni di gennaio, ogni tanto vedevamo già delle colonne di tedeschi che si ritiravano, e sentivamo già i cannoni a suonare il fronte che era vicino, magari sarà stato cento chilometri, chi lo sa. Noi non potevamo sapere niente.
Ma quello che più ricordo lì, poi alla fine quando ho dovuto… posando una trave per terra, con questi miei compagni di lavoro, mi è andata sul piede destro, che mi ha marcato il piede per tutta la vita. Fortunatamente nel ’97 ho poi trovato un dottore francese che è riuscito a mettermelo a posto, con un intervento. Ho sempre portato delle scarpe con tre numeri in più se no non potevo camminare. Sono stato colpito su questa trave di cemento armato, ho sofferto le pene dell’inferno per arrivare la sera a casa, cioè a casa… nel campo di concentramento. Non potevo più camminare, sorretto dai miei compagni, perché io non mi arrendevo, avevo coraggio, mi facevo coraggio, mi facevo forza. Dopo, quando sono arrivato in baracca mi hanno mandato a Revier, cioè al “kabè”, lo chiamavano “kabe” l’ospedale. E lì l’infermiere o il dottore che mi ha preso in cura mi ha medicato i piedi, tutti e due perché anche il sinistro era un po’ colpito ma solo sull’alluce, invece il destro era molto rovinato. Io temevo che fosse rotto, e allora quando me l’ha fasciato poi con della carta e tutto, mi ha detto qualcosa in polacco che io non ho capito, e io dicevo: “Nicht verstehen”, parlavo in tedesco, “non capisco”. In polacco qualche parola la capivo, ma dicevo che non capivo. Lui è andato fuori poi è tornato dentro con uno che parlava bene l’italiano, un prigioniero come me, e quando è stato lì m’ha detto:
“Sei italiano?”
“Sì”
“Di dove sei?”
“Di Torino”
Mi ha guardato.
“Sei ebreo?”
“No, sono cattolico”, ho detto la verità, avevo il triangolo”
“Mi ha detto il dottore di dirti che non c’è niente di rotto, però ti tiene qui due tre giorni perché non puoi camminare, col piede che hai, va a finire che…”.
Difatti mi ha dato un posto per dormire tutto per me. Ho dormito due o tre giorni, giorno e notte, quando era ora della zuppa me la portavano, i primi due giorni. Due giorni dopo andavo alla medicazione, nel corridoio ho incontrato questo italiano. La curiosità di entrambi… ci siamo incontrati con lo sguardo, ci siamo salutati e poi gli ho detto a lui:
“Ma tu di dove sei?”
“Anch’io sono di Torino, sono ebreo, sono stato arrestato in montagna, e adesso mi trovo qua. Fatti coraggio – m’ha detto – vedrai che tutto finisce presto.”
È finita così, al 17… al 16 sono uscito nel pomeriggio dal kabè, con il mio piede fasciato, avevo avuto la fortuna di avere un paio di scarponi ancora in buono stato. Al 17 siamo partiti, almeno almeno la metà dei prigionieri che eravamo lì. Ci han fatto partire per l’evacuazione del campo, ed ecco perché… io che avevo questa memoria, non ho mai scritto, avevo tutte queste memorie, e raccontavo ogni tanto e nessuno ti dava retta, un bel momento ho scritto. Nel 1986 incontro nel congresso a Torino Primo Levi, ci mettiamo a parlare. Ho detto che c’ero anche io lì alla Buna, ci siamo abbracciati. Gli ho fatto vedere la matricola, gli ho spiegato quell’affare del kabè, e lui mi ha detto: “Ma io mi ricordo: eri te quel ragazzo?”, dico: “Si ero io”. E allora tutte queste memorie un bel momento… Io ho conosciuto un professore, tanto caro, che mi ha aiutato a realizzare queste memorie, e penso che ne valga la pena. Perché anche poi dopo nel tragitto della marcia della morte, tutti quelli che sono morti uccisi per le strade, prima li caricavano su delle slitte, le troike chiamate, li buttavano lì come dei sacchi di patate. E poi han fatto delle fosse comuni, andando avanti li buttavano dentro, li seppellivano lì. Queste cose sono rimaste, sono ancora là da vedere adesso, le abbiamo trovate.
D: Pio, ma quando voi avete evacuato la Buna, Monowitz, a piedi vi hanno messo?
R: Sì.
D: Diretti dove?
R: Noi non potevamo sapere dove eravamo diretti, era una destinazione ignota. Sapevamo che ci portavano all’interno della Germania – potevamo pensare – però nessuno sapeva di noi. Il giro che ci hanno fatto fare, i chilometri. So che abbiamo camminato tanto, tanti sono morti per sfinimento, li hanno uccisi, che non potevano più camminare. E poi siamo arrivati al 19 notte sera, siamo arrivati a Gliwice, a Gleiwitz. A Gliwice c’era un piccolo campo già evacuato, ci saranno state dieci o dodici baracche, noi eravamo novemila o diecimila, chi lo sa, dalla colonna che eravamo eravamo in tanti. Arrivati a Gliwice eravamo molto, molto di meno. Siamo entrati in quel campo, i primi che sono entrati nelle baracche ci sono rimasti, ma eravamo in tanti e non c’era posto per tutti e molti siamo rimasti fuori. Qui dovrei raccontare delle storie che sono molto pesanti. Al mattino del 21 di gennaio si sentiva una locomotiva fuori nelle vicinanze, che si muoveva, e poi rientrato nel campo il comandante con le SS e i gendarmi ci hanno spinti tutto in fondo al campo, così ammassati. Poi ci hanno obbligato a passare dietro le baracche e il filo spinato, c’era un corridoio di un metro e mezzo così, o neanche, in fila indiana. Quando arrivavamo all’ultima baracca, davanti c’era il comandante delle SS e gli ufficiali che scartavano: “Links rechts”. Loro lì decidevano chi poteva ancora sopportare un altro viaggio in tradotta o chi era oramai alla fine. Chi era alla fine lo mandavano in mezzo alle due baracche che c’erano in fondo. In mezzo alle due baracche c’era già… un po’ di prigionieri lì, io adesso non posso fare il numero perché è difficile. Quando passo io lì, con un piede un po’ zoppicando, si vede che loro han detto “questo qui bisogna eliminarlo”, e mi han mandato a sinistra. Io sono andato a sinistra. Oramai ero stanco, non ne potevo più, sfinito, non me ne importava più di morire. Oramai ero rassegnato. Ero lì, con gli altri: chi piangeva, chi borbottava, ognuno diceva la sua. Un bel momento il mucchio è diventato grande. Quando è diventato grande alcuni cercavano di scappare e le SS coi mitra sparavano nelle gambe. Qualcuno è stato ferito, piangeva, urlava. Era una cosa tremenda, raccontarlo proprio come l’ho vissuto non si può. A un bel momento, quando ero lì, trovo un altro italiano che conoscevo già da Mauthausen. Si chiamava Pasquale, lui era di Latina, aveva subito il trasporto mio, la stessa trance, diciamo. Ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, e lui fa: “E’ finita. Andiamo in baracca prima che… prima di morire, che tanto qui fa freddo”. Faceva un freddo terribile. Ci siamo seduti su un pagliericcio, di quei castelletti a tre piani. Davanti a noi, abbiamo guardato, c’era una divisa da prigioniero francese, col triangolo francese, e l’abbiamo guardato e abbiamo detto: “Ma tanto a noi non ci serve neanche più a fare le pezze da piedi, cosa la prendiamo a fare?” Eravamo lì così. Ci siamo abbracciati, abbiamo pianto, abbiamo fatto di tutto. Poi un bel momento arriva un ufficiale. Prima, in tedesco, ha detto “Kommandant”, perché là dicevano il Kommandant fuhrer, il comandante e poi dicevano sempre fuhrer. Perché qualcuno, quando io dico questo ride. Era così, là. “Il Kommandantführer ha deciso di graziare gli ariani francesi”. E allora Pasquale lì ha detto: “Porca miseria!”. Noi avevamo un ago nel bavero della giacca, e il coltello dalla parte del manico lo tenevamo molato per tagliare il pane o qualcosa. Abbiamo preso questi due triangoli, col coltello è stato un attimo, li abbiamo scuciti e poi li abbiamo cuciti sopra il nostro. Ecco perché c’è questo, vede? [mostra l’immagine del triangolo stampata sulla prima di copertina del volume Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette lager, ndr]. L’abbiamo cucito sopra. E poi, con la “F” lì siamo passati [mostrando] il braccio, la matricola così, davanti al comandante delle SS, e ci chiama: “Französisch?” E io ho risposto: “Jawohl”. Pasquale ha fatto così anche lui. E ci siamo salvati.
Di quel viaggio ci sarebbe da raccontare un mucchio di cose, ma è tutto scritto. Ci sono stati i francesi ebrei, che poi sul vagone si sono anche litigati un po’, per il trattamento che hanno avuto. Loro avevano ragione a dire: “Se uno deve morire deve essere sempre un ebreo”. Tanto è vero che Primo Levi ha detto che il giorno 18 era passato, negli ultimi dieci giorni – “Se questo è un uomo” – era passato un maresciallo delle SS per assicurarsi che nelle baracche ci fosse uno che facesse il capo, e ha messo un ariano perché non si fidava degli ebrei. L’ha scritto, l’ha scritto lui questo. E ha detto: “Il mattino del 18 è passato l’amico Albert a salutarmi perché partiva per l’evacuazione del campo”. Dice: “Ma, se qualcuno potrà un giorno scriverà la loro storia”. Sono passati cinquantasei anni, questo libro ha raccontato quella storia lì di quel trasporto… fine prima parte
D: Vi siete cuciti il triangolo sulla divisa e vi siete salvati così.
R: Sì.
D: E lì cosa è successo?
R: E poi visto e considerato che siamo stati fortunati a salvarsi, ci hanno messo nella colonna di quelli che venivano inviati nella tradotta. Siamo stati per la strada che stavamo facendo per andare alla tradotta dei carri scoperti, quelli di carbone, abbiamo sentito le mitragliatrici che sparavano e delle urla da non finire, perché li hanno uccisi tutti con le mitraglie. E quindi noi siamo rimasti – io e Pasquale – male, avevamo le lacrime agli occhi, strada facendo ci guardavamo solo così, non c’era più segno di… di niente. Arrivati dove c’era la tradotta, ci hanno fatto salire su dei vagoni molto alti da per terra, abbiamo anche tribolato, ci aiutavamo uno con l’altro. Eravamo 120 –130 per ogni carro, impiombati con pancia e schiena uno contro l’altro come le sardine. Verso sera la tradotta, quando è stata completata, è partita, ha fatto un fischio, poi pian pianino pian pianino, dopo un po’ quando è riuscita a prendere la velocità di crociera, nelle curve… questi vagoni nella curva… chi era in mezzo, cosa faceva… si piegava così e poi con la debolezza, dopo due o tre volte, cadeva sotto i piedi dei compagni e non riusciva più alzarsi perché gli altri si allargavano, e molti sono morti anche così. Il giorno dopo, dopo 24 ore, alla sera, ci hanno fatto fermare in un posto di campagna, e abbiamo scaricato i cadaveri, li abbiamo messi in un vagone dietro dove ce n’erano già degli altri. E poi il viaggio è continuato. So che siamo arrivati… per tutto quel tragitto, ogni tanto in certi vagoni – nel mio non mi ricordo che sia stato fatto quello – ma molti aspettavano che arrivasse la notte, poi i cadaveri li buttavano fuori per farsi più spazio loro. Io mi ricordo che quando sono arrivato a Buchenwald, nel nostro vagone avevamo da una parte i cadaveri impilati, a triangolo così, da una parte e dall’altra, li avevamo accantonati lì e quelli che erano lì vicino ai cadaveri si erano seduti sopra, per riposarsi. Siamo arrivati al 26 del mattino a Buchenwald. Una tradotta che era lunga – anche Beppe Berti ha detto che non si ricordava in tutta la storia di Buchenwald una tradotta lunga così – entrata nel campo, ci hanno fatto scendere e abbiamo aspettato anche due giorni per passare alla disinfezione. Tanti morivano di freddo, allora in quattro lo prendevamo lo portavamo dentro: magari era ancora vivo, però lo caricavano sul carretto che andava al forno crematorio. E quelli che erano riusciti a passare e portare dentro il cadavere, invece di mandarli fuori, passavano subito alla doccia e alla disinfezione e via dicendo, e venivano mandati poi a destinazione nel campo nella baracca. Io con Pasquale – il nostro turno è stato verso dopo la mezzanotte – eravamo sfiniti. Siamo sempre stati assieme fino al momento della doccia, poi ci hanno divisi. Io non so più la fine che abbia fatto lui, se è andato al Revier, se fosse stato male. A me mi hanno destinato alla baracca numero 10, dove ho trovato poi un altro compagno di Torino che ci siamo fatti compagnia e che mi ha aiutato molto. Ho trovato Luciano La Rocca, della Sicilia. Era della Commissione segreta per la Liberazione, ma noi non lo sapevamo. Però ognuno aveva il suo gruppo e noi eravamo sotto il suo gruppo di Luciano La Rocca, io Prato ed altri, Fiori, Giovanni. Lì era un campo politico dove c’era una organizzazione clandestina. Si erano organizzati, c’erano delle armi nascoste. E sono rimasto lì fino alla Liberazione. Devo dire che sono anche stato un po’ protetto dal dottore triestino, Pecorari, al quale ogni tanto al mattino quando c’erano dei trasporti, mi mandavano al Revier perché io avevo una ferita qui da Linz [indica un punto dietro la spalla destra, ndr], quando ero stato ferito e poi per i piedi che avevo feriti. Mi hanno curato. In quei momenti lì, diciamo tra la fine di febbraio fino alla fine di aprile… cioè a marzo, c’erano di nuovo le evacuazioni, ogni tanto venivano dentro il campo le SS per far uscire dei prigionieri. Siamo arrivati a un punto che ce n’erano ottantamila. Li portavano nell’interno della Germania, Mauthausen o Dachau, chissà dove. E lì facevano altre marce della morte. E li facevano uscire dalle baracche con forza.
Io mi sono salvato due volte, le altre volte che mi hanno mandato in Revier mi è andato bene. Diciamo che io posso ringraziare anche la solidarietà che ho trovato dei compagni lì, a Buchenwald, altrimenti…
Ad esempio, Pasquale, che con me è arrivato lì a Buchenwald, poi si vede che è stato preso in un altro trasporto e poi portato a Mauthausen, è stato immatricolato un’altra volta, mandato a Gusen II dove morì mi sembra assieme a Caresio Andrea, il 21 aprile del 1945, pochi giorni prima della Liberazione.
Così ho avuto la fortuna di resistere fino alla Liberazione che è arrivata l’11 di aprile, dall’esercito americano, la terza armata comandata dal generale Patton. È l’unico campo che con la sua organizzazione segreta è riuscito a liberarsi da solo, perché temevamo di essere sterminati prima della Liberazione. Al mattino alle 10 e mezza, sono venuti due apparecchi a fare un volo sopra. Noi avevamo paura che fossero i tedeschi, che buttassero giù le bombe. Poi invece il secondo giro che hanno fatto a bassa quota, abbiamo notato che avevano le stelle bianche sui fianchi: abbiamo capito che erano gli americani e allora è stato un urlo: “sono gli americani, siamo liberi”, così. Poi stop.
Fuori qualche sparatoria, perché dal passo del campo avevano tagliato i fili, erano giù usciti qualcuno, dei più anziani. E invece all’una meno un quarto, io mi ricordo come fosse adesso, che il nostro comando con Luciano La Rocca e altri italiani, siamo usciti dalla porta centrale senza “Mützen ab e Mützen auf”, cioè berretto su berretto giù. Abbiamo capito che eravamo liberi.
Quando dopo l’una, l’una un quarto, l’una e venti, eravamo fuori è arrivata su la prima camionetta americana con il comandante Patton e dietro tutta la colonna, che ogni tanto si fermavano perché sotto a Weimar facevano la resistenza i tedeschi. Noi li abbiamo accompagnati un pezzo, loro ci davano dei biscotti, delle gallette, ci davano del cioccolato. Buttavano giù anche delle sigarette, ma noi… avevamo fame. Poi molti sono morti ancora dopo per la dissenteria, ci è voluto un bel po’ per mettere a posto il campo. Si sono dati da fare, diciamo, per la pulizia, per i pidocchi, per tutto.
Alcuni militari che venivano lì che parlavano anche l’italiano – perché erano figli di italiani [immigrati] in America, e ci parlavano in italiano – abbiamo fatto le fotografie assieme. Qui [nel libro citato sopra, ndr] ce n’è una dopo la Liberazione, fatta il primo maggio, eravamo già tutti gli italiani in una baracca assieme. Così era finita la nostra sofferenza. Però non avevamo la minima idea di quando poteva essere il nostro turno per arrivare a casa, in quanto ogni tanto andavamo a vedere, informarci dal comando, dicevano che le ferrovie non circolavano, i ponti erano saltati e bisognava attendere che gli americani dessero… Difatti, dopo tante tragedie e via dicendo, siamo poi riusciti con molta difficoltà avere un rimpatrio da Erfurt, verso l’8, il 9 di giugno. E siamo arrivati con molta fatica, passando da Bolzano, dove ci ha raccolto la Croce Rossa italiana e ci ha aiutati per il resto del tragitto, in quanto ha cercato dei camion dei mezzi di trasporto, dei corrieri che venivano a Milano. Siamo saliti sopra e ci hanno portato alla Croce Rossa di Milano. Poi quelli che dovevano andare giù al sud, si sono interessati di farli trasportare con altri automezzi. Noi che venivamo in Piemonte, a Torino, so che siamo arrivati a Torino su un camion di autotrasportatori, eravamo una quindicina di torinesi.
Però la tragedia non era finita, in quanto poi abbiamo sofferto: anche solo arrivando a Torino, nessuno ti credeva cosa avevi passato. Io mi ricordo un fatto. Arrivato a Porta Nuova, dopo tanta sofferenza, avevo il mio zaino, ero vestito con della roba usata, ma se non altro pulita, vestito militare americano, e avevo lo zaino con un po’ di porcheria dentro che mi ero portato via di là, dei ricordi. Aspettando il tram tutti mi guardavano con curiosità, eccetera: io ero senza capelli, avevo l’eczema, e certamente che ero da guardare, ero diverso dagli altri. Poi è arrivato il tram, il numero 13, sono salito sopra, e ho ancora avuto dei rimproveri da una donna, una signora, che diceva che “gente come me che puzzava non avrebbero dovuto prendere il tram”. Sa cosa le ho risposto io? “Signora – c’è anche scritto qui sopra [sul libro, ndr] – preghi di non avere nessuno in Germania come sono stato io, e se un domani avesse qualcuno che arriva lo abbracci, senza fare queste insinuazioni, perché io arrivo da un posto della morte”. Tutti gli altri che erano lì, m’han tenuto le parti, io ho solo dovuto stare zitto perché han pensato loro a tenermi le parti. Vede quando uno arriva da una tragedia del genere, che cerca di raccontare quello che ha patito e sofferto, e di essere incompreso, la ferita invece di chiudersi si apriva una volta di più. E per me è stato per molti anni, fin quando… Alla sera andavo a dormire e non riuscivo a dormire, avevo sempre quei ricordi, quelle parole crudeli in tedesco, le sognavo, e [sognavo] come mi avessero picchiato. Poi ho trovato una signorina, che poi è diventata mia moglie. Poco per volta mi sono formato una famiglia, ma quel tempo, la ferita si sarà rimarginata, ma mi è rimasto un segno profondo. E quindi non mi stancherò mai, mai… sia per quello che ho passato io personalmente, ma per tutti quei miei amici e compagni di lotta che hanno perso la vita per la libertà e la democrazia, e una pace che sia duratura.
D: Pio, ti ricordi il tuo numero di Buchenwald?
R: Cento ventitré mila trecento settantasette [123377].
D: Ecco, poi su Buchenwald ritorneremo ancora. Adesso vorrei ritornare un attimo alla Buna: il campo era molto distante dalle officine?
R: Diciamo, distante… io che posso ricordare, non era un’esagerazione perché andavamo a piedi, non eravamo portati con i camion o automezzi. Ci sarà stato quel viaggio di tre o quattro chilometri al massimo, o due e mezzo, io adesso a distanza di tanti anni è difficile calcolare proprio con esattezza. Non era molto distante, era lì nei pressi diciamo, che a piedi in quella mezz’ora tre quarti d’ora si andava e veniva, ecco. Perché noi lavoravamo fino alle sei di sera, alle sette c’era l’appello, quindi alle sette eravamo già in campo per l’appello.
D: Ecco, un’altra cosa, lì alla Buna c’erano dei civili a lavorare?
R: C’erano anche delle imprese che avevano del personale civile, e dei prigionieri militari. I civili polacchi cercavano di apprestarsi di darci aiuto, difatti ogni tanto ci lasciavano scorrere un pezzo di pane, lo buttavano a terra, e chi arrivava prima lo prendeva.
D: Pio, scusa, a Monowitz tu lavoravi alla Buna?
R: Sì.
D: Quindi quando dici le officine intendi la Buna?
R: La Buna, sì. Cioè… Io lavoravo in un cantiere dove stavano costruendo dei capannoni, dei capannoni di cemento. Portavamo il cemento, scaricavamo il cemento sfuso, facevamo delle buche, insomma, era un cantiere grande, che stavano ampliandolo per fare dei capannoni non alti ma bassi. E quindi lì c’era un po’ di tutto, diciamo, non lo so, perché… Poi lì, a Auschwitz III, che lavoravano alla Buna, nello stabilimento, c’era poi anche quelli che lavoravano nella chimica, come forse Primo Levi e via dicendo. Lui, la sua fortuna è stata che aveva una laurea e riusciva a farsi capire, a parlare abbastanza bene il tedesco, è stata la fortuna. Io purtroppo avevo… quando sono stato arrestato avevo un mestiere – e l’hanno anche scritto in tedesco, “Dreher”, Dreher vuol dire tornitore – e allora era un mestiere di prestigio il tornitore, ero un meccanico. Tornitore allora voleva dire conoscere il disegno, e fare tutti i pezzi per montare un apparecchio. Però da meccanico che ero mi hanno poi in ultimo destinato a un lavoro pesante, massacrante, di manovalanza.
D: Se tu ricordi, quando eri alla Buna, a Monowitz, potevate scrivere o ricevere lettere, o pacchi?
R: No, per carità, ma neanche per sogno! Io questo… Per tutto il periodo della mia permanenza di sedici mesi nei campi di sterminio, da Mauthausen fino alla fine, non abbiamo mai potuto scrivere a casa. Questa discussione poi l’ho anche intrapresa con Alberto Berti, che quando m’ha detto che lui scriveva e riceveva i pacchi da casa ho detto “Non bestemmiare, perché a me, a me non mi è mai successo, ma nessuno di noi, nessuno, nessuno ha mai scritto”. Per scrivere bisognava avere… non lo so, non ho mai potuto scrivere, ma nessuno di noi ha scritto a casa, noi italiani. C’erano qualche francese che potevano scrivere a casa, ma non tutti. C’erano i cecoslovacchi che scrivevano a casa e ricevevano i pacchi, c’erano i polacchi che scrivevano e ricevevano i pacchi, ma più tanto di lì… Per quello che so io.
D: Pio, Buchenwald, ti ricordi di aver visto delle donne o dei ragazzetti, dei bambini nel Lager di Buchenwald?
R: Sì dei ragazzetti, sì. Ultimamente, quando sono arrivato io, sono arrivati da Auschwitz, ce n’erano parecchi. Adesso non mi ricordo bene la baracca che erano, ma mi sembra la 17, dove c’era anche Sabatino Finzi, che lui per scherzo chiamava quella baracca “Hotel tre stelle”.
D: E anche delle donne hai visto a Buchenwald?
R: Io non ho mai visto le donne, non mi ricordo di aver visto donne, proprio sinceramente. Senz’altro ci saranno state anche delle donne perché ho sentito anche delle testimonianze di donne che sono state a Buchenwald, però se ci sono state erano chiuse in una baracca, dove ad esempio era anche morta la Mafalda e via dicendo. Io so che quello che ho sentito di Buchenwald l’ho sentito da altre persone raccontare, delle donne. Ma io personalmente, ero un ragazzo di diciannove anni quando mi hanno preso, ho compiuto venti e ventuno anni in quei posti, non mi ricordo di aver visto una gonna, una volta. Mai, mai.
D: E religiosi, ti ricordi se c’erano dei religiosi?
R: Religiosi sì, ce n’erano. Ad esempio, io mi ricordo a Linz I, che c’era un greco, un ragazzo greco di Salonicco, molto bravo. Ma non mi ricordo la religione che era, perché lui digiunava al giovedì… mi voleva bene, parlava correttamente l’italiano, lavoravamo come Schweißer, tutti e due nello stesso posto. Lui al giovedì mi dava la sua zuppa, e anche il pane. Io gli dicevo: “Ma avanzalo per domani” “No, a me la mia religione non me lo permette”. Ecco, questo me lo ricordo benissimo, non mi ricordo più il nome perché sono passati tanti anni, ma di questo ragazzo io mi ero scritto le memorie in quel memoriale che poi ho dovuto buttare via, e ricordo solo quello.
D: Vado a memoria, magari mi sbaglio: era successo a te che nel campo di Linz, ti eri avvicinato al reticolato, che c’era una SS sulla garitta che t’ha lanciato un pezzettino di pane?
R: No, ma non è così. Non è così. A Linz III stavamo noi italiani, era di domenica. Eravamo un gruppo molto affiatato che lavoravamo nello stesso comando, alla quale c’era uno di Bergamo, Obert si chiamava, come lo ricordo io, c’era Malaguti, i nostri padri anziani c’erano diversi. Poi c’eravamo noi giovani, e un bel momento abbiamo intonato una canzone, “Mamma”, e quando abbiamo cantato si sono avvicinati a noi i russi e i polacchi a cantare, ma cantavano nella loro lingua, facevamo la stessa tonalità. Finita la canzone, da quella garitta, un SS già anziano che era là – ha sentito cantare – ha detto: “Italiener, komm”. E noi abbiamo guardato, abbiamo sentito, abbiamo pensato a un richiamo ufficiale e ci siamo spaventati un po’. Poi questo bergamasco, Obert, che era di “Bergamo de hure”, diceva, [sopra, in dialetto, ndr], si è avvicinato, ha detto: “Bitte”. [L’uomo delle SS:] “Alles Italiener, komme. Singer!”. Dice: tutti voi italiani, venite qui sotto e cantate. Allora lui ha detto: “Venite che vuole che cantiamo una canzone”. Siamo andati là, eravamo una quindicina quel gruppo, e quando siamo stati là fa: “Cantate Mamma, Singer Mamma”. E allora noi abbiamo cantato la canzone “Mamma”. Abbiamo cantato la canzone “Mamma”, poi ci ha chiesto di cantare “Lili Marlene”, e noi gli abbiamo detto: “Nicht…”, “non la sappiamo”. E invece la sapevamo! In quella occasione, mentre cantavamo, io notavo le sue mosse, ogni tanto si asciugava le lacrime, e poi un bel momento ha preso uno di quei pani che aveva nello zaino e un pezzo di salame, l’ha avvolto dentro un pezzo di carta, e poi ha detto “Alles, teilt egal!”, cioè “un pezzo per uno, tutti uguali”, e ce l’ha buttato giù, e l’ho preso proprio io, così! Questo sì, è vero, è vero. Bisogna dire tutto, il bene e il male…
D: Da Birkenau alla Buna, vi hanno portato in che modo?
R: A piedi, a piedi. Sono sette o otto chilometri mi sembra. Siamo andati a piedi, abbiamo sofferto il viaggio perché faceva freddo, eravamo male equipaggiati, e quindi era stato molto duro.
D: A Buchenwald, tu eri presente quando hanno fatto entrare nel campo la popolazione di Weimar?
R: Eh, eh, eh, porca miseria se ero presente! Però non ci hanno mai inquadrati, ci hanno messi distanti noi, eravamo là… Allora non portavo gli occhiali ma avevo una vista da fenicottero, vedevo bene e li vedevo che ogni tanto… loro cercavano di guardare da un’altra parte. E poi alla domanda che le facevano “Ma voi lo sapevate che tutte queste cose…” e loro rispondevano che non erano al corrente di niente. Ma l’hanno sempre detto, questo, perché… loro ci vedevano tutti i giorni nelle stazioni, a lavorare nelle fabbriche, attraversare il paese a piedi, maltrattati: si chiudevano magari in casa, o li incontravamo per le strade e via dicendo, tante volte i loro bambini ci hanno preso a palle di neve anche, quindi non possono dire che non ci vedevano. Ancora tanti anni dopo, dopo il processo di Norimberga, [durante] un viaggio che abbiamo fatto nel 1983, il primo viaggio che si sono mossi gli storici e via dicendo, abbiamo poi incontrato dei civili lì a Norimberga. Tramite un interprete tedesco che avevamo assieme, gli abbiamo chiesto se loro erano al corrente, loro hanno detto no, che non erano al corrente, che non potevano sapere. In realtà c’era una disciplina che faceva paura. Questo è vero, che c’era una disciplina che faceva paura, però non potevano dire che non sapevano, perché lo sapevano questo, era impossibile che non lo sapessero. Lo condividevano, diciamo.
Poi, ritornando sul periodo della Liberazione, di Buchenwald, io ho un ricordo molto vivo in quanto l’11 di aprile, all’una meno un quarto, tre anni dopo ero già sposato. È nato mio figlio tre anni dopo, e l’ho preso in braccio io, e mi è venuta in mente la memoria di tre anni prima e gliel’ho detto a mia moglie. Non si può dimenticare quelle cose lì, erano cose fresche, di tre anni….