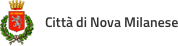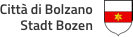Nota sulla trascrizione della testimonianza:
L’intervista è stata trascritta letteralmente. Il nostro intervento si è limitato all’inserimento dei segni di punteggiatura e all’eliminazione di alcune parole o frasi incomplete e/o di ripetizioni.
R: Mi chiamo Bergamasco Elvia, sono nata a Manzano nel 1927, il 18 agosto in provincia di Udine. All’età di 18 anni sono andata a lavorare in un campo di munizioni. Dopo un paio di mesi che stavo lavorando là, c’era già nella provincia di Udine la formazione di partigiani, una sera lì è venuto un signore che mia madre conosceva e ha chiesto se per piacere consegnavo una lettera a un capitano dell’aeronautica che stava lavorando in questo deposito di munizioni insieme con me.
Io lo conoscevo, ho detto di sì. Mia madre ha chiesto: Vediamo che cos’è” perché allora avevo 18 anni, e ai nostri tempi c’era molta severità. Mia madre ha letto, ha visto che era una lettera d’amore più che altro, era scritto: “Amor mio, ci troviamo alle cinque, alle sei si parte…” e tutte queste cose.
Era invece una lettera scritta in codice, l’ho scoperto dopo quando mi hanno detto che cos’era. Io sono andata al lavoro, ho consegnato queste lettere; un paio di volte l’ho fatto. Ho scoperto che c’erano i partigiani che consegnavano. Laggiù c’era questo capitano dell’aeronautica che lavorava lì e un maresciallo della Wehrmacht, un nobile di Vienna, non ricordo come si chiamasse questo maresciallo.
Queste lettere erano scritte in codice, nel momento in cui venivano trasportate nei camion delle munizioni, invece di caricare questi camion con delle bombe di cannone, si caricavano questi signori, anch’io delle volte, si caricavano munizioni piccole, bombe a mano, cartucce, queste cose.
Questi camion dovevano attraversare dei boschi, venivano trasportati in un altro deposito. Questi boschi erano quasi vicini al confine jugoslavo. Così c’era l’appuntamento. Queste lettere non so come poi venivano trasferite, fatte arrivare ai partigiani sloveni, loro scendevano, quando si trovavano tra questi boschi, lì prendevano le munizioni, si armavano.
Così abbiamo fatto un paio di volte dal mese di gennaio al mese di giugno. Un giorno i primi di giugno sono capitati con il camion delle SS e si erano spaventati un po’. Ho detto in Friulano: “Sono arrivate le cagne”, vuol dire è arrivato un macello, davano il nome alle SS. Cercavano soltanto me, erano tutti spaventati gli operai che erano lì naturalmente.
Invece sono arrivati nel capannone dove lavoravo io, sono venuti vicino a me, mi hanno chiesto se mi chiamavo Bergamasco Elvia, ho risposto di sì. Loro avevano una foto in mano. Mi hanno ordinato di seguirli. Mi hanno scortato, io lavoravo in fondo a questo campo, mi hanno scortato con un mitra davanti e uno di dietro. Mi hanno fatto salire su una specie di jeep tedesca, mi hanno portato a Cormons, una cittadina in provincia di Gorizia.
Lì ho trovato i miei compagni, chiamiamoli compagni, delle persone di una certa età che io conoscevo soltanto di vista praticamente.
Eravamo in sette/otto di noi, ci hanno messo in fila, hanno chiamato fuori il comandante. Difatti era il commissario della zona, del battaglione Garibaldi.
L’hanno chiamato fuori. L’avevano già percosso quando l’avevano arrestato. Sono andati a prelevarlo a casa durante la notte perché gli hanno detto: “Senti, sta per morire tua madre. Vai a trovarla”.
Lui è sceso dalle montagne, era su dalle parti di Castelmonte, nelle colline di Cividale. Lui è sceso a trovare sua madre, invece c’era la spia, c’erano già i nazisti e i fascisti lì ad aspettarlo.
Per salire su un camion bisognava appoggiare le mani perché il portellone non era stato tirato giù. Mentre saliva gli hanno picchiato con il manico del fucile sulle mani.
Poi lì ritornando a Cormons lui è uscito fuori quando lo hanno chiamato per nome, lì ho avuto il primo impatto con le cose che dovevano succedere.
Davanti a noi gli hanno tolto le unghie con le tenaglie. Però dalla sua bocca non è uscito un grido. S’è trasformato dal dolore, ben s’intende.
Poi finito il loro lavoro, ci hanno caricato su una corriera, ci hanno portati a Gorizia, nelle carceri di Gorizia. Nelle carceri di Gorizia siamo rimasti quaranta giorni. In una cella eravamo venticinque donne.
Si dormiva per terra. Gli animali che c’erano lì ci facevano compagnia durante la notte. Abbiamo subito cinque processi. Io fra tutte noi che eravamo sette, soltanto io non sono stata picchiata o torturata. Le altre donne le hanno anche psicologicamente tartassate anche negli interrogatori. Nell’interrogatorio non era che si continuasse a parlare come un libro aperto, perché magari quello che mi avevano chiesto il primo giorno me l’hanno richiesto il quinto giorno.
Poi abbiamo avuto la condanna a morte. Poi è intervenuto il Vescovo di Udine e una Baronessa austriaca che abitava nel paese dove abitavo io, a Manzano. L’hanno tramutata nei lavori forzati.
Poi dopo quaranta giorni, un giorno è venuta una chiamata di prepararci che si andava a lavorare in Germania. Il nostro trasporto è un po’ anomalo anche perché veniva dall’Ungheria, avevano caricato sloveni, ungheresi, tutta la gente dell’est, ragazzi, donne, bambini.
Ma hanno bombardato, stavano bombardando in Ungheria, il nostro treno lo hanno dirottato verso Trieste, così hanno fatto i carichi prima a San Sabba, poi a Gorizia, poi alla volta di Udine. Poi siamo partiti alla volta di Tarvisio. Siamo partiti.
D: Eravate in tanti sul tuo Transport?
R: Sì. Quando ci hanno fatto salire sui carri bestiame, ci siamo guardate in giro. Eravamo tutte in piedi, ammucchiate. Quando abbiamo avuto il tempo di contarci eravamo in centoventi donne. Ce n’erano anche che venivano da Trieste sul nostro carro bestiame.
C’erano delle donne, ragazze anche, che le avevano torturate a San Sabba. Abbiamo chiesto loro cosa avevano fatto. Loro ci hanno raccontato che avevano messo loro l’elettricità nei capezzoli e nel di dietro e poi delle torture psicologiche.
Abbiamo viaggiato dodici giorni. Su questo carro bestiame c’era un po’ di paglia e due mastelli. Uno pieno di acqua e uno per i servizi igienici.
Potete immaginare, dodici giorni di viaggio senza mai aprire. Gli odori, le cose che erano lì. Il mese di agosto. L’acqua si spartiva un po’ per ciascuno, pianino.
Il mastello si svuotava soltanto durante la notte, quando il treno si fermava. Il nostro viaggio è stato lungo dodici giorni perché? Perché durante la notte fermavano la tradotta. Caricavano e scaricavano carne umana, delle persone.
Io penso che si siano fermati negli altri campi, a Mauthausen, a Buchenwald, Dachau, negli altri sottocampi. Si sentiva nel treno quando attaccavano e quando staccavano gli spintoni.
Finalmente dopo dodici giorni siamo arrivati dove si doveva arrivare. Mi ricordo una cosa. La stazione che ho visto, era scritto in una lingua che non capivo, ora lo so che si chiama Oswiecim, siamo scesi allo scalo merci. E’ stato il nostro l’ultimo trasporto che è sceso a Oswiecim.
Dopo dodici giorni si sono aperti questi vagoni. Ci hanno investito con un gran fascio di luce. Si sono sentite molte urla in lingue che non si capivano e un grande abbaiare di cani.
Gridavano: “Schnell, Los, Los, Los”. Abbiamo capito che si parlava polacco e tedesco. Poi altre lingue forse. Gridavano di scendere in fretta, in fretta, di scendere in fretta. Lì siamo scese, ci siamo girate, ma quante persone sono rimaste su quei carri, non si sa il numero.
So che eravamo una marea di gente. Il treno era talmente lungo tra bambini, donne, anziani, uomini; chi gridava, chi cercava la madre, chi cercava il figlio, la moglie, “Dov’è mia moglie…” Però con le urla dei nazisti s’è fatto tutto un silenzio, questo abbaiare di cani anche.
Poi hanno cominciato con l’ordine secco di metterci in fila per cinque. Poi mentre si passava dicevano: “Questo sì, questo no”. In più l’hanno detto nelle lingue in modo da farci capire che chi era stanco, non poteva camminare o era anziano, poteva salire su quei camion che erano a disposizione lì.
Molta gente che era stanca ha detto, vado col camion, faccio più presto. “Ma è qui vicino”, dicevano. Poi hanno cominciato a fare due file, una a destra e una a sinistra. A sinistra venivano gli anziani, i bambini che venivano strappati dalle braccia delle madri. Dovevano andare con la fila degli anziani o con quelli che non stavano bene.
Poi ci siamo incolonnati e a piedi ci siamo camminati. Non potrei dire quanto tempo abbiamo camminato perché io non sapevo quanti chilometri… Siamo arrivati davanti ad un cancello con la famosa scritta: “Arbeit Macht Frei“, “Il lavoro rende liberi”.
Ci hanno detto che eravamo arrivati ad Auschwitz, nelle lingue, ognuno ha capito che eravamo ad Auschwitz. Eravamo stanchi, sfiniti, senza valigie, senza niente. In più ci scortavano lo stesso. C’è sembrato un po’ strano.
So di essere arrivata ad Auschwitz e di essere entrata in un gran capannone, lungo, fatto in mattoni. Lì dopo che erano entrate tutte le donne separate dagli uomini senz’altro, ci hanno dato l’ordine di spogliarci immediatamente.
Io non lo so, oggi come oggi di spogliarsi davanti a una bambina, a una ragazzina, una nonna, una madre, non lo so se riesce a capire la gente che cos’era a quel tempo. Poi qualcuna ha tenuto le mutandine, le sono state strappate in un modo talmente violento, cattivo. E’ difficile spiegare, dire che senso era.
Poi sempre in fila per cinque, nude, ci hanno fatto la prima cosa, ci hanno fatto un numero al braccio sinistro, il tatuaggio. Il mio numero al braccio sinistro è 88653. Poi sempre in fila per cinque, non era uno solo, erano in tanti, tante persone che facevano il numero, si andava in fila, poi si passava in un’altra stanza. C’era una vasca, si doveva mettere i piedi dentro.
C’era un’acqua bianca. In quest’acqua io credo c’era un disinfettante, un odore, come quello con cui si disinfettava una volta gli animali, la creolina si chiamava. Non so se si chiama anche adesso così.
Poi siamo passate alla doccia finalmente. Abbiamo detto: “Finalmente ci laviamo dopo dodici giorni”. C’e’ stata anche la rasatura. Ritorno indietro. Dopo il numero ci hanno fatto salire su degli sgabelli in fila, c’era una fila di sgabelli, anche lì una cosa realmente brutta è stata per noi.
Perché quando ci hanno detto di toglierci il vestito, di piegarlo, di metterlo bene, di toglierci gli ori, gli orecchini, le collane, quello che si aveva e di appoggiarlo lì perché ce lo avrebbero dato dopo, dopo aver fatto le docce, tutto.
Loro ci hanno fatto salire su questo sgabello, ci hanno guardato anche nei posti che non andava bene per vedere se si era nascosto qualche gioiello. E’ stato il primo impatto della vista schifosa della mia vita, chiamiamola così, è una brutta parola dire schifosa, ma era oltre lo schifoso questa cosa.
Poi ci hanno rasate dappertutto, ci hanno fatto alzare le mani, gambe al largo, ci hanno rasato i capelli e per tutto il corpo. Poi finalmente ci hanno portato alle docce.
Alle docce abbiamo detto, “Finalmente ci rinfreschiamo, ci laviamo”. Cos’è successo? Che ci hanno aperto l’acqua bollente, poi tutto in un momento, quando eravamo sotto che si gridava hanno aperto quella ghiacciata.
Poi tutto finito. Siamo uscite fuori nude com’eravamo. Intanto sono passate le ore, è venuta mattina, ci hanno consegnato il vestito, ci hanno dato il vestito zebrato.
Poi ci hanno incolonnate. Ci hanno dato la targhetta, da attaccare il numero sul vestito, il numero del braccio sul vestito ci hanno fatto mettere.
Poi inquadrate per cinque, ci siamo incolonnate, siamo partite alla volta di Birkenau.
D: Scusa, Elvia, con l’immatricolazione oltre al numero ti hanno dato qualche altra cosa?
R: No, no.
D: Vi hanno dato per caso anche un triangolo?
R: Ah, sì, il numero, si capisce, da mettere sul vestito e il triangolo rosso con la I e D. Voleva dire italiano, il triangolo rosso era segno di politico, che ero una deportata politica.
D: Parlavi di vestito. Oltre alla zebrata vi hanno dato biancheria intima?
R: No, solo il vestito e basta, senza biancheria. Niente, né mutandine, né camicia. Ci hanno dato le scarpe. Chiamiamole scarpe. Ci hanno dato gli zoccoli olandesi, quelli in legno, sopra e sotto tutti in legno. Di lì ci siamo incolonnate e siamo partite a piedi verso il campo di sterminio di Birkenau. Si trova a quattro/cinque chilometri di distanza da Auschwitz.
Siamo arrivate là. Era intanto mattina presto. Ci hanno messo in fila, ci hanno assegnato le baracche, ma non siamo entrate subito. E’ giunta l’ora di pranzo.
Ci hanno dato una qualità di minestra bianca, era come un gries, una cosa così. Ci hanno consegnato la Miska, la famosa Miska, la scodella. Non era nuova, era color mattone, erano in smalto, però erano vecchie, già tutte ammaccate.
Noi abbiamo detto: “In queste cose dobbiamo mangiare?” Eravamo un po’ schifate. Delle persone che erano lì già da un po’ di mesi, italiane anche, ci hanno detto: “Pregate Iddio che le avete voi, noi ce la siamo dovuta procurare”. Hanno risposto così passando: “Vi accorgerete presto quello che c’è”.
Ci hanno dato in queste scodelle, questo gries bianco l’ordine, in tutte le lingue l’hanno detto, che dobbiamo berlo, hanno gridato molto forte, di berlo senza mai lamentarci e tutto in un fiato, che se lo rifiutavamo, dovevamo pentirci molto, rimpiangerlo.
Infatti è stato proprio così, l’abbiamo rimpianto quel gries famoso, era un dolciastro schifoso, era cattivo da mandar giù. Poi s’è scoperto cos’era col tempo.
D: Che cos’era Elvia? Che cos’era?
R: Nel gries c’era bromuro. Il bromuro a cosa serve? A non far venire le mestruazioni alle donne. A quel punto, dalla rasatura al numero e avendo tolto anche questo, hanno tolto proprio la femminilità completamente a una donna.
Io dico sempre che la donna è stata molto più umiliata dell’uomo. Nel senso che… Io non so se era soltanto a Birkenau, le cose che sono successe a Birkenau in sei mesi, se ne sono viste moltissime.
D: Dopo ti hanno messo in baracca?
R: No, siamo state tutto il giorno in piedi fuori per cinque. Eravamo giovani, ragazze donne giovani, quarant’anni, cinquant’anni la più anziana del nostro gruppo.
Siamo state tutto il giorno. Verso le sei alla sera ci hanno fatto entrare in baracca. Le baracche sono fatte in mattone. Dentro nel muro delle baracche sono fatti i castelli. I castelli, non i letti che si vedono a castello, erano fatti di semimuratura anche quelli, con delle assi, a tre piani ben s’intende. Si doveva stare in otto per ogni piano.
Quando si girava una, si dovevano girare tutte le altre. Non si dovevano mai tenere fuori i piedi. L’ordine era che si dovevano avere i piedi interni nel posto da dormire.
Io ero al secondo piano, le nobili, le laureate le mettevano nel sotto, nella terra nuda a dormire. Per quello erano a tre piani, perché mettevano anche sulla terra nuda. Forse per farle umiliare ancora di più.
Quando si girava una, si dovevano girare tutte. Noi avevamo anche una ragazza incinta tra le nostre otto. Non si poteva stare nemmeno sedute, si doveva stare sempre distese o scendere giù. Erano talmente basse, c’era come un buco da infilarsi, nient’altro. Poi abbiamo scoperto che la sveglia era alle quattro la mattina, poi si usciva. Grida in polacco, in tedesco “Schnell, schnell, schnell”…
Si doveva in fretta e furia scendere da questi letti. Poi abbiamo fatto la scoperta del famoso Gummi. Il Gummi che cos’era? C’era un tubo di gomma con un filo dentro in rame e questo lo facevano girare tutto il santo giorno.
Siamo uscite fuori per cinque all‘appello, alla distanza delle braccia allungate una dall’altra si doveva stare. Lì siamo state dalle quattro di mattina, ci si alzava alle quattro.
Poi ci hanno portato ai famosi bagni, chiamiamoli bagni. Era una baracca con settantadue buche doppie. Si facevano i bisogni schiena con schiena. Fare in fretta, tutta la baracca doveva fare in fretta perché subentrava l’altra.
Col tempo, coi mesi che sono passati, dovete pensare che la dissenteria era facile e non si aveva il tempo per lavarsi. Non c’era l’acqua perché a Birkenau, se Birkenau è come adesso, era tutta una palude.
Queste strade, questi fossi sono stati fatti da noi prigioniere stesse, non solo io, centinaia e migliaia. Dico tante volte mentre penso ai ricordi, se ci fosse stato un elicottero a sorvolare, quando eravamo tutte all’appello, tutte rasate, con questo vestito zebrato, io non lo so quello che veniva, queste teste rapate di tutte le età. Una cosa…
Io a Birkenau non ho mai visto i bambini. Li ho incontrati solo una volta. Per tre giorni hanno fatto nella fila… Io non lo so. E’ stata una scelta proprio di questi bimbi che hanno portato lì. Nella nostra fila delle baracche c’era una distanza che vi si faceva anche l’appello.
Hanno fatto un serraglio con una rete. Hanno messo un trenta e più bambini, non lo so, praticamente. Però sapevano che questi bimbi erano figli di queste donne che erano in quella baracca.
Hanno detto alle madri, fatto capire che questi bimbi sarebbero stati trasportati a Cracovia, abbiamo scoperto di essere in Polonia, che li avrebbero portati a Cracovia dove sarebbero stati molto bene.
Queste madri… Ritorniamo indietro, il pranzo. Parliamo del mangiare. Di mattina ci davano un caffè, chiamiamolo caffè nero, da bere. A Birkenau era proibito bere l’acqua, assolutamente, perché veniva fuori l’acqua color marrone essendo una palude. Era proibito bere l’acqua.
La mattina ci davano un mestolo di questo caffè. A mezzogiorno ci davano un mestolo di rape grattugiate e bollite non so con quale acqua. Nemmeno le lavavano. Dopo col tempo abbiamo detto, la terra e la sabbia che si trovavano sotto erano la vitamina B, abbiamo detto fra noi.
La sera ci davano un altro mestolo di minestra. In più ci davano il pane. C’era un pezzo di pane. Loro lo chiamavano la strunza. Questo serviva per dodici persone. Veniva segnato con un dito mignolo, si facevano i piccoli segnetti, poi si tagliava a pezzettini.
Serviva per dodici persone, si segnava col dito mignolo, si facevano dei segnetti, poi si tagliava. Loro portavano il tavolino fuori le Kapò. Questo non ho detto. Cosa abbiamo trovato lì.
In questa baracca non so quante eravamo, non ci siamo contate, ma penso che eravamo in quante… Abbiamo fatto i conti tempo fa, eravamo quasi in quattromila. Hanno fatto i conti i ragazzi tempo fa quando eravamo ad Auschwitz calcolando in quante eravamo.
Avevamo le Kapò, le comandanti. Le Kapò erano tutte donne polacche. Erano delle persone della feccia più cattiva che poteva esistere in Polonia. Gli uomini uguali, i polacchi.
Non sentirete mai un deportato parlare bene dei Kapò, delle donne e degli uomini polacchi. Quelli che erano dentro come Kapò. Dovete pensare che la nostra comandante, la nostra Kapò aveva ucciso il marito e i due figli a coltellate.
D: Scusa Elvia, a proposito di figli, prima stavi parlando del recinto dei bambini.
R: Sì, giusto, scusa. Ritorniamo. Hanno portato i bambini in questo recinto. Hanno fatto capire alle madri che li hanno scelti realmente perché le madri ogni sera non mangiavano il loro pane. Il terzo giorno hanno detto che all’indomani i bambini partivano verso Cracovia.
Sono sgusciate fuori queste madri come dei serpenti, come delle bisce. La sera non si poteva uscire dalle baracche, era proibito. Loro sono scivolate fuori. Hanno consegnato a ogni bambino un pacchettino col pane che non avevano mangiato. Se questi bambini vanno là, così hanno per qualche giorno un pezzettino di pane in più.
All’indomani, il quarto giorno, la mattina presto… La mia baracca era nella terza fila delle baracche, la terza baracca. Sono venuti tutti tirati a lucido i capi delle SS, in nazisti, il comandante a capo del campo. Tutti sorridenti, tutti tirati a lucido, dei visi cattivi, quella mattina andando fuori all’appello non abbiamo trovato i bambini.
Si sapeva che erano partiti per Cracovia. Allora arrivano lì a fare la conta nella nostra fila, non c’entrava di venire nella nostra fila a far la conta, sono venuti lì realmente. Allora le madri hanno chiesto con l’interprete.
Hanno detto: “Madri, ricordatevi che i vostri bambini stanno bene, sono usciti per i camini”. Io non ho visto una lacrima sui volti di quelle donne, però ho visto i loro volti trasformati. Ho visto il dolore, realmente cosa vuol dire il volto di una persona che ha un dolore enorme.
Erano contraffatti. Hanno cambiato sembianze. E’ difficile capire, si sono scurite, gli occhi… E’ difficile spiegare come sono diventati i volti di queste donne. Non so se sono tornate o se sono rimaste lassù a Birkenau.
Raccontare quello che succedeva a Birkenau… Io purtroppo ho avuto la sfortuna di essermi ammalata due volte. Una volta mi sono ammalata, la seconda volta sono stata scelta. A Birkenau c’era il dottor Mengele, non solo lui, tutta l’equipe insieme, però lui era il capo di tutti, Mengele
La domenica dovete pensare che ci facevano spogliare nude con la scusa che portavano il vestito alla disinfezione e ci facevano passeggiare per cinque tutta la lunghezza del nostro percorso che avevamo da una baracca all’altra, nude tutto il giorno perché portavano alla disinfezione. Non so se è vero.
C’era il tavolino in fondo alla strada, c’era Mengele e tutti gli altri. Si marciava davanti a lui. Diceva: “Questa, questa, questa no, questa sì”.
Purtroppo un giorno sono stata scelta anch’io con l’ordine di darmi il vestito e di trasportarmi al campo B. Io ero al campo A appena all’entrata di Birkenau, c’è il campo A, poi c’è il campo B.
Sono andata al campo B. Al campo B c’era il blocco delle Krezze chiamato. Era il blocco delle malattie infettive. Era il blocco dove Mengele faceva i suoi esperimenti.
Lì io ho visto con i miei occhi le donne su cui lui ha fatto gli esperimenti. Col gran dolore, tutte le cose che lui faceva non le faceva con l’anestesia, assolutamente. Così queste donne erano anche impazzite, camminavano in giro su se stesse, nude completamente, facevano il giro.
Dentro nel campo B c’era un altro campo con una grande muraglia e un gran cancello in legno. Mi ricorderò sempre questo cancello enorme, non si doveva sentire né vedere niente.
Lì mi hanno fatto entrare in un’infermeria, chiamiamola così, Revier. In questo Revier mi hanno fatto spogliare, mi hanno dato su con un pennello delle qualità di colore. Uno verde, una pomata bianca col pennello che bruciava da morire.
Sono stata quattordici giorni, ogni giorno cambiavano colore e bruciava da morire. Stando lì questi quattordici giorni ho visto le donne, di cui altre compagne lì mie parlavano e raccontavano. Io chiedevo cos’è successo a quelle donne? Io ho visto delle donne bruciate davanti alla pancia e alla schiena.
Mi hanno detto che erano le donne che mettevano incinte, poi lui le faceva abortire con una piastra. Metteva una piastra davanti e una di dietro, poi attaccava l’elettricità, non lo so a quanti volt, so che queste donne erano bruciate. Per il gran dolore, le ho viste nude che giravano in giro per questo piccolo campo.
Poi ho visto le donne con gli sfregi nelle gambe, nei piedi, in altri posti, nel viso. Lì penso che sia stata… Io la lebbra non l’avevo mai sentita nemmeno nominare, ma credo che lì dentro ci sia stata anche quella.
Quando portavano da mangiare a mezzogiorno soltanto, portavano una volta al giorno, quel mastello non veniva portato, veniva gettato dentro e queste povere donne si buttavano sul mastello come degli animali.
Infatti eravamo diventati degli animali. Si buttavano, si picchiavano l’un l’altra. Con questa gamella che avevano, Miska, si davano giù per la testa, così si vedeva magari saltare un pezzo di naso, un orecchio, perché erano talmente piene di croste dappertutto per il corpo, perché avevano fatto degli esperimenti, delle cose che le avevano infettate tutte.
Lì sono stata quattordici giorni. Poi si vede che non hanno fatto effetto su di me, mi ha rispedita al campo A. Prima di uscire da questo grande cancello mi hanno detto in italiano di non raccontare mai a nessuno quello che avevo visto e sentito lì dentro.
Poi mi hanno accompagnata alla mia baracca. La mia Kapò quando sono arrivata quasi non mi voleva più. Invece si sono parlate con quella che mi ha scortata e ha detto che si vede che non avevo preso malattie infettive assolutamente, perché noi a Birkenau abbiamo fatto gli anticorpi grandi come il mondo.
Poi mi sono riammalata un’altra volta, credo che mi sia venuta la bronchite. Avevo un febbrone talmente alto. Io mi ricordo di essermi alzata, di essere andata fuori all’appello in fila e poi di aver gridato molto forte e di essere caduta.
Sono stata quattro giorni al Revier, mi hanno dato delle pastiglie. Sono rientrata dopo quattro giorni la sera dopo l’appello. Entrando nella baracca si doveva passare davanti alla Kapò.
Io ho fatto l’inchino perché bisognava inchinarsi e rispettarla questa Kapò. Non avevo fatto in tempo ad inchinarmi che mi ha dato, aveva un randello in mano come una mazza da baseball, mi ha dato tre randellate per la schiena che io non ho avuto il tempo di gridare. Hanno gridato le mie compagne che mi hanno sentito.
Il lavoro a Birkenau in cosa consisteva. Come ho detto prima, la sveglia alle quattro. Alle sei si partiva per il lavoro. Il lavoro. Veniva consegnato a chi il badile… C’era una carriola. Su questa carriola c’era il badile, il piccone e poi nel posto dove ci hanno accompagnato abbiamo trovato anche il rullo, quello con cui si batte la terra, la strada.
Questo a turno, quelle che facevano il fosso, questo fango che si faceva mentre l’acqua scolava, in questi fossi il fango che si toglieva con il badile si buttava per fare la strada. Poi col rullo passavano sopra.
Dieci spingevano e cinque tiravano. Lì si doveva tirare, per forza perché il Gummi volava a tutta forza sulle schiene. Quando c’era il turno invece dei nazisti, allora loro avevano un altro tipo di frusta. Avevano il frustino. C’era un manico in cuoio lungo, poi c’era un mucchio di cordoni in cuoio e loro quando passavano così senza dire niente davano giù. Non andava quella persona, le davano giù una frustata.
Poi le punizioni. Abbiamo subito noi delle punizioni che non avevano niente a che fare, che siano state comandate dai nazisti. Erano le Kapò stesse che ci facevano delle punizioni, loro proprio non c’entravano niente.
A Birkenau essendo una palude c’era il fango, quegli zoccoli famosi di cui ho detto prima ci sono durati tre giorni. Il quarto giorno sono rimasti lassù. Mi è venuto il turno di andare a prendere il caffè di mattina, sono andata. Mentre sono ritornata dalle cucine a prendere il caffè, lo zoccolo è rimasto là, si è aperto e poi ho camminato sempre scalza.
Lì a Birkenau ci facevano accovacciare con due mattoni o un pezzo di pietra con le mani alzate su così, oppure nel braccio ci facevano rotolare nel fango. Non c’era il posto per lavarsi. A Birkenau non abbiamo mai fatto una doccia, mai, non ci siamo mai lavate in nessun posto.
Forse l’acqua era proibita, noi abbiamo bevuto più di qualche volta essendo il mese di agosto/settembre. Bevuto anche quell’acqua che era nei fossi, non si badava a tante sottigliezze. La Nerina ha detto che lei non ha mai bevuto.
Io invece, noi con la mano si prendeva su. Si diceva una preghiera. Ai miei tempi si diceva: “Beve il serpente, beve Iddio, che berrò anch’io”. Si dicevano queste parole e si beveva l’acqua.
Purtroppo qualcuno ci ha chiesto quando si va nelle scuole se si pregava là. Io ho detto che abbiamo imparato le preghiere più belle che non esistono in nessun vocabolario. In meno di otto giorni abbiamo imparato le più belle che possono esistere su questa terra, tutto al contrario.
Queste funzionavano. Non so perché scattavano. Se una mia compagna mi toccava che cosa si diceva… Queste preghiere venivano a sfilza, una dietro l’altra e in tutte le lingue, queste parole si capivano in tutte le lingue, italiano, tedesco, ci sono centoventun lingue, però quelle lì si capivano in tutte le lingue.
Cosa devo dire? Birkenau cos’era? A Birkenau ci avevano tolto la parola. Il ricordo di Birkenau è come una nebbia. La nebbia a Birkenau si toccava con le mani, se la prendevi in mano la sentivi. Dovete pensare che a Birkenau c’erano dodici forni crematori, erano ventiquattro bocche, ne cremavano ventiduemila al giorno. Funzionavamo ventiquattro ore al giorno.
A Birkenau avendo fatto sei mesi, essendo al campo A, si vedevano tutti gli arrivi di quei carri bestiame che arrivavano di carne umana.
Si sentivano le grida, le urla ogni giorno e ogni notte. Durante il giorno scaricavano nella parte dove c’erano le baracche dei cavalli. A Birkenau avevano fatto i binari ed entravano direttamente fino vicino ai forni crematori. Di notte scaricavano dalla parte dove erano le nostre baracche.
Durante la notte si sentivano i pianti, le urla, le grida, chiamare mamma, chiamare la sposa. Quello che era successo a noi, così succedeva o di giorno, o di notte, arrivavano a tutte le ore questi treni.
A Birkenau c’erano più campi. C’era il campo A, il campo B, poi c’era la casa rossa, chiamata così. Che cos’era la casa rossa: Canada in principio serviva come primi esperimenti per le camere a gas. Poi hanno fatto i forni, le camere ingrandite servivano per deposito, dove venivano depositati tutti i vestiti e gli ori, la selezione.
In più c’era il parcheggio il Canada. C’è ancora un boschetto di betulle, venivano parcheggiati quelli che non riuscivano a portarli a forni crematori.
Quelli servivano per quando bombardavano, i treni non arrivavano. Allora andavano a prendere quelli, li chiamavano e venivano eliminati quelli che erano lì in attesa in questo boschetto, seduti lì aspettavano due o tre giorni.
Oppure durante la notte succedeva quando non avevano al parcheggio più nessuno, c’erano degli ebrei purtroppo, delle donne, loro sapevano che dovevano andare là ai forni, era il modo che chiamavano, perché dicendo io non dice quasi niente.
Chiamavano durante la notte: “Le Jude, le Jude”. Loro sapevano, si alzavano, toglievano il vestito, andavano davanti alla Kapò sulla porta della baracca, glielo consegnavano piegato, loro nude queste donne si mettevano in fila e andavano su al campo B dove c’erano i forni.
Loro sapevano di andare. Un’altra cosa. Siccome era tolta la parola, era tolto un po’ tutto, completamente la femminilità, non esistevi e basta, infatti in sei mesi si riesce a diventare come volevano loro. Si camminava, si sentivano gli ordini, secchi, imperiosi come si sentivano e si andava avanti.
Forse un animale si rivolta, invece ci hanno fatto diventare realmente… Forse era la vita stessa che lottava da sola, forse il tuo cervello o che non funzionava più, non lo so quello che ci avevano tolto, anche quello.
Si andava avanti come dei robot realmente. Il robot va con il clic, noi con le loro urla. Si andava avanti al lavoro, si ascoltava, ci si guardava in giro. Andando, facendo questi lavori di scavo, di fossi, è capitato che io sono andata tra la fine del campo A al campo B, adesso non c’è più lì a Birkenau, c’era più bosco.
Abbiamo visto le pire chiamate, le cataste delle donne morte, perché non riuscivano i forni a smaltirle, allora quelle che erano morte lì, le mettevano, ma le mettevano a regola d’arte una sopra l’altra. Questa catasta era ben fatta. Poi davano fuoco.
Noi abbiamo detto: “Oddio, ecco perché nevica a Birkenau fuori stagione”. Ci sono tante cose…
D: Quanto tempo sei rimasta tu a Birkenau?
R: Sei mesi. Dopo sei mesi nel mese di dicembre è venuto un gruppo d’ingegneri tedeschi a chiedere dei pezzi. Mi occorrono cinquemila pezzi.
Allora un giorno di mattina ci hanno fatto spogliare nude cinquemila donne, è stata fatta una selezione, ci hanno selezionate, ci hanno messo su una scalinata e ci hanno lasciato tutto il giorno lì. Era il mese di dicembre.
Noi siamo partite il 2 gennaio. Il 31 dicembre ci hanno messo su questa scalinata, siamo state tutto il giorno. Mi ricordo che c’era un termometro in fondo sul muro dell’entrata di Birkenau, grande era, rosso, mi ricordo di questo, che segnava dai 20 gradi in su, poi non si riusciva a vedere, sotto zero, eravamo già agli ultimi di dicembre.
Quando siamo scese la sera alle sei, quando ci siamo girate ne abbiamo lasciate molte là. Poi ci hanno dato il vestito, fatto rientrare in baracca. Credo che sia stata la minestra più buona, più calda che io abbia mangiato in un anno di campo di sterminio quella sera.
Abbiamo detto: “Siamo ancora vive”, abbiamo sentito il caldo della Miska. Una cosa, il dottor Mengele di domenica… Noi abbiamo calcolato che c’era la domenica, perché ogni quei tanti giorni, li abbiamo contati, si contava sette giorni e il settimo si riposava, si diceva, perché ci facevano spogliare e camminare nude.
Era il fatto che si doveva passare davanti al dottor Mengele, era il modo in cui lui ti toccava. Poi sceglieva lui le donne. A me purtroppo mi hanno tolto non solo la donna, il mio io, il mio essere, mi hanno tolto tutto, il modo con cui toccava.
Dovete pensare che quando si andava nel suo ambulatorio, era enorme. Quando ti metteva là, prendeva una ragazzina che non sapeva cosa vuol dire nemmeno il ginecologo, quelle cose lì, ti metteva là, lui si sedeva davanti e guardava. Io penso che, porca miseria, a me sembra che le donne siano fatte tutte uguali più o meno. Non so che cosa guardava.
Prendeva una ragazzina di quindici anni per vedere la differenza, la grandezza forse di quella di quindici e di quella di venti. Poi un’altra cosa schifosa anche. Quando eravamo nude, non sempre, ogni quel tanto tempo, io non so cosa gli serviva, la temperatura corporea. Ci facevano piegare nude, c’erano le donne addette e c’infilavano di dietro un termometro. Non il termometro con cui si misura la febbre, era molto più grande.
Avevano un modo per infilarlo, zum zum. Lo toglievano ad una e lo infilavano all’altra e via così. Queste erano le cose schifose, brutte che è difficile far capire alla gente raccontando queste cose.
Non solo io, tutta la baracca, tutte le donne che erano lì di tutte le età. Un altro fatto a Birkenau. Un giorno è venuto lì Mengele e ha scelto una ragazzina di Gorizia, si chiamava Gabriella, mentre eravamo in fila, non eravamo nude, eravamo vestite, è venuto lì, ha guardato in giro, questa no, questa no, ha scelto questa ragazza.
Era insieme a sua zia. La zia ha detto: “No, no, non lei”, gridava questa donna perché avevamo scoperto che a Birkenau c’era la casa delle bambole. Si sapeva che sceglievano le ragazzine vergini di quindici, sedici anni e le portavano in questa baracca che serviva per i loro piaceri.
Ha preso tante di quelle botte quella donna, tante di quelle botte quel giorno. L’hanno portata via la mattina, è ritornata alla sera. Siamo andate vicino a chiederle, pianino, non si poteva parlare durante la notte. “Cosa ti è successo? Cosa ti hanno fatto?” Lei tutta vergognosa ha detto: “Mi hanno fatto un’iniezione là”. Puoi immaginare a quei tempi, una ragazzina di quindici/sedici anni.
Poi finito così. Soltanto che noi con i mesi che passavano si dimagriva, si diventava così. C’erano tre ragazze, una di Firenze, si chiamava Wanda, una di Venezia, poi un’altra milanese anche. Loro dicevano, perché si era, non credo ormai disperate, non si ragionava, non penso alla disperazione, chi era disperata andava nel filo spinato.
Invece noi eravamo ridotte che non eravamo nemmeno disperate, eravamo lì e basta. E’ un po’ difficile spiegare come ci si sentiva, pensando anche adesso, una nullità realmente, completa, noi eravamo una nullità anche dentro di noi.
Queste che avevano un venticinque e più anni, anche trenta credo quella di Venezia, andavano fuori quando erano nude, ragazze, “Cosa vi disperate, siamo ritornate delle ragazzine”, dicevano.
Soltanto questa Gabriella abbiamo scoperto che i suoi seni, i nostri invece erano spariti, i suoi si arrotondavano. Poi è stata scelta anche lei tra le cinquemila, dopo l’esperimento ci hanno detto che dovevamo partire per un altro trasporto, per un altro posto di lavoro.
A questi ingegneri occorrevano cinquemila pezzi. Noi eravamo diventati dei pezzi, non eravamo più né dei numeri, né delle persone. Eravamo dei pezzi e basta. Siamo il 2 gennaio, siamo partiti alla volta di Buchenwald.
Anche lì abbiamo fatto un po’ a piedi fra i boschi della Polonia finché abbiamo trovato un binario morto dove c’era il carro bestiame, ci hanno fatto salire su questi carri bestiame e siamo partiti verso la Germania, chiamiamola così.
Dopo sei giorni abbiamo incontrato una stazione che si chiamava Dresda. Abbiamo detto, allora siamo in Germania. Poi siamo finalmente arrivati… Poichè bombardavano hanno deviato un po’ i treni. Siamo arrivati a Buchenwald. Veramente siamo arrivate a Weimar, nella stazione di Weimar, nello scalo merci di Weimar, passando col treno abbiamo letto Weimar.
Ci hanno fatto scendere allo scalo merci di Weimar, ci hanno incolonnate per cinque. Lì mi hanno dato un paio di zoccoli da infilare finalmente, zoccoli che erano chiusi, non aperti e mi hanno dato quelli più piccoli. Mi hanno fatto infilare col tedesco vicino, nazista, che dovevo infilare questi zoccoli.
Infatti ho messo dentro i piedi. Se io non avessi avuto due mie compagne che mi hanno trascinata su, perché andando a Buchenwald c’era una salita, adesso c’è la strada asfaltata, ma quella volta non c’era la strada asfaltata. Quelle che non riuscivano a fare la salita, c’era il fosso, un colpo di pistola e finito.
Così non so in quante siamo arrivate lassù a Buchenwald. Io so soltanto di essere entrata una volta sola per il cancello normale di Buchenwald e di aver trovato un albero, di averlo abbracciato che è ancora là secco nel mezzo.
Ho detto: “Oddio”, quando sono ritornata dopo un dieci/dodici anni, ho trovato il mio albero. “Che tuo albero?” diceva la gente che era insieme a me.
Ci hanno portato in fondo a Buchenwald. Lì l’indomani siamo andati, la sveglia sempre la solita, sempre i soliti Kapò, sempre le solite Stubowe,Blockowe. Sempre la sveglia alle quattro. Dopo due giorni ci hanno detto che eravamo pronte per andare a un altro lavoro.
Siamo uscite, fatta la scelta, ci siamo trovate… Perché sulla scalinata a Birkenau quando siamo scese non eravamo più in cinquemila, però alla partenza ci siamo trovate sempre in cinquemila. A Buchenwald però non so in quante siamo arrivate. Siamo morte un po’ camminando, un po’ sulla salita.
Ci siamo alzate. Hanno fatto i comandi, unite tante persone scelte. Poi ci hanno portato, fatto scendere in un sentiero da Buchenwald giù a basso, ci hanno fatto salire su un camion, ci hanno portato… Non so quanta strada, quanti chilometri distante. Mi ricordo di essere arrivata in questo posto che c’era una gran scalinata dove si scendeva, poi c’era la galleria.
Un ricordo che non dimenticherò mai. Eravamo nella galleria a Dora dove facevano la V2. Dice qualcuno che non hanno visto le donne, però ci sono dei signori invece che ci vedevano ogni giorno entrare.
Io mi ricordo a Dora che nell’entrata della nostra galleria davanti c’era una grande bomba, enorme, a noi sembrava enorme enorme, era grande, immensa, nera con una fascia rossa sotto.
Ci hanno fatte entrare in questa galleria, noi donne eravamo addette alle cariche. Si lavorava negli esplosivi, nel tritolo, balestrite, tutte queste cose. C’era come una specie di mulino, veniva macinata e mischiata la miscela di esplosivi.
C’era una qualità che bruciava anche le mani. Eravamo diventate tutte gialle. Ci facevano delle iniezioni ai seni. Si era lì nude completamente, loro passavano, avevano talmente ormai la praticità, passavano di corsa a fare queste iniezioni. Non so in cosa consistevano, per il fatto che eravamo diventate gialle forse.
Non era cambiato. Era cambiato qualcosa per noi che a Buchenwald abbiamo ricominciato a riprendere la vita, a cercare di sopravvivere Lì si capiva che si doveva lottare per sopravvivere. Poiché la domenica gli ingegneri non lavoravano, abbiamo riscoperto la domenica, si rimaneva in baracca.
Si poteva parlare. Quante cose ci siamo raccontate, quante ricette abbiamo scritto solo col cervello. Io quando vado a casa faccio così, quando vado io, allora eravamo di tutte le nazioni e di tutte le regioni del nord: Milano, Torino, ognuna aveva le sue ricette.
Lì ci si scambiava solo idealmente, solo si parlava. Forse questo ci ha aiutato molto anche per il ritorno. In più ci ha aiutato molto schivare tutte le punizioni possibili. Si cercava sempre di schivare ogni cosa.
Quando siamo andati a Kamnitz, abbiamo lavorato due mesi lì, facevamo pezzi di aerei, prima di arrivare a Buchenwald. C’è stato il bombardamento, allora ci hanno riportato un po’ in blocco. Un po’ ne hanno scelte, siamo andate a sbucciare patate, a pelare, non a sbucciare, a pelare, perché la buccia si poteva mangiare, invece pelarle era solo grattarle.
Eravamo lì che si parlava fra noi, ci siamo girate, abbiamo visto in vetro dei filoni di pane, non il nostro, un’altra qualità di pane. Come faremo? Lì si parlava di questo pane che era là. Ci sembrava già di mangiarlo, di averlo mangiato.
Lì abbiamo avuto la fortuna grande che c’era uno di Milano che si chiamava Marcello, un bellissimo ragazzo, non so di cognome, mi ricordo solo il nome, so che era un bel ragazzo, era un militare italiano. C’era quella di Firenze la Wanda. C’era solo una tedesca con noi di guardia. Ha fatto in modo di portarsela via. Si vede che sapeva il tedesco. Quando lei è ritornata era talmente svampita, talmente sognante, ha fatto un lavoro formidabile il nostro italiano, è stato bravissimo e noi abbiamo preso il pane, l’abbiamo nascosto sotto un braccio.
Quella sera quando siamo entrate in blocco si doveva alzare le braccia, ne abbiamo alzato uno solo. Non so com’è stato che ci siamo passate. Abbiamo mangiato tutta la notte. Ognuno un pezzo per ciascuno, si sono buttate su di noi quando hanno visto questi filoni di pane lì.
L’indomani sono venuti a cercare il pane. In una notte. Venire a cercare il pane l’indomani mattina? Abbiamo goduto noi quella notte, mamma mia. Non abbiamo fatto la spia.
“Guardate che avete mangiato quel pane. Il pane serve per i tedeschi, era per i nazisti, per i comandanti”, ci hanno detto. Nessuna ha parlato perché ognuno ha avuto il suo pezzo. Loro sapevano quelle che eravamo, ma loro dovevano punire tutte assieme.
Sono venuti a cercarci, hanno rovesciato i letti, non hanno trovato nemmeno le briciole. L’indomani mattina hanno cercato il pane. Non l’hanno trovato, ci hanno detto che se avessimo raccontato non ci avrebbero fatto niente, ci dicevano che dovevamo avvertire perché ci sarebbe venuta la dissenteria per aver mangiato questo pane.
Invece è successo che quelle che avevano la dissenteria sono guarite avendo mangiato questo pane. E’ successo che è venuta punita questa tedesca, cosa strana. Non so cos’è scattato. Noi ci abbiamo goduto se è stata punita questa tedesca. Realmente.
Un’altra cosa a Buchenwald. Abbiamo cantato. A noi è sembrata festa. Non abbiamo capito a cosa si andava incontro. In fila ci hanno fatto scendere da Buchenwald, ci hanno portato all’ospedale a Weimar a fare i raggi.
Mentre si passava, abbiamo attraversato il centro di Weimar. La gente ci sputava vedendo queste donne sporche, rasate, ci hanno fatto uguale a Buchenwald come ci hanno fatto ad Auschwitz, c’erano sempre i soliti dottori, altri dottori, altri nomi, però sempre le solite visite schifose, sempre le solite cose.
Noi quel giorno che siamo andate a fare i raggi abbiamo cantato per la strada per il fatto che non abbiamo lavorato. Questo fatto è stato bellissimo per noi. Per forza che i tedeschi uscivano nella città di Weimar a guardare chi era che cantava. Come si faceva a cantare? Non ci si rendeva conto che facendo i raggi si poteva… non abbiamo mai pensato di essere ammalate, assolutamente. Nemmeno l’idea lontanamente di ammalarsi. Nemmeno quando eravamo tutte gialle, non si pensava che si fosse malate, ci sembrava che era normale essere così. Questo è il fatto. Giusto per ritornare a quando ero al Revier, quando sono stata dimessa dal Revier, passando per uscire sono passata davanti a un bagno.
Dio, c’era un bagno. Ho guardato così mentre passavo, ho visto una persona nello specchio. Quando sono rientrata in baracca ho detto: “Dio, ragazze, che brutta donna che ho visto. Ho visto una ragazza talmente brutta”. E una signora: “Ti sei mai guardata allo specchio? Dove lo hai per guardarti?”.
Ero io quella che ho detto che era brutta. Dopo ritornando a Birkenau dopo tre mesi, tanto quella che aveva sessanta anni e quella che ne aveva venti eravamo tutte uguali. Una cosa a Birkenau, ritornando indietro a Birkenau, quando veniva gridata: “Oggi selezione, oggi selezione”, le donne, quelle che avevano una certa età o per la paura anche i capelli diventavano bianchi prima del tempo prendevano del fango e se lo davano su nella testa.
Quando si passava nude davanti, nel viso anche, quando si passava davanti al tavolo dei dottori molte riuscivano a passare senza venire scartate, perché purtroppo chi veniva scartato si sapeva dove si andava direttamente, ormai non era un mistero per noi. Poi un’altra cosa a Birkenau che non ho detto prima che mi è rimasta molto nella memoria. C’era una ragazzina a dormire sopra di me che avrà avuto quindici o sedici anni, era di Firenze, non lo so come si chiamava. So quello soltanto. Anche quella signora, Wanda, che era di Firenze non la conosceva, però sapeva che era di Firenze, l’ha detto lei che era di Firenze. Cantava, aveva composto una piccola canzone su “Dorme Auschwitz” e la cantava sull’aria di “Dorme Firenze”. Diceva: “Dorme Auschwitz sotto un cielo di cenere, dorme Auschwitz, si vedono tante fiammelle. Sono le anime dei bambini che escono per i camini. Dorme Auschwitz, non si vedono le stelle, soltanto cenere”. Poi ci sono altre parole, ma non mi ricordo. Solo la prima strofa mi è rimasta un po’ in testa. Anche la canzone “Mamma”, la Vittoria Gargianti la sa tutta lei, se la ricorda tutta. Io mi ricordo un pezzo, ma soltanto… Ad Auschwitz c’era l’orchestra delle donne, c’è lo spiazzo ancora dove suonavano, dove tenevano i concerti. Quest’orchestra ci accompagnava sempre nel lavoro, nel rientro e quando si usciva, uguale, sempre. In più se avveniva un’impiccagione era accompagnata dall’orchestra sempre. C’erano donne che suonavano, c’era una baracca dove andavano a fare le prove anche per loro. Di fatti stavano un pochettino meglio, non andavano al lavoro, non erano nel freddo e non avevano il vestito zebrato. Quelle che venivano scelte nel gruppo, chiedevano se sapevano suonare e andavano in questa baracca a fare le prove. Loro gli davano gli strumenti e suonavano sempre, anche per loro dopo, anche per i nazisti. Dovete sapere che la Kapò non dormiva mai nella nostra baracca, c’era la Stubowa, la Blockowa non dormiva mai.
C’era la Stubowe, le Kapò andavano a fare la bella vita. C’erano due di guardia, erano di una cattiveria incredibile, veramente.
D: E questa ragazzina di Firenze?
R: No, è rimasta ad Auschwitz. Allora ritornando a Buchenwald, mentre un giorno eravamo in galleria che si stava lavorando, perché la galleria era lunga non so quanti chilometri, mi avevano detto quanti gli uomini, adesso… Ma c’erano tante deviazioni. C’erano dei reparti, i laboratori c’erano in queste gallerie. Un giorno lì nel nostro laboratorio dove eravamo noi le è preso male a questa ragazzina di Gorizia, questa Gabriella, che ho detto che si arrotondava i seni, così. Era arrotondata anche lei. L’hanno portata via, le è venuta un’emorragia, l’hanno portata via. Dopo quattro giorni è ritornata, la ragazzina ha detto: “Mi hanno operata”. Dopo ha avuto la forza di ritornare, però abbiamo saputo che le avevano fatto la totale. Questa sperimentazione della fecondazione artificiale credo che l’abbiano messa insieme il dottor Mengele e tutta la sua equipe. Non era perfetta come è adesso, ben si intende, però credo che sia partita da lì e che veramente gli esperimenti siano stati fatti a Birkenau.
D: Eleonora chi era?
R: Eleonora era una ragazza, una sposina di Cormons, in provincia di Gorizia. Adesso vive a Belgrado. Lei quando è salita sul nostro trasporto era incinta. A Birkenau ha partorito durante una notte, dopo tre mesi che eravamo lì. Lì è stata coperta un po’, le grida, le urla, questo bimbetto che era nato lì. Si vede che l’indomani mattina la cosa… O la Kapò o la Blockowa, è stata avvertita. So che è arrivato il dottor Mengele e ha dato l’ordine di non allattarlo. Ma io non lo so dove il latte sarà stato dopo tre mesi che eravamo già lì. Noi abbiamo detto: “Se non hai il latte tu, noi metteremo un po’ di pane bagnato”. Ci avevano già tolto un po’ le cose proprio essenziali, come fa a vivere un bambino col pane bagnato in quell’acqua marrone che c’era? Dopo quattro giorni credo che un pulcino pigolasse molto più forte di quel bimbino . Mi ricordo qui una cosa, che si dormiva in otto, come ho detto prima, si cercava di lasciare il posto a lei col bambino sopra sulla pancia. L’avevano avvolto in una specie di coperta color nocciola, non lo so dov’è che è stata trovato questo pezzo di coperta. L’aveva avvolto lì questo bambino. Durante la notte sul quarto giorno, andando al quinto, è arrivata una dottoressa polacca, per forza doveva lavorare là. E’ venuta lì e ha detto il nome finalmente, perché dovevamo dimenticare anche i nomi. Difatti eravamo ridotte a chiamarci per numero, realmente. O 53 o 52, secondo il numero, non i primi due, 88.000, si chiamavano i due ultimi. Ci si capiva. E’ stata chiamata Eleonora, “Bisogna sopprimere il bambino”. Ci siamo un po’ rivoltate tutte, anche quelle nobili che dormivano sotto di noi, realmente sono saltate su, parlando austriaco, tedesco dicevano: “Far morire un bambino?”. Lei ha detto: “Queste cose le faccio per salvare la madre, perché domani mattina verrà il dottor Mengele e porterà via la madre e il bambino”. Allora lei ha messo una mano sopra e un minuto dopo il bambino non piangeva più. Lo ha preso, lo ha portato nello stanzino dove si mettevano le donne che morivano di notte. C’era uno stanzino in fondo alla baracca apposta in cui si mettevano le morte. Quel giorno nell’insieme abbiamo avuto una fortuna che il carretto della morte è arrivato molto prima, il bambino è stato caricato. Il dottor Mengele e la sua equipe sono arrivati dopo l’appello. Essendo arrivato dopo l’appello la dottoressa ha detto che il bambino era morto, e che era stato portato nel mucchio dei morti. Sapete che è andato a cercarlo tra quelle due o tre che erano morte dopo morto il bambino, è andato a vedere se c’era lì. Questa Eleonora ha avuto la forza, è ritornata, il figlio forse se lo sarà ricordato dopo, quando è ritornata forse. Non l’ho incontrata più perché essendo sposata con uno sloveno è andata a vivere là e non ci siamo più incontrate. Non lo so se è viva ancora, so che era andata là sposa a Belgrado. Dopo non lo so.
D: Elvia, la liberazione, dov’eri tu alla liberazione?
R: Alla liberazione? Dice qualcuno che hanno gridato di gioia, così, anche nei film che vedo si vede così. Io non posso dire… Non ho avuto il tempo di godermela. Perché? Perché quel giorno, il 7 maggio, che era già finita, ci hanno portato in galleria. In galleria eravamo tutti, uomini, tutti. Questo perché la loro idea era di far saltare la galleria, è questo il fatto. Se non che si vede che il fronte è avanzato molto prima della preparazione per fare queste cose. Mi ricordo che è entrato un altro gruppo di uomini, lì abbiamo avuto molto aiuto dai militari italiani.Poi le cose che si facevano per loro erano tutte sabotaggio, se mentre eri all’appello ti scappava la pipì, poiché per farla c’erano gli orari, c’era la mattina e basta per andare ai bagni, Se facevi la pipì magari lì, perché non si avevano né mutande né niente, era sabotaggio. Prendevi tante di quelle botte, prendevi dalle dodici alle venticinque frustate anche. Chi le prendeva? Io non le ho prese queste, io ho preso solo le tre legnate della Kapò, però chi le prendeva doveva anche contarle. C’era un seggiolino, le piegavano e le davano giù lì.
Poi se ci sono le russe, mettiamo quelle due che hanno cercato di fuggire a Buchenwald… Perché noi avevamo un momento quando si scendeva dal camion, sulla strada in cui ci mettevano c’era un ponte che si doveva attraversare. Non so se c’era un fiume perché durante la notte e il giorno non si aveva tempo di guardare. C’era un momento che ci si mischiava con le persone civili e queste russe devono aver fatto amicizia con delle russe lavoratrici che erano prese dalla Russia e portate a lavorare. Hanno tentato la fuga. Dopo tre giorni le hanno riprese, le hanno portate in blocco. Quando siamo ritornate dal lavoro le abbiamo trovate lì, distese per terra che le avevano bastonate, si può, all’infinito. Noi eravamo lì in piedi in fila, e il comandante ha camminato sopra. Non so il comandante di Buchenwald come si chiamasse. Ha camminato con gli stivali sopra queste due ragazze. Erano due sorelle. Le hanno prese. Dentro nella baracca c’era un Bunker, una botola in cemento armato con una porticina più un buco rotondo. Le hanno prese e le hanno messe lì dentro con l’ordine a noi di non andare a guardare né niente. Una cosa strana, fra tutte le nazionalità che eravamo, noi italiane avevamo legato con le russe, non lo so come mai c’era questo legame fra noi. Dovete pensare, mettiamo, io sono di Udine e quelle sono di Gorizia, siamo a venticinque chilometri di distanza, ma parlavano sloveno e loro si spacciavano per slovene, non si sentivano più italiane. Non si riusciva ad andare d’accordo.
Pensandoci anche adesso ci si chiede il perché di questa cosa, che abbiamo legato con queste russe. Allora a turno si montava di guardia in modo che le Kapò o le comandanti non ci vedessero. Noi si toglieva un pezzettino del nostro pane, si bagnava nell’acqua e si buttava dentro per questo buchetto. Dopo sei giorni hanno aperto il Bunker e hanno tirato fuori una viva. Io dopo cinquant’anni l’ho rincontrata questa russa a Mosca. Lei mi ha riconosciuta, io non l’ho riconosciuta, perché poi abbiamo seguito tutta la trafila insieme fino alla liberazione. Per ritornare e raccontare il giorno della liberazione…. Per noi è venuto dentro questo con un Ape che si guidava allora, quella volta, in piedi gridando: “I russi alle porte, i russi alle porte!”. Perché c’era il corridoio della galleria enorme. Noi non c’eravamo nemmeno messe al lavoro, si diceva: “Non c’è nessuno qui”, non hanno acceso il motore del mulino. Piano piano sentendo questo siamo uscite, ci siamo trovate in un grande spiazzo e c’erano… Allora quando si era in baracca si diceva sempre: “Quando andrò a casa, mi toccherà incominciare a mangiare col cucchiaino, non si potrà mangiare tanto perché il nostro stomaco si è ristretto”. Questi erano i discorsi quando eravamo su in baracca. Ma al momento che eravamo fuori e abbiamo visto le case dei comandanti cosa si è fatto? All’assalto alle case a cercare da mangiare, non si è ragionato più. Lì si aprivano tutti i sacchi, si assaggiava cos’era. Questo l’ho trovato io, sono stata molto brava. Io ho aperto, era di carta questo sacco, sono arrivata a strapparlo e ho assaggiato questa polvere, era color verdolino. Ho assaggiato, mamma mia, sapeva di fagiolo. “Sono fagioli macinati”, tutte queste ragazze che non ci siamo contate mai dopo, ci siamo buttate sopra. Lì abbiamo acceso dei fuochi in queste gamelle che avevamo, ognuno faceva la crema. “Che buono, che buono, mamma mia, che buono”. Quando abbiamo finito di mangiare tutto abbiamo scoperto che era colla. E adesso? Cosa facciamo? Ci ha fatto bene, ci sentivamo sazie, se anche era colla noi abbiamo pensato: “Ci ha fatto bene”. Adesso da che parte si va? Dove si va adesso? Dove siamo? Non si sapeva dove si era, non si vedeva dove si andava. Abbiamo cominciato a ragionarci sopra, abbiamo detto: “La strada sarà sempre in alto, mai sotto, perché qui è la collina, le strade sono sopra. Non possono essere qui dove hanno fatto le gallerie. Se venivano coi camion e con le macchine…”. Abbiamo attraversato questo bosco e difatti fuori da questo bosco sempre in salita abbiamo trovato la strada. Non ci si rendeva conto che le Katiusce sparavano sopra le nostre teste, non si sentiva. Si sentiva di andare, finito. Quando siamo arrivate in questa strada abbiamo trovato dei furgoncini rovesciati nei fossi. Via a cercare anche quello che c’è lì. Lì abbiamo trovato dei maiali già puliti, già tagliati, dei pezzi di lardo. Io non lo so se avete visto i leoni nei deserti quando prendono la preda, così è stato per noi. Tutti assieme, tutto un mucchio, lì eravamo di tutte le razze, eravamo tutte sorelle.
Coi denti si strappava. Questo purtroppo ci ha salvato, questo lardo ci ha salvato. Poi abbiamo detto: “Da che parte andiamo?”, le russe e le polacche hanno detto: “Noi andiamo verso dove sparano che là ci sono i russi”. “Noi andiamo giù di qua. Dove andiamo da questa parte? Si andrà in Italia, noi italiane”.
Anche le altre, le greche, quelle delle altre nazioni, anche le ungheresi ci avevano detto: “Andiamo da questa parte, si andrà in Ungheria”. Difatti loro indovinavano giusto, ma noi italiane si andrà in Italia di qua, loro vanno dalla parte dei russi. La Russia è la via, si diceva, vieni da quella parte.
Ci siamo incamminate e siamo arrivate in una cittadina chiamata Erfurt. Lì ci hanno visto arrivare, queste donne in quelle condizioni che eravamo, si camminava ormai che si trascinavano così i piedi, non si camminava normalmente. Ci hanno detto che stavano arrivando i russi, ci hanno fatto capire che ci avrebbero ucciso tutte.
Allora noi che eravamo rimaste ci siamo riunite anche se non ci si capiva, anche quel piccolo gruppo di italiane. Abbiamo detto: “Andiamo là dove mettono il fieno ad asciugare, andiamo a dormire in un fienile, vediamo domani”, perché erano già venute le sette di sera ormai.
Quando ci siamo avviate nei campi finalmente vediamo arrivare due carri armati con la stella rossa che era l’Armata Rossa. Sono scesi, mi ricordo che c’erano un capitano e un colonnello. Il capitano russo parlava l’italiano.
Prima ci hanno chiesto nella loro lingua di che nazioni fossimo, chi eravamo. Noi abbiamo detto, il nostro gruppetto di poche italiane che eravamo, abbiamo detto: “Siamo italiane”. Allora è sceso questo capitano, parlava l’italiano e ha detto di ritornare a Erfurt che là c’era la truppa che ci avrebbe dato di cui mangiare, lavarci, vestirci.
Difatti siamo ritornate indietro e lì ci hanno separate, le italiane da una parte, le greche, le cecoslovacche… Ci hanno messe in tante case sequestrate che avevano loro, ci hanno messo lì.
Non saprei nemmeno oggi come oggi dire cos’è stata la liberazione per me, non è che abbiamo alzato le braccia, niente. Perché abbiamo dovuto lottare ancora, perché poi si viveva sempre quei quattro o cinque giorni che siamo rimaste lì… Perché?
Perché ogni giorno di mattina presto eravamo talmente ormai abituate ad alzarci a quell’ora, si era sempre in strada. A ogni gruppo che passava si chiedeva: “Sei italiano? Sei italiana?”, alle donne e agli uomini. Erano già quattro giorni, cinque che eravamo lì.
Un giorno è arrivato un gruppo e ci hanno detto che erano italiani, mamma. Forse lì abbiamo conosciuto un po’, non nel senso di essere liberati, no, di avere trovato delle persone che erano uguali a noi, italiane insomma. Non per razza, perché hanno detto che erano italiani.
Forse questo nome ci ha dato… Allora hanno detto: “Dove andate?”. “Andiamo in Italia”, abbiamo detto. “Unitevi a noi che andiamo”. Erano un gruppo di ragazzi, c’era il corridore Monti anche.
Hanno detto: “Unitevi a noi che andiamo verso l’Italia”. Invece viene lì vicino un colonnello russo che aveva visto un po’ di gente raggrumata lì, c’erano anche altre prigioniere che chiedevano, è venuto, ha detto: “No, voi lasciate le biciclette qui, vi diamo un carro e un cavallo e tutti i viveri. Andate sempre dritti per questa strada fin quando arrivate a Praga, dovete arrivare a Praga” ci ha detto.
Ci siamo incamminati, abbiamo dormito all’albergo delle stelle, abbiamo camminato per altri cinque o sei giorni. Mi ricordo di essere arrivata entrando dalla Germania a Praga, mi ricordo di essere arrivata sul ponte di San Stanislao e poi di essere caduta lì. Poi non mi ricordo nulla per due o tre mesi, li ho persi completamente, cancellati completamente.
D: Però lì sul ponte a Praga cos’è successo?
R: E’ successo che mentre io ero caduta e avevo perso i sensi passava il Console italiano, sua moglie e una contessa cecoslovacca che faceva la crocerossina, andavano in cerca di queste persone coi vestiti zebrati.
Lei è scesa dalla macchina: “Fermati” ha detto “che c’è una ragazzina per terra”. “E’ viva ancora, questa non è morta”. Mi hanno caricata in macchina, mi hanno portato alla Casa d’Italia.
Dopo due mesi, tre che ero lì mi ricordo di essermi svegliata e quando ho guardato ho visto un viso talmente bello, talmente sorridente, come una visione. Ho detto: “Oddio, sarò in paradiso, questo è un angelo”.
Mi hanno raccontato che ho avuto il tifo, che ho avuto la malaria, poi mi è ritornata la malaria, che pesavo 25 chili, che mi hanno pesata in un lenzuolo, mi hanno legata e messa nel lenzuolo che ridevano tutti quando mi hanno pesata.
Lei non mi ha abbandonato né giorno né notte, mai mai mai. Allora si vede che avevo la febbre talmente alta, lei bagnava le lenzuola, mi avvolgeva dentro nell’acqua fredda perché ghiaccio dove? Avendo il figlio dottore forse ha…
In più mi ha curato la pelle della schiena, perché con gli esperimenti che mi ha fatto il dottor Mengele la mia pelle era come un cartoccio di carta, quella carta di una volta. I pidocchi difatti non stavano vicino a me assolutamente, perché se ti trovavano un pidocchio c’era anche la punizione.
Tanti parlano che erano mangiati dai pidocchi, dalle cimici. Non solo io, il nostro gruppo non aveva queste bestie, realmente non le abbiamo mai avute. Anzi, c’era una punizione.
D: Dopo questi tre mesi di Praga cos’è successo?
R: E’ arrivato un altro gruppo di italiani e hanno detto: “Dove andate?”. “Andiamo in Italia coi camion, andremo in Italia. C’è un treno che parte dalla stazione di Praga che va verso l’Italia”.
Invece siamo partiti coi camion, abbiamo attraversato un ponte di barche che avevano fatto i russi perché i ponti erano distrutti e ci hanno bloccati a Bratislava. A Bratislava ci siamo trovati in una caserma militare, eravamo in 17.000 persone italiane tra donne, bambini e militari, ufficiali.
Erano tutti ufficiali italiani che erano prigionieri del ’43. Quelle donne e quei bambini non erano prigionieri, loro erano delle persone che erano andate emigranti in Germania. Si sono trovati nel giro di tutte queste cose. Lì siamo stati altri tre mesi, fino al mese di ottobre.
I russi, io devo dire solo bene di loro, ci hanno dato i generi alimentari che ci si doveva fare da mangiare da soli, sbrigarsi da soli. C’era l’ordine però, si viveva come in caserma, uguale. Non c’era il permesso di uscire, perché si potevano fare dei brutti incontri, perché si ubriacavano come tutti, come gli americani, come gli inglesi e tutti, anche i russi uguale agli altri.
Allora poteva succedere, cercavano di evitare queste cose. Siamo stati fino al 30 ottobre. Un giorno è arrivato mentre eravamo lì il generale da Vienna russo, è entrato lì. Ci hanno fatto schierare gli ufficiali, i nostri italiani bravissimi, lui ha camminato in mezzo, è andato fino in fondo, si è girato.
“Italiani fascisti” ci ha detto. Me lo ricorderò sempre per il modo in cui l’ha detto. “Questa volta”, ha detto, “vi abbiamo perdonato. Se per caso ritornate in guerra un’altra volta non vivrà nessuno”. Ma in un modo ce l’ha detto, veramente.
Poi un’altra cosa: “Io non posso mantenervi più, perché non siete soltanto voi”, ha detto, “non siete solo voi 17.000. Ne ho altre migliaia a cui dare da mangiare, da vivere. Se entro tre giorni l’Italia o qualcuno non viene a cercarvi… Impossibile che in Italia non ci sia nessuno che non sappia che mancano 17.000 persone, non è una”, ha detto.
Ricordo realmente, era proprio anche un po’ incavolato questo generale. Ha detto: “Mi dispiace, se entro i tre giorni non viene nessuno a chiedervi, sono costretto a mandarvi via a Odessa”. Gli ufficiali, i militari che erano tanti anni ormai che erano lì hanno detto: “Ci mandano in Russia, se andiamo via a Odessa andiamo in Russia e non ritorniamo più”.
Invece alla quarta giornata la mattina presto abbiamo visto dei camion inglesi arrivare. Su quei camion chi c’era? C’erano gli inglesi, ma chi c’era a cercarci? C’erano i frati di Padova. In ogni camion c’era un frate, erano i frati di Padova che cercavano i deportati in giro. Non lo so come abbiano scoperto, o i russi hanno fatto sapere agli inglesi, hanno trasmesso così.
L’indomani siamo partiti finalmente con questi, ci hanno caricati nei camion abbastanza, eravamo un po’ strettini, ma il fatto di andare a casa… Invece ci hanno fermato a Vienna Noistar.
Io l’impatto l’ho avuto brutto con gli inglesi, non per me, un po’ per tutti. Abbiamo detto: “Siamo ritornati indietro”, perché ci hanno accolto in questo campo di smistamento a Vienna Noistar, a quaranta chilometri venendo sempre dalla Cecoslovacchia prima di Vienna.
Ci hanno accolti come degli appestati, ci hanno disinfettati con del flit, con delle cose che bruciavano. Siamo stati due giorni lì, poi siamo partiti finalmente. Ci hanno messi su una tradotta e siamo partiti finalmente verso l’Italia.
Mi ricordo che quando abbiamo attraversato il Brennero la gente, gli ufficiali più di tutti, sono scesi e hanno baciato il suolo italiano. Siamo arrivati a Pescantina e lì c’erano i frati di Padova ad aspettarci, c’era un campo con delle tende. Lì ci hanno dato i viveri.
Ho dormito lì, l’indomani ci hanno chiamati e hanno detto: “Guarda, c’è un treno che parte alla volta di Udine. Non so quando arriverete a Udine”. Io so di essere partita sola, perché dopo quindici mesi che ero via ci hanno arrestati assieme, una mia compagna del mio paese, siamo andate ad Auschwitz insieme, poi ci siamo perse ad Auschwitz.
Poi non l’ho vista più, l’ho incontrata a Pescantina dopo quindici mesi. Ha detto: “Elvia, andiamo a Udine, andiamo a Udine, andiamo a casa dalla mamma”. “Aspetta”, ha detto, perché lei era ritornata con un altro gruppo di italiani, “che vado a salutare quegli amici che mi hanno aiutata”, perché lei è stata liberata a Melk. “Vado a salutare”.
Il treno è partito e io sono andata, per la fretta di andare a casa non l’ho aspettata. A Udine ci hanno accolto tanto bene, mamma mia, l’impatto, il ritorno in Italia, in patria, mamma mia, il tuo paese, favoloso, da piangere anche oggi come oggi dopo cinquantacinque anni. E’ da piangere anche adesso.
Hanno detto che avevamo avuto un figlio coi tedeschi e lo abbiamo lasciato a Udine nell’orfanotrofio, non sapeva nessuno che noi siamo ritornate, dove eravamo, se eravamo vive o morte, però avevamo fatto un figlio. In più quando siamo arrivate le donne cosa ci hanno chiesto? “Vi hanno violentate?”.
Non come eravamo, già pesavo un trentacinque chili, per la mia altezza ero ancora magra. Non mi hanno detto… I capelli erano appena così, non erano ricresciuti in tre mesi, quattro della liberazione. No, queste cose.
Poi avevamo bisogno di cure ancora, di tante cose. No, niente, non si è fatto avanti nessuno, nessuno ci ha chiesto. E’ stato un professore che era amico del ragazzo che avevo che mi ha curato, mi ha fatto delle iniezioni, delle punture lombari per togliermi delle infezioni, delle cose così.
Avrà provato anche lui, non lo so, so che mi ha fatto delle iniezioni lombari contro la tubercolosi, perché quelli che sono ritornati prima di me erano tutti nei sanatori. Questo è il mio ritorno.
D: Quando sei ritornata?
R: Il 30 ottobre del ’45.
- scarica la testimonianza (80.53kb – PDF)
- » Bergamasco Elvia: testimonianza sonora (100′) (11617.25kb – MP3)